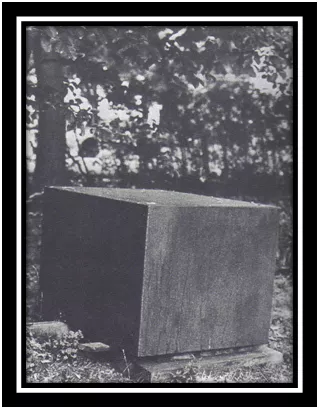Brian O’Doherty. Inside the White Cube
È uscito in libreria il libro di Brian O’Doherty, Inside the White Cube. L’ideologia dello spazio espositivo (traduzione italiana di I. Inserra e M. Mancini, Johan and Levi editore, Milano 2012, pp. 146, € 20). Il volume raccoglie e traduce per la prima volta in italiano i saggi pubblicati dall’artista irlandese sulla rivista Artforum a partire dal 1976.
Presentiamo qui il testo attraverso due contributi di Alessandra Sarchi e Riccardo Venturi e ne anticipiamo la postfazione.

Lo spazio dell’arte
“Una scena ricorrente dei film di fantascienza mostra la Terra che si allontana dall’astronave fino a diventare un orizzonte, un pallone, un pompelmo, una pallina da golf, una stella. Questo cambiamento di scala si accompagna a un passaggio dal particolare al generale. All’individuo si sostituisce la razza, rispetto al quale noi siamo un’inezia, un brulicare di bipedi mortali ammassati quaggiù come un tappeto steso per terra. Vista da una certa altezza, generalmente la gente appare buona. La distanza verticale favorisce questa generosità, mentre l’orizzontalità non sembra avere la stessa qualità morale. Le figure che si profilano in lontananza potrebbero avvicinarsi e noi prevediamo le incognite dell’incontro. La vita è orizzontale, un avvenimento dopo l’altro, un nastro trasportatore che ci trascina verso l’orizzonte. Ma la storia - la visione dall’astronave che si allontana - è diversa. Con il mutamento di scala gli strati di tempo si sovrappongono, e noi proiettiamo su di essi le prospettive che ci consentono di recuperare e correggere il passato. Non c’è da stupirsi se in questo processo l’arte si ritrovi messa parecchio male: la sua storia, percepita attraverso il tempo, è confusa dall’immagine che abbiamo di fronte, un testimone pronto cambiare la sua deposizione alla minima provocazione percettiva. Al centro della ‘costante’ che chiamiamo tradizione, la storia e lo sguardo vivono un profondo conflitto.”
Con un’apertura di respiro letteralmente cosmico Brian O’Doherty, nella raccolta di saggi usciti tra il 1976 e il 1981 su Artforum, e qui per la prima volta tradotti in Italia, introduce le sue originali riflessioni sulla centralità dello spazio. Da contenuto delle opere attentamente imbrigliato e sorvegliato nella prospettiva rinascimentale o esploso nella scenografia barocca, lo spazio si è dilatato nell’arte contemporanea fino a coincidere con il luogo fisico tout court (studio d’artista, installazione, museo, galleria). Brian O’Doherty ripercorre le tipologie diverse di un’unica vicenda, quella che porta alla definizione modernista dello spazio bianco e ipertecnologico delle gallerie espositive, dove i legami effimeri di temporalità e località vengono aboliti a favore di un’idea platonica di assolutezza che astrae dalla vita e si proietta nell’eternità.
Il white cube in cui ci siamo abituati a vedere l’arte contemporanea è prima di tutto un patto sociale, il frutto di una mediazione politica ed estetica escogitata dall’arte, dopo la caduta del mecenatismo dei secoli passati, per sopravvivere dentro un sistema di cultura di massa e di capitalismo.
“Oggi è impossibile allestire una mostra senza perlustrare la parete come un ispettore sanitario: bisogna tenere conto dell’estetica che inevitabilmente trasformerà in arte l’opera ... La maggior parte di noi ‘legge’ un allestimento come mastica chewing-gum: inconsapevolmente e per abitudine”.
Il bianco assoluto delle pareti, l’azzeramento di ogni elemento di connessione, percettiva o funzionale, con la realtà esterna, minimizzano la dimensione commerciale enfatizzando, viceversa, il richiamo sotteso ai luoghi di culto, chiese, piramidi o celle monacali. Paradossalmente il white cube ci assicura che ciò che stiamo osservando sfiderà i tempi, le mode, si rivelerà pertanto anche un buon investimento monetario.
Eppure la situazione che oggi appare uno standard consolidato e inscalfibile proprio perchè si innervata in un punto nevralgico del sistema artistico, ha una storia fatta di grandi deviazioni e tentativi di eversione che O’Doherty pone in magistrale gioco dialettico. Cos’hanno in comune lo studio ingolfato di oggetti - stracci, fogli, bidoni di vernici, pennelli, riviste, pezzi di mobili e molto altro ancora - di Francis Bacon, oggi ricostruito alla Hugh Lane Gallery di Dublino, e la stanza quasi monacale nella sua sobrietà - un tavolo, un divanetto, una sedia, un lucernario, con una tenda regolabile per filtrare la luce, di Mark Rotkho in East 68th Street a Manhattan?
E ancora: esiste qualche legame fra questi e l’ambiente raffigurato nell’Arte della Pittura di Vermeer che riproduce lo studio dell’artista nel 1672?

E infine, il punto di svolta non è ancora una volta Duchamp e la sua installazione Sixteen Miles of String (“First Papers of Surrealism”, New York 1942), quando isolando le opere con una ragnatela continua e ostacolante dichiarava quell’ostilità nei confronti dei visitatori che O’Doherty pone alla base del rapporto moderno fra artista e pubblico?
Se l’artista seicentesco Vermeer si mette in scena, di spalle, invitando a identificarsi con il suo sguardo, con il suo vedere, entro la rassicurante cornice del dipinto da cavalletto, all’interno di un microcosmo pieno di particolarità, per quanto veniamo sempre tenuti a debita distanza, Bacon e Rothko ci immettono nel pieno e nel vuoto della loro creazione, chiedendoci innanzitutto di essere spettatori del gesto, capaci di vivere il loro spazio a misura assoluta del mondo, anche se disagevole.
Duchamp, infine, ci dice esplicitamente che siamo all’interno di un rituale sociale: il pubblico rifiuta l’artista, questi si arrabbia, ciò “produce un’energia sufficiente per convincere tanto l’artista quanto il pubblico che ciascuno assolve al proprio ruolo sociale, poiché ciascuno rimane incredibilmente fedele alla concezione che l’altro ha del suo ruolo: ed è questo il legame più potente nell’ambito di un rapporto.”
Dentro al white cube perfungiamo un antico rito, l’opera è stata forse cannibalizzata, ma il sacrario rimane.
Merce fra le merci, l’arte, pur sempre espressione del particolare fenomenico, ha dovuto accaparrarsi fette ingombranti di valore assoluto; alla desacralizzazione del mondo ha risposto con la sacralizzazione di sé. La visione dall’astronave (la Storia) e il pullulare della vita vera sulla terra mai come oggi sembrano correre su binari divaricati.
Alessandra Sarchi
Non entrate nel cubo bianco
“Bisogna poter dimenticare il fatto che ci sono dei muri e allo scopo non abbiamo trovato niente di meglio che i quadri. I quadri cancellano i muri. Ma i muri uccidono i quadri”. Così è scritto in quello straordinario “diario di un utente dello spazio” che è Espèces d’espaces (1974) di George Perec. Forse non è altro che un calembour. O forse, sospetto, è il commento più incisivo sul white cube, lo spazio espositivo per le opere d’arte contemporanea affermatosi negli anni cinquanta negli Stati Uniti e, a seguire, nel resto dell’emisfero occidentale.
Due anni dopo il diario perechiano compare su “Artforum” un articolo che indaga la grammatica e l’ideologia del white cube. Ne seguono a breve altri due, raccolti nel 1986 in un libro presto diventato un classico, Inside the White Cube. L’ideologia dello spazio espositivo (appena tradotto per Johan & Levi da Irene Inserra e Marcella Mancini).
L’autore è Brian O’Doherty, pressoché sconosciuto nel nostro paese.
Laureato in medicina, è artista ma anche storico dell’arte americana del dopoguerra (ha scritto American Masters: the Voice and the Myth in Modern Art, 1974 su Hopper, Davis, Pollock, De Kooning, Rothko, Rauschenberg, Wyeth, Cornell, divenuto celebre per i ritratti fotografici di Hans Namuth). È professore universitario (prima a Berkeley su invito di Peter Selz e poi, dal 1970 al 1996, al Barnard College affiliato alla Columbia University), ma anche abile intervistatore per la trasmissione Invitation to Art promossa dal Museum of Fine Arts di Boston (1958-60), dove s’intrattiene con, tra gli altri, Hopper, Gropius, Chagall, Albers, Rauschenberg, Morton Feldman, Rothko ma anche Woody Allen e Cassius Clay.
È direttore di Art in America nei primi anni settanta, trasformando una rivista incline al gossip in un luogo di dibattito critico (il suo primo editoriale, nel maggio 1971, è sul postmodernismo), ma anche collaboratore dell’americana Visual Arts Program e, in seguito, del Media Arts Program: Film, Radio, Television del National Endowment for the Arts, dove promuove la video art. Senza dimenticare il fatto, riportato da Patricia Falguières nell’introduzione alla traduzione francese di Inside the White Cube, che fu O’Doherty a commissionare a Roland Barthes il celebre saggio sulla morte dell’autore nel 1967 per la rivista Aspen (“The Death of the Author” nel suo titolo originale).
Gli storici dell’arte hanno inoltre vita difficile nel districarsi tra i cinque pseudonimi di O’Doherty, rivelati solo nel 1998 in occasione della mostra Five Identities (alla Orchard Gallery di Derry): Sigmund Bode – che evoca Freud e Wilhelm von Bode, lo storico dell’arte e direttore dei musei di Berlino del XIX secolo – in quanto curatore della rivista Aspen; William Maginn, poeta irlandese del XIX secolo vicino a Thackeray e Coleridge; Mary Josephson, utilizzato per firmare gli articoli su Art in America; Patrick Ireland, adottato il 29 novembre 1972 davanti a un notaio durante una performance (Maze/Name Change, Projects Arts Centre di Dublino), in segno di protesta contro Bloody Sunday, il massacro dell’esercito britannico a Derry. Un’identità tenuta in vita fino al 20 maggio 2008 quando, in seguito agli accordi di pace in Irlanda del Nord, organizza il funerale di Patrick Ireland nei giardini dell’Irish Museum of Modern Art.

Il libro di O’Doherty resterà alla storia come uno spartiacque: prima della sua comparsa esistevano gli spazi dei musei e delle gallerie d’arte, dopo nient’altro che il white cube. Tuttavia il successo di Inside the White Cube ha finito per livellare la figura poliedrica del suo autore nonché il contenuto stesso del libro: il white cube? il cubo bianco della galleria! Si potrebbe obiettare che il white cube è ormai un arnese spuntato, utilizzato come modello espositivo al di là delle sue implicazioni ideologiche. Lo testimonia un museo-monstre che più di ogni altro si è sforzato di scardinare lo spazio purista degli angoli retti, ovvero il sinuoso Guggenheim di Bilbao progettato da Frank Gehry. È privo di una facciata classica che introduca il visitatore all’arte come in un tempio, è dominato da un’immensa hall d’ingresso cui solo le sculture ellittiche di Richard Serra riescono a tener testa. Non per questo ha rinunciato alla ripartizione delle sale espositive en enfilade proprie del white cube. Più radicali gli angoli ciechi, le impasse e le finestre-ferite tagliate nel corpo del Museo ebraico di Berlino progettato da Libenskind, al punto da generare accesi dibattiti sulla possibilità di esporre la struttura tale e quale – “il contesto come contenuto” direbbe O’Doherty – o di concepire un percorso museale che riannodi il filo di una narrazione, che renda l’esperienza degli spettatori meno traumatica.

Eppure, non è l’uso del white cube a fini pratici a renderlo meno ideologico; non è la sua affermazione istituzionale negli ultimi sessant’anni ad autorizzare qualsivoglia naïveté critica. Pensiamo a una sorta di fenomenologia del desk nelle gallerie d’arte contemporanea. Al loro ingresso troneggiavano una volta scrivanie da ufficio che facevano dello spazio un misto tra un museo pubblico e un luogo privato. In seguito si è innalzato davanti alla scrivania un ripiano dove ordinare i comunicati stampa e altro materiale informativo, con il vantaggio, per il gallerista e gli stagisti di turno, di ritagliarsi una superficie di lavoro. Negli ultimi anni il ripiano è diventato un parapetto così alto che, di chi siede sull’altra sponda, s’intravede a malapena il capo. Più che punti d’accoglienza, sono uffici senza soffitto o, il termine inglese non potrebbe essere più calzante, dei cubicles. Per guardarci dentro bisognerebbe salire su una scala mobile come Jacques Tati in Playtime.
Questa nuova geometria dello spazio espositivo dovrebbe liberare lo spettatore dall’imbarazzo di sentirsi osservato mentre guarda le opere. Poche cose mettono più a disagio che essere guardati mentre si guarda, come ha ben intuito Duchamp con Etant donné, messo a punto nello stesso periodo (e nella stessa parte dell’Atlantico) in cui Hitchcock gira Rear Window. Dell’installazione di Duchamp si considera spesso soltanto l’atto voyeuristico del guardare la donna svestita attraverso la piccola feritoia nella porta e non, come insegna la visita al museo di Philadelphia, la fila silenziosa, impaziente e giudicante che si crea dietro al singolo visitatore impegnato nel suo piacere scopico. Con la sparizione fisica del gallerista dal white cube lo sguardo della sorveglianza si disincarna e si dissemina per tutto lo spazio espositivo. Viene interiorizzato. Di più: se ogni elemento che intralcia la contemplazione estetica va soppresso, si ha presto l’impressione che ad essere di troppo è la nostra stessa presenza. Per evolvere in questo spazio autonomo consacrato all’Arte dovremmo insomma annientarci, liberare lo sguardo da quello scarto organico, da quel “manichino cinestetico” che è il nostro corpo. L’opera d’arte perde così quella qualità minima indispensabile che l’estetica gli ha sempre riconosciuto: il suo “darsi a vedere”. Oppure questa datità non ha più un destinatario che possa raccoglierla.
Qualcuno potrebbe ribattere che dopotutto ce lo siamo meritato. Il white cube nasce dalla crisi di quel modello espositivo che irritava un Paul Valéry già nel 1923. Riportando la visita di un museo, probabilmente il Louvre, descrive il suo “sacro orrore” davanti al “disordine organizzato” e alla “vicinanza di visioni morte”. Mentre “l’orecchio non potrebbe sopportare di ascoltare dieci orchestre allo stesso tempo”, l’occhio al contrario “si trova obbligato ad accogliere un ritratto e una marina, una cucina e un trionfo, personaggi nelle condizioni e dalle dimensioni più disparate”. La sua sensibilità è pienamente modernista: bisogna spaziare tra loro le opere, restituirgli quell’unicità e quell’isolamento non garantito dall’accumulazione e dall’ambizione enciclopedica di Salon e musei. A Valery mancava la parola, ma quello che cercava somigliava al white cube descritto da O’Doherty.

Ma cos’è esattamente il white cube? Un set di elementi ricorrenti dello spazio espositivo, anzi di leggi rigorose “come quelle che presiedevano all’edificazione di una chiesa medievale” o la stanza del tesoro in una piramide. In sintesi: una stanza regolare con le finestre sigillate, i muri dipinti di bianco, il pavimento tirato a lucido, ogni oggetto d’arredamento espunto, fatta eccezione per il bancone d’ingresso, sempre più mimetizzato. L’illuminazione dall’alto è regolata in modo da creare un ambiente omogeneo e senza ombre che trasfigura le pareti bianche con un leggero tremolio. Un hortus conclusus igienico, isolato e immutabile, segregato rispetto alla realtà esterna e anelante all’eternità della forma pura. Le opere esposte, non protette ma tacitamente intoccabili, non interferiscono tra di loro. L’etichetta che ne identifica l’autore, il titolo, il materiale, le misure, la data d’esecuzione, il luogo di conservazione – ovvero che fa di un’immagine un oggetto concreto a tutti gli effetti – è per queste ragioni spinta agli angoli, marginalizzata rispetto all’opera che denota. Il visitatore, pensato al singolare, è indotto ad assumere un atteggiamento raccolto, quasi di contrizione, a mantenere quel silenzio artificiale lontano dalla congerie metropolitana. Il white cube fa così parte di quell’”estetica del silenzio” descritta già nel 1967 da Susan Sontag – abile nell’intercettare i fenomeni nel loro stesso accadere –, in rapporto a un crocevia culturale e sociale molto eterogeneo, come tipico dei suoi articoli.
Ora, il protocollo di sottrazioni descritte da O’Doherty e teso al modello iperuranico del white cube non è incarnato appieno da nessuna istituzione. E anziché diventare invisibile, lo spazio espositivo acquista una presenza singolare e spettrale, come aveva capito Yves Klein quando nel 1958 inaugura Le Vide nella Galerie Iris Clert. Una galleria svuotata non è mai vuota. “Con il Vuoto. Pieni poteri”, come annotò Albert Camus nel guest book. Klein non rivendicava semplicemente lo svuotamento dello spazio espositivo come gesto artistico ma lo dichiarava saturo di “sensibilità pittorica”, immateriale quanto assimilabile – senza alcuna mediazione e come per contatto se non per contagio – dai visitatori.
Un gesto in cui, come capita spesso davanti alle opere più sintomatiche di Klein, non sono più districabili le componenti simbolista e ironica, mistica e mistificatoria, utopica e kitsch. Klein è il più ironico tra i simbolisti, il più mistificatorio tra i mistici, il più kitsch tra gli utopisti.

Lungi dall’essere una mera questione di restyling o di location, il white cube è il “grado zero dello spazio” che “trasforma senza essere sottoposto al cambiamento”. Segna il momento in cui la galleria passa “da contenitore di oggetti a oggetto in sé”. Un salto cui contribuiscono, secondo O’Doherty, tre elementi: la parete, il pavimento e il collage. Il primo comporta l’eliminazione della cornice; il secondo l’eliminazione del piedistallo; il terzo l’eliminazione della profondità del piano pittorico. Decisivo il ruolo del collage – “cugino volgare” degli altri due elementi – che “saltò fuori dal dipinto per sistemarsi sul pavimento come un barbone”. In altri termini, il collage s’identifica con quella fase in cui “i molteplici punti di fuga del dipinto cubista si riversano nella stanza con l’osservatore”, in cui il piano pittorico bidimensionale esplode invadendo lo spazio reale: “Lo spazio non è solo il luogo in cui avvengono le cose: sono le cose a farnascere lo spazio [...] Se il piano della tela definiva la parete, il collage inizia a definire l’intero spazio”. Tradotto: nei primi anni sessanta, il collage si trasforma in assemblage.
O’Doherty è abile a istituire un’omologia tra lo spazio della rappresentazione e lo spazio espositivo, a “collegare la storia interna dei dipinti a quella esterna delle modalità espositive”. È così che può meglio render conto del pericolo più insidioso per il white cube: che l’Occhio – la percezione ottica disincarnata propria del modernismo – sia scalzato dallo Spettatore, dalla sua presenza fisica. Un processo che risale, secondo l’autore, all’impressionismo con “il tormento dello Spettatore”, un’”angoscia sensoriale” in cui “l’oggetto d’analisi diventa attivo; i nostri sensi sono sotto accusa”. Il white cube è la dimora dell’Occhio. Secondo Thomas McEvilley che firma l’introduzione del libro, qui “non si parla con un tono di voce normale; non si ride, mangia, beve, dorme né ci si sdraia; non ci si ammala, non si impazzisce, non si canta, balla né si fa l’amore”. Più prosaico O’Doherty: “Questo spazio”, nella fattispecie quello tridimensionale progettato da Mondrian, “sembra incompatibile con la grossolanità del corpo, in esso sono banditi rutti e scoregge”. (Questo vuol dire che Oh! È uno di questi signori che l’ha fatto! (1925), un dipinto di Mirò, non potrebbe essere esposto in uno spazio simile: il titolo allude infatti proprio alla scoreggia).
Il rapporto tra l’Occhio e lo Spettatore è più articolato di quanto sembra e andrebbe considerato, tra l’altro, sullo sfondo della traduzione inglese della Fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty e della teatralità delle sculture minimaliste. Qui basterà ricordare che O’Doherty vi rintraccia il doppio destino dell’arte visiva americana dopo il sisma pittorico di Pollock (un tormentone su cui si è esercitata tutta la critica d’arte USA). L’Occhio la trascina verso la pittura Color Field, lo Spettatore verso gli happenings e gli environments di Allan Kaprow, ovvero in direzione dell’ambiente artistico frequentato da O’Doherty quando elabora Inside the White Cube: ad esempio Eva Hesse, Dan Graham, LeWitt, Lippard, Robert Smithson, ma anche Kubler, Sontag, Beckett, Burroughs, Robbe- Grillet, Butor, incontrati tutti alla metà degli anni sessanta. È in questo periodo che la galleria diventa una propaggine dello studio, che il luogo d’esposizione e il luogo di produzione si sovrappongono. Nell’ultima sezione del libro, O’Doherty ne ripercorre la storia ad ampio raggio, da L’atelier del pittore (1855) di Courbet, in cui l’atelier diventa un soggetto artistico moderno, a Vito Acconci (grande assente è, inspiegabilmente, Bruce Nauman). Ed è in questo periodo che O’Doherty è attivo come artista, partecipando ad esempio a Rooms, la mostra inaugurale del PS1 (1976), con Standing Magic Square. Nonostante l’abilità nel tener distinte le sue cinque identità e la sua doppia carriera di critico d’arte e artista (in Inside the White Cube non fa cenno alle sue opere), è chiaro che queste due figure funzionano come sliding doors.

Qui tocchiamo un punto decisivo: chi si aspetta di leggere la storia del cubo bianco – la storia delle vicissitudini dell’Occhio – resterà deluso. O’Doherty è poco interessato a restituirne le occorrenze storiche. Al punto che, una volta tratteggiato il modello del white cube (e mai è stato fatto in modo così convincente), non fa che insistere sulle eccezioni – le vicissitudini dello Spettatore –, consapevole che queste eccezioni puntellano la storia degli spazi espositivi sin dagli anni venti. Non a caso nel 1976 O’Doherty visita l’Italia – primo dei suoi lunghi soggiorni nel nostro Paese prima di stabilirsi a Todi – per studiare l’architettura di Borromini. E del “fenomeno di dispersione d’energia dall’arte all’ambiente circostante”, Borromini può essere considerato uno dei padri nobili e, aggiungo, uno dei rari italiani, visto che in Inside the White Cube di italiano ci sono solo i cavalli di Kounellis alla galleria L’Attico.
Inside the White Cube racconta insomma l’emergere della figura dello Spettatore o il modo in cui l’Occhio ha preso coscienza del corpo in cui è installato, diventando insofferente alla cornice dell’opera d’arte, al confinamento dell’esperienza estetica. Gli esempi non mancano, a partire dai grandi classici come il Gabinetto astratto ad Hannover di El Lissitzskij; il Merzbau di Kurt Schwitters in cui la galleria diventa una “camera di trasformazione”; gli atelier – parigino e newyorkese – di Mondrian che uniscono architettura, scultura e pittura; lo studio di Brancusi che, posando le sculture direttamente sul pavimento, lo attiva e lo trasforma da mero supporto a zona estetica. Inaggirabile Duchamp, con i 1200 sacchi di carbone (1938) appesi al soffitto e da cui, per quanto svuotati, pioveva ancora del carbone sulla testa del pubblico spaventato.
L’artista francese è una figura chiave per O’Doherty: i due artisti si erano incontrati alla fine degli anni cinquanta, e nel 1967 questi registrerà Duchamp mentre legge The Creative Act (1957) ed estratti da A l’infinitif (1919-20).

Le rivoluzioni, si sa, si giocano in una manciata di giorni. Prendiamo la settimana che va dal 14 al 20 ottobre 1942. La prima data corrisponde all’apertura di First Papers of Surrealism alla Whitelaw Reid Mansion (su Madison Avenue, tra la 50ima e la 51ima Strada) in cui Duchamp, su invito di André Breton, realizza Mile of String: 1.609 metri di spago bianco che dal soffitto scendono a terra e schermano i quadri appesi ai muri. Corteggiando lo sguardo disincarnato, questa ragnatela immobilizza il corpo e confonde le coordinate dello spazio, al punto che sulla rivista VVV (marzo 1943) una fotografia dell’installazione viene pubblicata – inavvertitamente? si tratta pur sempre di una rivista surrealista – capovolta.
La seconda data, il 20 ottobre dello stesso anno: Frederick Kiesler trasforma in otto mesi due laboratori di sartoria nella galleria Peggy Guggenheim di New York (sulla 57ima strada, a sei giorni e sette isolati di distanza rispetto a First Papers of Surrealism) in occasione della mostra Art of This Century. Kiesler avvolge lo spettatore in un ambiente sinuoso e senza spigoli, dalle pareti concave come quelle della sala circolare del Tempio del Libro di Gerusalemme (1965). Le pareti non fanno da supporto alle tele che, senza cornici e inclinabili, sono staccate di circa trenta centimetri, sospese tra pavimento e soffitto. Della luce, tesa a esaltare le qualità plastiche degli oggetti, viene fatto un uso drammatico che illumina in alternanza ora un lato ora l’altro della sala (“l’illuminazione ordinaria dei musei fa apparire i dipinti come morti”). In giro si poteva ascoltare il rumore del passaggio di un treno come sulla banchina di una stazione. La galleria d’arte subisce lo stesso processo subito dall’unità abitativa e dalla scatola muraria, quella “prigione cubica” cui Kiesler contrappone la Endless house, involucro organico – bolla d’aria e respiro, guscio e galassia – in cui la vita si rigenera.
Gli anni sessanta offrono un campionario di spazi off: i cuscini argentati e il Cow Wallpaper esposti da Andy Warhol da Leo Castelli nel 1966; l’impacchettamento del Museum of Contemporary Art di Chicago da parte di Christo nel 1969. Più concettuale l’operazione di William Anastasi che, in occasione di una personale a New York nel 1965, si reca nello spazio vuoto della galleria Dwan per prendere una serie di fotografie. In seguito trasferisce l’immagine di una parete su una tela più piccola, avendo cura di riportare ogni elemento, dalle prese d’aria e di corrente al marcapiano e alle placchette. Secondo O’Doherty l’effetto di questo accrochage si prolungò ben oltre la durata della mostra, trasformando il muro della galleria in una sorta di ready-made che interferiva con le opere esposte successivamente da altri artisti. Non andava per le lunghe Robert Barry, che nel 1969 fece pubblicare su una rivista il seguente annuncio: “During the exhibition the gallery will be closed”. E in effetti la Eugenia Butler Gallery di Los Angeles rimase chiusa per le tre settimane della mostra, con lo stesso messaggio affisso sulla porta d’ingresso. Il gesto più estremo appartiene infine all’artista argentina Graciela Carnevale con il progetto Tucaman is Burning.
I visitatori erano accolti, nel corso dell’inaugurazione, in una sala completamente vuota con le vetrate coperte. Silenziosamente le porte si richiudevano dietro alle spalle degli ignari visitatori. L’opera consisteva nell’osservazione delle loro reazioni, che non si fecero attendere: dopo un’ora di sgomento ruppero i vetri e fuggirono in preda al panico. Per una volta il pubblico comprese perché gli artisti non hanno mai smesso di ribellarsi al white cube o a quello che Maurice Blanchot ha chiamato mal du musée.

Come mostrano questi esempi, il disinteresse di O’Doherty per l’istituzionalizzazione del white cube è strategico. Il suo non è, non vuole essere, un manuale di museologia ma un libro di critica d’arte incentrato sui tentativi di fuga dall’immacolata prigione modernista, sulla pratica artistica come invasione dello spazio espositivo, in linea con l’institutional critique che proprio in quegli anni si affermava. Per restare fedele al suo contenuto, Inside the White Cube avrebbe dovuto intitolarsi Out of the Box (titolo di una raccolta di articoli di Carter Ratcliff). Ed è per questo che è oggi necessario tornare a leggere questo libro scritto quasi quarant’anni fa e ancora attuale. Per proseguire le sue riflessioni, gli affiancherei un approccio archeologico del white cube, una meno ambiziosa analisi della sua congiuntura storica alla seconda metà degli anni quaranta che può riservare delle sorprese.
New York 1946: apre la galleria di Betty Parsons, a pochi metri dalla galleria progettata da Kiesler. Per almeno cinque anni regna incontrastata nel milieu avanguardistico: Barnett Newman, Rothko, Pollock, Clyfford Still, Ad Reinhardt. I loro signature paintings, astratti e giganteschi, avevano bisogno di spazio per respirare, come si diceva allora, e mal si prestavano a essere esposti nelle gallerie sulla 57ima strada, con i loro vasi di piante e le ornamentazioni, i divani e i tappeti da salotto, i rivestimenti in legno e i tendaggi. Un ambiente che mimava l’arredo degli appartamenti della clientela più facoltosa, che poteva facilmente realizzare se le opere esposte avrebbero sfigurato sulle pareti di casa.
Quando un’agenzia pubblicitaria contattò Betty Parsons per chiedere in prestito una grande tela da mettere sopra il divano del loro ufficio al fine di ricostituire un ambiente domestico, questa respinse inorridita la proposta, dileguando seccamente gli avventati clienti: “I’m interested in important paintings, not in the home”. Parsons pronunciò anche una frase al cuore delle nostre riflessioni, rivolta agli artisti a lei affiliati (allora non si usava ancora il gergale e brutto “scuderia”): “I give them walls. They do the rest”. Il gesto di Parsons in quanto gallerista è lungimirante: offrire agli artisti due stanze spoglie, o meglio nient’altro che delle superfici. Al resto penseranno gli artisti.
Riprendiamo il passaggio perechiano da cui siamo partiti: “Bisogna poter dimenticare il fatto che ci sono dei muri e allo scopo non abbiamo trovato niente di meglio che i quadri. I quadri cancellano i muri. Ma i muri uccidono i quadri”.
Se Perec ha ragione – e Perec, come Alighiero Boetti, è tutto ragione, sebbene una ragione che gioca con la sua ombra dentro un labirinto –, il gesto di Betty Parsons si tinge di una sottile crudeltà. Dare i muri agli artisti non era un atto magnanimo ma una provocazione. Quella che si giocava all’interno dei primi white cube è una vera e propria sfida tra la pittura e le pareti retrostanti, una sfida per sostituirsi a quel vuoto che rischiava da un momento all’altro di inghiottire le opere. È per questo che Rothko fa di tutto per cacciare i dipinti più grandi negli spazi più angusti. Bisogna cancellare i muri, a rischio che i quadri ne assumano la conformazione, ovvero che diventino semplici superfici, anestetiche o decorative che siano. Una sfida non raccolta o meglio lasciata cadere dalla pittura Color Field che, come scrive O’Doherty, oltre ad essere dalla parte dell’Occhio, non ha “mai cercato di impadronirsi della parete”, non ha mai “tentato una riconciliazione tra il murale e il quadro da cavalletto”, rimanendo “una pittura da Salon”.
Ora, non dobbiamo dimenticare che il cubo bianco di Betty Parsons fu progettato dall’architetto Tony Smith. O’Doherty dovrebbe averlo conosciuto in una delle mostre collettive cui hanno partecipato entrambi, tra cui Schemata 7 (1967) e Labyrinth al Philadelphia Institute of Contemporary Art (1976). Un incontro curioso, non c’è che dire: l’autore di Inside the White Cube e l’architetto artista che, negli anni sessanta, diventerà celebre per i suoi cubi neri. The Black Box e Die (1962), rispettivamente in legno dipinto e acciaio, non sono l’esatto contrario – visivo e concettuale – del white cube? Il cubo nero, insieme dormiente e aggressivo, è una sorta di autoritratto melanconico dell’artista che ha bruciato ogni immagine nell’oscurità della notte. Testimone di uno stato luttuoso, il cubo mette in mostra un processo di svuotamento: “se pensi lo spazio come un solido, le mie sculture sono dei vuoti eseguiti in questo spazio”. Non a caso Smith rifuggirà presto dal white cube, preferendo esporre i suoi cubi neri all’aperto o in luoghi abbandonati. In finale, i suoi cubi neri mi fanno pensare che il modello stesso del white cube – il capolavoro più perverso che il modernismo abbia escogitato – contenesse ab ovo la sua cupa latenza, insomma la possibilità di una via di fuga, quella percorsa dallo Spettatore. Gli artisti sono capaci di sintesi folgoranti: “There is a Love Affair between the White Cube and the Black Square” (Karina Bisch, Nicolas Chardon).
Riccardo Venturi
Questo articolo è apparso in forma ridotta su “Alias”, supplemento culturale de “Il Manifesto”.