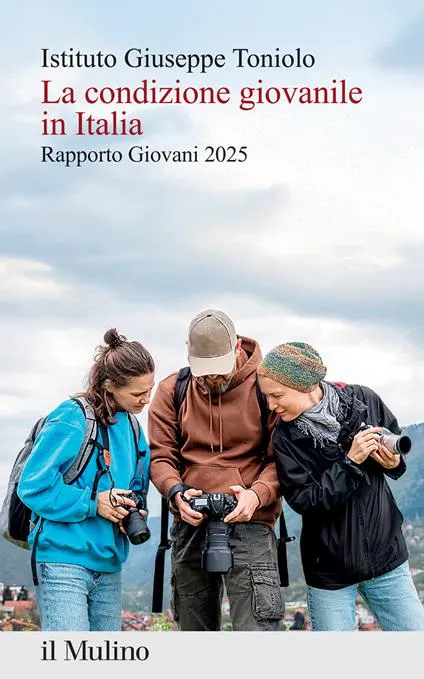Giovani: prove di futuro
“Non si sentono al loro posto se non percepiscono che quel posto può cambiare con loro”, sostiene Alessandro Rosina che cura le ricerche e la redazione del Rapporto Giovani 2025, ultima edizione di un contributo annuale che rappresenta uno dei ritratti meglio riusciti dell’evoluzione demografica, economica, sociale e psicologica delle giovani generazioni in Italia [Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2025, Il Mulino, Bologna 2025]. La frase di Rosina contiene le parole chiave per comprendere lo stato delle cose. Noi esseri umani siamo cercatori di significati. I significati nascono da una presenza partecipe. Prendere parte vuol dire sentire che conti nella dinamica e nell’evoluzione delle cose. Dal Rapporto emerge che le giovani generazioni in Italia sentono di contare sempre meno da un punto di vista demografico e, quindi, di incidere poco a livello elettorale, tanto da non suscitare attenzione in chi governa in un’epoca in cui il consenso per il consenso e il voto di scambio mettono, tra le altre ragioni, in crisi la stessa democrazia. Oltre alla quantità c’è il problema della qualità. Viviamo tutti in una inedita antropologia, che ce ne accorgiamo o no. Il posto di noi umani sul pianeta Terra è cambiato. Le giovani generazioni sono il punto di massima sensibilità della trasformazione della qualità della nostra vita. Sono loro ad essere al centro del ciclone del cambiamento e a sentirne le conseguenze. L’aspetto più rilevante del Rapporto è proprio l’atteggiamento prevalentemente anticipatorio di futuro delle posizioni che le giovani e i giovani esprimono. Tutti i contenuti indicano la capacità di segnalare con le loro posizioni il fallimento del modello di sviluppo dominante e le loro sensibilità mostrano non poche indicazioni di inedite e più appropriate forme di vita. Emerge dalle analisi del Rapporto un diverso modo di essere e fare nel mondo che non è solo nelle loro aspettative, ma nel modo di intendere la scuola, il lavoro, i progetti di vita e la partecipazione sociale.
Le fatiche e le incertezze, le crisi e i disagi, così presenti nelle esperienze delle giovani e dei giovani nascono dal rapporto con i contesti che mostrano di non essere in grado né disponibili a mettersi in discussione con loro. Del resto l’incertezza regna sovrana in molti degli aspetti delle loro vite. Dalla precarietà lavorativa all’assenza di prospettive pensionistiche; dal rinvio sistematico dei progetti di vita al contesto ostile alle loro aspettative, la condizione esistenziale è satura di incertezza. Dal punto di vista degli orientamenti di valore i giovani mostrano di non riconoscersi nella prospettiva “più lavori e più consumi”. Aspirano in modo sempre più chiaro a un diverso modello di sviluppo. Il benessere relazionale ha assunto un ruolo cruciale nella loro visione della vita e si combina con una crescente ansia ecologica. Se questi sono alcuni aspetti degli atteggiamenti e dei sentimenti dei giovani non è difficile ricavarne l’evidenza di un ruolo analizzatore e segnalatore non solo della loro condizione ma della necessità di cambiamento nei nostri stessi modelli di vita e lavoro.
Se continueremo a guardare ai percorsi di adolescenti e giovani con gli occhi del passato, a entrare nei loro territori con le nostre mappe non aggiornate, non solo non capiremo che esperienza di sé e del mondo stanno facendo, ma neanche potremo aiutarli a dar vita a nuove posture e a inediti percorsi che permettano di allentare l'ansia e ritrovare il senso del possibile. Non esistono, infatti, innumerevoli rappresentazioni diverse di un unico mondo ma innumerevoli mondi diversi, ciascuno dei quali si fonda su una prospettiva unica e irripetibile dell’essere che lo percepisce. Si rende necessario un ontological turn generazionale. E qui sta il problema. Le resistenze a persistere nella lettura del presente da uno sguardo del passato ci sono sempre state nei ricambi generazionali. La loro intensificazione oggi è dovuta alla velocità dei cambiamenti da un lato, e alla discontinuità radicale dovuta al fallimento del modello di sviluppo vigente. C’entra però anche il modo di intendere la nostra esperienza umana e il senso e il significato che cambia e che le giovani generazioni attribuiscono alla vita e al lavoro. L’affermazione di un paradigma corporeo, evidenziata in particolare dalla ricerca scientifica e psicologica, trova la sua corrispondenza nell’attenzione al corpo e alle emozioni che le giovani generazioni esprimono in modi più evidenti e risoluti. Lo stesso vale per l’attenzione all’estensione delle reti di relazioni e dell’empatia al di là dei confini fisici e tradizionali, che incidono nella concezione dei progetti di vita e delle prospettive di futuro. Ne risulta accorciata la distanza fra desiderio e realtà fino a rischiare, spesso, di neutralizzarla. Appare alimentata da più parti la negazione della paura fino a inabilitare la capacità di gestirla. È anche, forse, per questo che è eccitata la dimensione competitiva della giocosità fino alla negazione del limite. Così come, soprattutto da parte genitoriale, è esasperata la cura fino a negare l’autorità dei compiti di crescita e causare dipendenze endemiche. La curiosità e la ricerca sono spinte in direzioni irraggiungibili e verso modelli irrealizzabili. Tutto questo provoca la rabbia per gli scarti costanti tra aspettative compulsate e possibilità inesistenti o rare, e finisce per alimentare la/il tristezza/dolore per i fallimenti e le delusioni dalla vivibilità ecologica allo scarto tra capacità e opportunità. Non bisogna meravigliarsi, perciò, se poi sembra spento il motore dei sogni degli adolescenti e dei giovani. Sono soprattutto gli sguardi degli adulti che leggono le realtà adolescenziali e giovanili muovendosi tra emozionalismo e patologizzazione. O si esaltano le prestazioni sollecitando ogni tipo di performance fino all’estremo; o si ritengono patologiche le differenze espresse da adolescenti e giovani fino a mettere in atto tentazioni e pratiche di disciplinamento. Assistiamo a una crisi di riconoscimento intergenerazionale oltre quello che è sempre accaduto.

Eppure se volgiamo lo sguardo al versante orientale, quello dello statu nascenti di inediti orientamenti di valore e criteri di scelta, di vie originali, di progettualità e innovative forme di vita, non è difficile vedere i segni di un mondo nuovo che nasce. Come è sempre stato. Il versante orientale, quello dei movimenti e dei processi sorgenti, richiede sguardi aperti e controllo della nostra vis valutativa e giudicante.
La tensione permanente verso il futuro è una proprietà distintiva delle forme di vita, e quando risulta debole, come evidenzia Alessandro Rosina nell’introduzione al Rapporto Giovani 2025, vuol dire che si sono creati dei gap tra capacità e opportunità. Individuare quello che ancora manca per una più efficace connessione fra capacità e opportunità rappresenta uno dei principali punti di attenzione. La mancanza, infatti, non è solo indicativa del vuoto e delle carenze in cui ci si può smarrire, ma è anche lo spazio del “non ancora”, l’utero generativo del possibile. Si chiamano generazioni o nuove generazioni. La polisemia del termine indica le potenzialità di esprimere il possibile, quello che ancora non c’è o è solo presente in potenza e richiede investimento per generarsi e potersi realizzare. A trasformare la mancanza in possibilità può contribuire in primo luogo l’educazione. Proprio su questo punto una delle ricerche contenute nel Rapporto mette in luce le difficoltà dei giovani a vedere nell’educazione e nella formazione, così come sono organizzate oggi, un’opportunità. Circa la metà dei giovani ritiene che la riuscita nei progetti di vita dipenda dalle condizioni sociali ed economiche di partenza. Un rischio connesso a questa constatazione è l’inasprimento delle disuguaglianze sociali ed economiche, a causa del calo della motivazione a formarsi proprio per i giovani che partendo da condizioni svantaggiate potrebbero trarre maggiori benefici dalla formazione. Allo stesso tempo e per ragioni analoghe il lavoro finisce per essere visto solo come fonte di reddito per sopravvivere e non come opportunità di realizzazione e fonte di significato. Nonostante tutto il lavoro mantiene una posizione centrale nel progetto di vita delle nuove generazioni. La loro attenzione però riguarda un’occupazione che tenga conto del senso e della qualità del lavoro. Quello che cercano, all’interno di una laicizzazione dell’idea di lavoro, è un lavoro capace di soddisfare la domanda di significato. Il lavoro non deve impedire un progetto di vita e la possibilità di avere figli e di prendersene cura; non deve costringere a rinunciare a un tempo di vita di qualità; deve permettere di potersi riconoscere nei valori dell’azienda. Ne deriva che più che perdere rilevanza, nelle aspettative dei giovani, il lavoro allarga i suoi confini rispetto alle dimensioni di un modo nuovo di intendere il benessere che sempre più è associato al ben lavorare. Naturalmente accanto al tema del lavoro emerge come rilevante l’autonomia abitativa come traguardo che segna il passaggio all’età adulta. È ben noto quanto sia difficile oggi accedere all’autonomia abitativa e alla possibilità di fare scelte orientate al benessere e alle aspirazioni di sostenibilità e qualità di vita pur nella consapevolezza dei cambiamenti del mondo contemporaneo.
Studiando il rapporto tra giovani e abitazione emergono non pochi elementi di novità a proposito degli equilibri tra la casa, l’urbanità e il sentimento di vivibilità e sostenibilità ambientale che è particolarmente rilevante nella sensibilità delle giovani generazioni. Si ravvisa infatti una costante ricerca di equilibrio e un deciso orientamento all’adattamento tra le opportunità lavorative, l’accesso ai servizi, i costi delle abitazioni e il tema della vivibilità sia ecologica che sociale. Non manca, per quanto impostata su geometrie variabili, la ricerca delle condizioni per sperimentare un senso di appartenenza comunitaria. Il contesto abitativo ideale, infatti, per i giovani intervistati non è quello delle grandi città sovraffollate. La preferenza è soprattutto accordata ai centri di medie dimensioni che possano combinare la presenza di servizi di qualità con ritmi di vita più gestibili. Accanto alle attenzioni per la socialità e la qualità delle relazioni, c’è l’aspettativa di vivere in uno spazio che deve potersi estendere oltre la casa, nei luoghi di lavoro. L’attenzione alla dimensione pubblica della vita è un tema di costante interesse, così come le questioni collettive. Questa constatazione contrasta con la corrente interpretazione della distanza dei giovani dalla politica. Probabilmente il loro sentimento del mondo li tiene lontani dalla politica così come oggi si esprime ma non dalla ricerca di condizioni di vita sociale e pubblica più evolute, più emancipate e più fondate sulla libertà, la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e i diritti umani. La questione rilevante del tempo presente è creare le condizioni per ascoltare questa domanda così articolata e innovativa, offrendo ai giovani spazi e strumenti per esprimere le proprie idee e contribuire alle decisioni che influenzano il loro presente e il loro futuro.

Il Rapporto smentisce la retorica dell’apatia giovanile verso la vita pubblica e la partecipazione democratica. Quel che il rapporto di ricerca evidenzia è soprattutto una difficoltà nel riconoscersi nell’offerta politica, percepita come poco coerente e poco in grado di attrarre i propri interessi e coinvolgere la propria attenzione. La crisi di rappresentanza e la polarizzazione del dibattito pubblico accentuano la sensazione che il bene comune sia trascurato, mentre prevalgono interessi di parte. Nonostante questo c’è molta attenzione e sintonia con i temi dei luoghi di vita, per il miglioramento delle comunità di appartenenza e allo stesso tempo per gli interessi globali legati ai diritti e alla sostenibilità. Emerge una coscienza diversa, sia locale che planetaria, che richiede attenzione e considerazione per essere valorizzata. L’auspicio che emerge dalle posizioni dei giovani riguarda una politica più inclusiva, capace di offrire veri spazi di partecipazione per le nuove generazioni, in modo da migliorare la percezione della democrazia e invogliare all’impegno politico. Si evidenzia così quanta ideologia sia contenuta nelle sistematiche affermazioni relative alla crisi dei valori dei giovani o addirittura all’assenza dei valori nella loro esperienza. Certamente il tempo in cui vivono e il mondo che ereditano dalle generazioni precedenti crea in non pochi casi un sentimento di disperazione. Emerge tuttavia come, nei casi in cui prevalogono le esperienze di altruismo e di opportunità di relazioni sociali ampie e approfondite, non solo si arginano i sentimenti negativi ma si afferma l’attenzione a costruire relazioni basate sul confronto, sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione dell’altro secondo uno spirito di libertà e di giustizia. Questi orientamenti sono evidenti anche nel momento in cui si esplora la triste questione della violenza contro le donne. Affrontare e risolvere il problema, secondo i giovani, non può dipendere solo dall’attività repressiva e punitiva, ma dall’evoluzione della condizione della donna nella società, dai ruoli di genere, dalle aspettative e dalla qualità delle relazioni, ma anche dal modo di esprimersi in famiglia nella società. Emerge in ogni caso nelle nuove generazioni l’aspettativa di superare gli stereotipi di genere nella formazione delle proprie esperienze e nella propria vita relazionale, ma anche nella ridefinizione dei modelli educativi dominanti, impostandoli su un pluralismo dei codici affettivi. Il Rapporto, come di consueto si conclude con due approfondimenti territoriali, uno riguardante il Trentino e l’altro la Finlandia. In entrambi i casi si evidenziano criticità e possibilità analoghe a quelle che riguardano tutta la realtà italiana. Le specificità della situazione trentina, ricondotta in buona misura all’autonomia speciale di quel territorio, sono descritte con un’analisi in buona misura generosa. Per chi conosce in maniera approfondita quella realtà, purtroppo il tasso di innovazione e di capacità per generare prospettive future sembra non corrispondere del tutto alle descrizioni contenute nel Rapporto. È necessario parametrare le politiche e gli interventi alla particolare disponibilità normativa e finanziaria propria dell’autonomia, e allo stesso tempo si tratta di considerare con attenzione il fatto che i giovani con il livello di formazione più elevata e con aspettative più rilevanti di espressione di sé non sempre incontrano in quella realtà le opportunità corrispondenti a quanto si attendano e, quindi, cercano la propria realizzazione altrove.
In sintesi il Rapporto Giovani 2025, che andrebbe letto soprattutto da chi governa e decide, oltre a chi è interessato a capire il presente e il futuro, mostra che le giovani generazioni vanno guardate dal futuro. I giovani fanno i conti con il fallimento di un intero modello di sviluppo e propongono ovunque possono una maggiore sensibilità ecosistemica unita a una coscienza planetaria; un’estetica delle relazioni e un’attenzione al pluralismo di genere e delle differenze; una laicità realistica rispetto al lavoro e all’esperienza lavorativa come fonte di significato; un’attenzione alla rilevanza della sfera simbolica; e una apertura alle molteplici forme dell’interconnessione interculturale. Si tratta di lezioni particolarmente importanti per chi voglia vivere il presente preparando il futuro.