Speciale
Ngũgĩ wa Thiong’o: biblioteche che muoiono
«In Africa ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia” disse il grande intellettuale maliano Amadou Hampaté Ba, parlando della tradizione orale. Il 28 maggio 2025 un’enorme biblioteca è stata arsa dal fuoco, ma per fortuna i suoi libri sono stati salvati. Si chiamava Ngugi wa Thiong'o o meglio, si è chiamato così. Nato nel 1938 a Kamiriithu, quando il Kenya era una colonia inglese, come James Ngugi, negli anni Settanta decise di abbandonare il suo nome “coloniale” e di chiamarsi con il suo nome kikuyu: Ngũgĩ wa Thiong’o.
Cresciuto sotto il dominio britannico fin da giovane partecipa alle battaglie per l’indipendenza, violentemente represse dal governo britannico. Conosce il carcere e le percosse e intanto inizia a scrivere racconti, romanzi e articoli sulla situazione politica kenyana.
Il suo romanzo d’esordio si intitola Weep not, child del 1964 (uscito in Italia per Jaca Book con il titolo Se ne andranno le nuvole devastatrici), in cui parla della rivolta anticoloniale dei mau mau, il movimento di ribellione ferocemente represso dagli inglesi. N’gugi non è però uno che si fa condizionare dalle retoriche dominanti, neppure da quelle indipendentiste, infatti, tre anni dopo un altro capolavoro prende vita: Un chicco di grano, in cui riflette sulle divisioni tra gli stessi kenyani dopo l’indipendenza.
«La storia culturale del continente si può dividere in tre grandi fasi: l’Africa prima della conquista dei bianchi, quella sotto la dominazione coloniale e quella di oggi, che si sforza di trovare la vera immagine di se stessa». Così scriveva nel 1971 su The Unesco Courier, il mensile pubblicato dall’organizzazione culturale delle Nazioni Unite. Lui, che aveva lottato per l’indipendenza, si trovava ora a criticare fortemente i nuovi leader africani, per il loro comportamento spesso dittatoriale, per conformarsi ai modelli occidentali e per la corruzione. Tanto è vero che nel 1977 fu incarcerato dal governo dell’allora presidente Jomo Kenyatta, il padre dell’indipendenza keniana, per aver scritto, insieme a Ngũgĩ wa Mirii, l’opera teatrale Ngaahika ndeenda (Mi sposerò quando voglio), che criticava il sistema capitalistico adottato dalle nuove autorità. Il successore di Kenyatta, Daniel Arap Moi, lo costrinse all’esilio, prima nel Regno Unito, e poi negli Stati Uniti, dove ha insegnato a lungo all’università. Ritornato in Kenya nel 2004, vive una terribile esperienza. Degli intrusi entrano nel suo appartamento, lo aggrediscono e violentano la moglie Njeeri. N’Gugi si dice convito che sia stata una vendetta politica, per avere denunciato la corruzione e le incapacità delle élites postcoloniali.
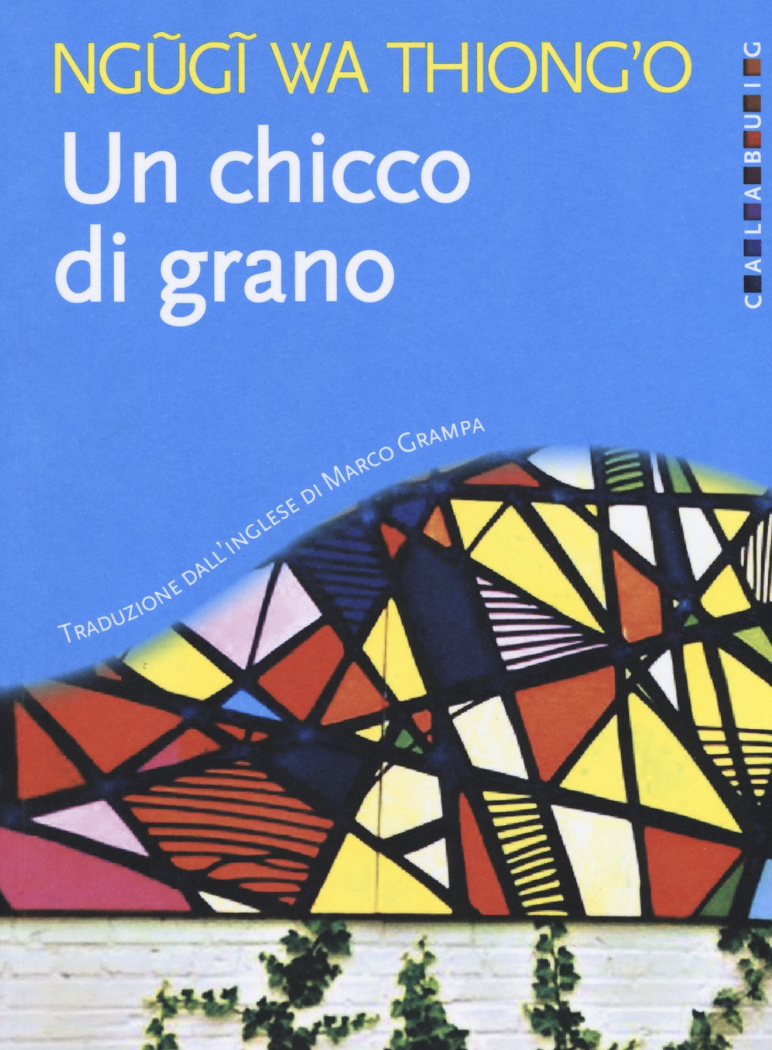
In un celebre saggio del 1986 dal titolo Decolonizzare la mente (Jaca Book 2015), sulla linea del Fanon di Pelle nera, maschere bianche, riflette appunto sull’atteggiamento succube di molti leader africani, che inseguono gli schemi occidentali, invece di cercare una “via africana” allo sviluppo e al cambiamento.
Personaggio scomodo N’Gugi, anche quando affronta tema letterari, come la lingua in cui scrivere. Dopo i primi romanzi in inglese, nel 1980 dà alle stampe Caitaani mutharaba-Ini (Diavolo in croce), scritto in lingua kikuyu, durante la sua reclusione in carcere, su fogli di carta igienica.
«Oggi ci rendiamo conto sempre di più che lo studio delle lingue africane è importante per creare un’immagine significativa di noi stessi. Incentivandolo, inevitabilmente sempre più africani vorranno scrivere nelle loro lingue, aprendo nuove strade alla nostra immaginazione creativa», scrive in un articolo su The Unesco Courier, sottolineando l’importanza di usare la propria lingua madre.
Il tema della lingua è stato spesso al centro dei dibattiti tra scrittori africani: scrivere nella lingua “coloniale” consente di raggiungere un pubblico ampio, ma al di là del fatto che quella lingua riflette una sudditanza, fino a che punto l’inglese, il francese o il portoghese possono esprimere il pensiero indigeno? Il riappropriarsi della propria lingua natale e farla diventare letteraria, è sicuramente un gesto politico importante, ma restringe il pubblico alla propria etnia o meglio ai non molti della propria etnia che sanno leggere.
Fedele alle proprie scelte, ancora nel 2024, insieme all’intellettuale senegalese Boubacar Boris Diop, aveva firmato una lettera al neoeletto presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye invitandolo ad adottare le lingue locali come “pietra angolare” del nuovo Senegal.
«I suoi non erano solo romanzi», ha commentato il giornalista ugandese Charles Onyango-Obbo, in «con i suoi libri ha istigato rivolte: ogni titolo era una molotov lanciata contro il cannone coloniale, il burocrate neocoloniale e i traditori dell’indipendenza. Il vecchio leone se n’è andato, ma il suo ruggito risuona ancora».
Poeta, drammaturgo, romanziere e saggista, il suo nome è comparso più volte come candidato al Premio Nobel, che certamente avrebbe meritato a pieno titolo, per il suo impegno e per le sue capacità letterarie. «Finisce un’era di scrittori che hanno reso il novecento un periodo di cambiamento culturale e di evoluzione della letteratura africana», ha scritto Aihehi Eidoro su un sito nigeriano di letteratura. «Insieme ad Achebe, Soyinka, Aidoo e molti altri, Ngũgĩ ha contribuito a gettare le basi della letteratura africana come la conosciamo oggi. Ha lottato per portare le voci africane sulla scena mondiale e ha fornito ad altri scrittori il linguaggio per raccontare vicende radicate nelle loro storie e culture».
Leggi anche:
Marco Aime | L’Africa non è un paese
Marco Aime | L’Africa a Venezia
Marco Aime | Africa rossa
Marco Aime | Restituzione: di chi sono le opere d’arte?
Marco Aime | L’etnocentrismo ministeriale. E l'Africa?
Marco Aime | Alì “Farka” Touré: la mia musica viene dall'acqua
Marco Aime | Ousmane Sembène, padre del cinema africano
Marco Aime | African Parks: business bianco
Marco Aime | Africa: la storia dalla parte del leone
Marco Aime | Africa: il progresso del sottosviluppo
In copertina, Dogon (Mali), fotografia di Marco Aime.







