Caspar David Friedrich e l'incompiuto
La parola greca ekphrasis – che fa la sua comparsa in uno scritto di Ermogene, retore del secondo secolo d.C. – si riferisce a «un discorso descrittivo che pone l'oggetto sotto gli occhi con efficacia». Questo termine, che ha ormai un lungo corso nella critica d’arte, viene in mente leggendo La figura umana, il libro che Gianluca Didino dedica alla sua relazione appassionata, talora tormentata, mai apologetica con il pittore romantico Kaspar David Friedrich.
Gli oggetti che Didino “pone sotto gli occhi con efficacia” sono una sequenza di quadri del grande pittore tedesco, tra i quali spicca il celebre Viandante sul mare di nebbia, con cui l’autore dichiara di avere intrattenuto un dialogo continuo durato anni, con un crescendo di coinvolgimenti affettivi alternati a parentesi riflessive e oggettivanti.
Si tratta dunque di una ekphrasis del tutto particolare: difficilmente collocabile in un genere retorico tradizionale, restituisce tuttavia una trama complessa di azioni e reazioni messe in moto dal confronto con le opere di Friedrich.
Fin da principio ci accorgiamo che la presenza iconografica del pittore tedesco acquista il senso di una ricorsività ossessiva: l’autore ne parla come di “un bias cognitivo percepito da chi ne è soggetto come una forma di schizofrenia a bassa intensità, un’incursione dell’allucinazione nella trama del quotidiano”.
Ma come fa l’immagine di un quadro a diventare un’ossessione? Un quadro, come il Viandante di Friedrich, che apparentemente non ha nulla di allucinatorio, semmai induce a una visione potenziata, a una contemplazione della contemplazione del soggetto ritratto.
Eppure, a seguire Didino, ci troviamo progressivamente dentro un viaggio sentimentale che rovescia come un guanto la vulgata critica tradizionale che vede nel Viandante l’emblema del Romanticismo pittorico, quasi una sorta di summa icastica del desiderio di infinito e di assoluto che anima questa età della storia culturale europea.
Questi incontestabili significati del quadro vengono calati dentro una cornice autobiografica in cui assumono i contorni di una ricerca di senso che si scontra con la banalità del vivere e l’effimera affermazione di se stessi.
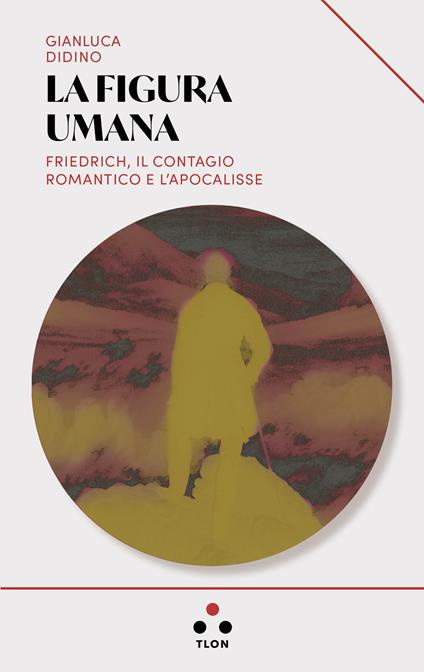
Da principio è una cartolina inviata da un amico che riproduce il noto quadro, poi l’immagine diventa lo specchio della relazione a distanza con l’amico, un tempo compagno di scuola e ora vagabondo senza meta in giro per il mondo. Ma il celebre dipinto si fa anche specchio di una memoria retrospettiva: il manuale di filosofia dove la riproduzione del viandante apriva il capitolo dedicato al Romanticismo.
Da lì l’immagine transita impercettibilmente nella trama dell’amicizia con S., l’amico della cartolina.
E il camminare diventa una condizione esistenziale dell’adolescente liceale che evade dalla sua provincia geografica e da quella dell’anima per andare verso l’orizzonte:
“Così avevo camminato. Per anni e anni. La rotta del mio camminare aveva finito per divergere da quella di S. Ma c’erano svolte impreviste, inversioni a U, passaggi segreti, prospettive impossibili come in un dipinto di Escher. Ci ritrovavamo per perderci subito dopo. Ci perdevamo per ritrovarci. Eppure continuavamo ad allontanarci, inesorabili, trascinati da una corrente invisibile. Andavamo alla deriva, come ogni altra cosa nel nostro mondo caduto.”
Ciò che sorprende di questo breve libro, dedicato a un’icona che è scesa dal piedestallo dell’arte per diventare sostanza vitale, è la sua capacità di restituire senza alcuna enfasi una trama di ramificazioni metaforiche che compendiano un intero percorso esistenziale.
Il Viandante, ma anche Il monaco in riva al mare o Le bianche scogliere di Rügen, appartengono a una percezione dell’incompiuto in cui l’io narrante ritrova la sua inadeguatezza, il suo senso di solitudine improduttiva, la vanitas di ciò che il mondo gli offre, la vanitas di sé medesimo.
Le incursioni nella propria vita e nelle proprie solitudini – quelle dell’adolescente nel proprio paese natale, e poi quelle londinesi nella città della giovinezza e maturità – si alternano ai ritorni nella storia.
E qui è di scena la vita dell’artista che sta all’origine di questa inesausta ermeneutica del desiderio: Friedrich stesso, nato il 5 settembre 1774 a Greifswald come terzo figlio di un candelaio luterano, precocemente segnato dalla morte per annegamento di un fratello e da altre disgrazie familiari.
“Segnato dunque da questa tragedia o da un’altra di cui non ci è giunta notizia, Friedrich cresce alto, sgraziato e solitario. Ha ossa grandi, da contadino. Gli occhi però, raccontano i contemporanei, hanno una purezza infantile”.
E l’infanzia, ricorda l’autore, è una categoria che entra prepotentemente nell’immaginario romantico, introdotta da Rousseau e poi adottata da coloro che, come Schiller e i romantici di Jena, vedono in questa età della vita umana la libertà rispetto alla coazione della razionalità strumentale.
Il desiderio senza meta, l’esplorazione per il gusto di esplorare e l’immaginazione al servizio del fantastico è una figura del pensiero che scenderà per i rami romantici fino ad approdare al flâneur baudelairiano e nel Novecento a quello benjaminiano.
Anche questa potenzialità è già tutta presente nei dipinti unheimlich (inquietanti) di Friedrich, in quelle figure viste di schiena che inducono a un pensiero dell’origine e nello stesso tempo della distruzione.
Il più romantico di tutti i pittori del primo Ottocento in realtà, ci ricorda Didino, aveva scarsissime frequentazioni dei circoli culturali allora emergenti. “Friedrich non conosce nessuno del gruppo degli amici che hanno inventato il Romanticismo: certamente non ha mai sentito la parola usata con il significato che le ha attribuito Friedrich Schlegel, lo stesso che usiamo ancora oggi”.

Friedrich del Romanticismo non sembra conoscere quello che i romantici di Jena chiameranno il Synphilosophieren, la filosofia come pratica dialogica che si arricchisce nella moltiplicazione delle prospettive. Di questa dimensione platonica Friedrich sembra essere privo, il suo è un fare artistico solitario che fa tutt’uno con le immagini che produce, altrettanti emblemi dell’assenza della dimensione sociale e ancor più di quella conviviale.
La progettualità che i romantici rivolgono verso un futuro in cui la condizione finita dell’umano si fonderà con l’infinito sotto il segno della libertà non appartiene a Friedrich. E nemmeno gli appartiene l’ottimismo di Friedrich Schlegel che sogna una nuova mitologia che sostituisca quella degli antichi per dare immagine e figura alla Modernità.
Quella del pittore del Viandante è una sorta di incantesimo del disincanto perché anche l’abisso, l’oscurità e la solitudine possono produrre l’illusione, per quanto effimera, della vita.
L’arte di Friedrich appare quindi, in questo libro-confessione, come una sorta di grandiosa allegoria non tanto dell’età romantica in cui pure affonda le sue radici, ma di quella tarda modernità in cui il disincantamento del mondo si è ormai definitivamente realizzato lasciando sulla strada individui attoniti e ipnotizzati da una società che ha perso ogni orientamento.
La bellezza del libro di Didino sta in questo scavo metaforico che riesce a fare di un’icona diventata tristemente kitsch una straordinaria figura del nostro tempo. La figura umana del pittore dell’infinito è dunque la segnatura di un’età votata alla distruzione.
In copertina, Le bianche scogliere di Rügen, Kaspar David Friedrich.







