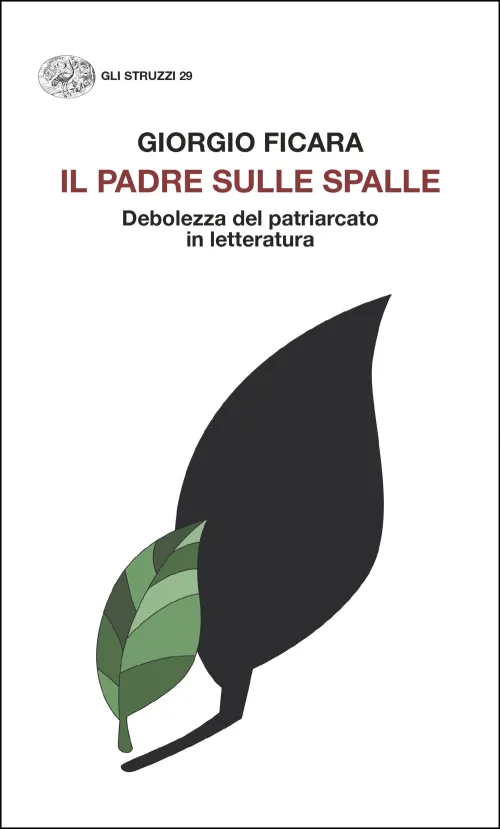Il peso dei padri
Che di padre e di padri si parli oggi con una ricorsività mediatica quasi ossessiva è sotto gli occhi di tutti.
Se ne parla mobilitando, quasi sempre in senso peggiorativo, l’alone connotativo associato alla paternità. Parole come paternalismo e patriarcato dominano la discussione pubblica associate all’idea del dominio maschile e della violenza nei confronti delle donne. L’emancipazione femminile ha richiesto, e non poteva essere altrimenti, una radicale messa in discussione dei meccanismi di potere che da millenni l’universo maschile ha adottato nella relazione con la donna sia nella dimensione pubblica sia in quella privata. Si è trattato di una disamina critica che una volta avviata ha interessato non solo le relazioni sociali e le dinamiche psicologiche, l’assetto economico delle società e i nuovi criteri di valore ma anche e in misura considerevole l’ampio spettro delle forme simboliche e l’insieme delle immagini che hanno rappresentato e suggellato le differenze e le disparità di genere.
Uno degli stereotipi più tenaci della tradizione occidentale, e certamente non solo di quella, ha assegnato da sempre al maschile l’attributo della forza e del coraggio come condizione per l’esercizio del potere, anzitutto nell’ambito familiare. Una locuzione giuridica come ‘patria potestà’ riconosce al padre l’esercizio della responsabilità legale verso i figli, il suo presupposto implicito è il riconoscimento di una auctoritas e di una forza superiore a quella della madre.
Questo quadro valoriale che fissa la «legge del padre» in ragione di una superiorità maschile, assai prima della odierna liquidazione per manifesta inconsistenza, è stato fin dalle più remote origini quasi totalmente disatteso nella letteratura.
Lo dimostra in maniera inconfutabile un libro di raro spessore teorico e nondimeno di gradevolissima lettura: Il padre sulle spalle. Debolezza del patriarcato in letteratura di Giorgio Ficara.
L’autore non è nuovo a ricognizioni letterarie che sanno affrontare diacronie di lunga gittata alla ricerca di un fil rouge che consenta di individuare delle direzioni di marcia che solitamente sfuggono agli sguardi micrologici, agli accanimenti filologici o alle partizioni storiografiche tradizionali.
La tesi del libro, per altro annunciata perentoriamente nel titolo, è che la letteratura ha la rara capacità di problematizzare e di relativizzare gli assunti inscalfibili delle discipline dedite alle ricostruzioni storico-evolutive. O di mettere in discussione gli assetti normativi su cui si è retta la tradizione, in questo caso occidentale.
La letteratura, a differenza della doxa imperante e delle sue differenti declinazioni giuridiche, ha saputo dare della figura del padre un’immagine più aderente alla condizione delle vite reali, più vicina alla complessità delle situazioni umane, paradossalmente più ‘critica’, più capace di un’interrogazione radicale, di quanto non sia stata in grado di fare la stessa critica filosofica.
La letteratura, e gli esempi forniti da Ficara lo dimostrano nel modo più convincente, ha la capacità di rappresentare, attraverso la forza dell’immagine e della narrazione, ciò che il ragionare filosofico prova a dire in astratto. Pertanto, la visibilità e l’evidenza di un personaggio letterario agiscono sul lettore con un grado di persuasività superiore, potenziandone la memoria e quindi l’effetto di lunga durata.
Ma veniamo ora alla variegata rassegna di personaggi che nel libro di Ficara danno veste alla figura del padre debole e incerto, alla sua intima lacerazione tra la forza e l’autorità che il mandato sociale e il sistema culturale gli assegna e la fragilità fisica e caratteriale che la letteratura ha saputo rappresentare.
La letteratura ha una sua peculiare vocazione all’imperfezione; anche laddove le figure sembrano essere icone della compiutezza ideale sono in realtà minate dal tarlo dell’immanenza, dalla precarietà di tutto ciò che è vivente.
Il ‘personaggio padre’ iniziale non poteva che essere Anchise, il padre “vecchissimo e stanchissimo” che Enea si carica sulle spalle con una formidabile inversione di ruoli: ora è lui bisognoso di cure e di dedizione e quando la sua ora è suonata su una “triste riva” siciliana il figlio esclama: «Qui, padre, mi lasci». La forza poetica di quell’abbandono rovescia nell’impotenza della morte il presunto potere paterno.
La trama del libro è tutta intessuta di questa continua tensione dialettica tra gli archetipi dell’eroismo paterno e la sconfessione che la vita fornisce di quelle immagini ideali.
Un esempio formidabile lo offre il Julius Caesar di Shakespeare in cui Cesare perde l’eccezionalità eroica che la tradizione storiografica gli ha assegnato nel corso dei secoli. È ora un dio tremebondo, spaventato e malato. E quasi a tracciare un filo che scavalca il tempo storico Cassio dirà a Bruto: «Come Enea portò sulle spalle il vecchio Anchise salvandolo dalle fiamme, così io trassi dalle onde del Tevere lo stanco Cesare, che ora è diventato un dio».
Se le narrazioni antiche mobilitano il divino e osservano da quella specola il ‘personaggio padre’ che esse mettono in scena, nella Modernità quell’alone di trascendenza si rovescia nelle fattezze dell’eroe per caso e l’eroismo assume una veste per così dire ordinaria passando dallo stato di eccezione e dalla lontananza del mito alla contiguità del quotidiano.
Così ci appare Tom Jones, un eroe che calca la scena del teatro del mondo con la disinvoltura di un picaro della porta accanto, a cui il destino riserva la più piena libertà dalla legge del padre, non avendone lui mai avuto uno.
Il trovatello, libero da legami familiari, sebbene esposto alle mille intemperie della vita, può tuttavia trovare da sé la sua strada e percorrerla con le sue imperfezioni e le sue traversie. In questa invenzione del destino risiede la sua modernità, ossia l’appartenenza a un mondo che ha congedato la sottomissione al Dio-padre.
Come ci ricorda ad apertura di libro lo stesso Ficara: “Freud scriverà che la morte del padre è «l’avvenimento più importante (…) nella vita di un uomo»: vivere una nuova vita sciolti dal peso-sollievo, e così inoltrarsi nel mondo indecifrabile, imparare una nuova lingua, sembra impossibile. Ma poi si va e si impara, soli al mondo, a testa alta nelle tempeste, proprio come Enea.”
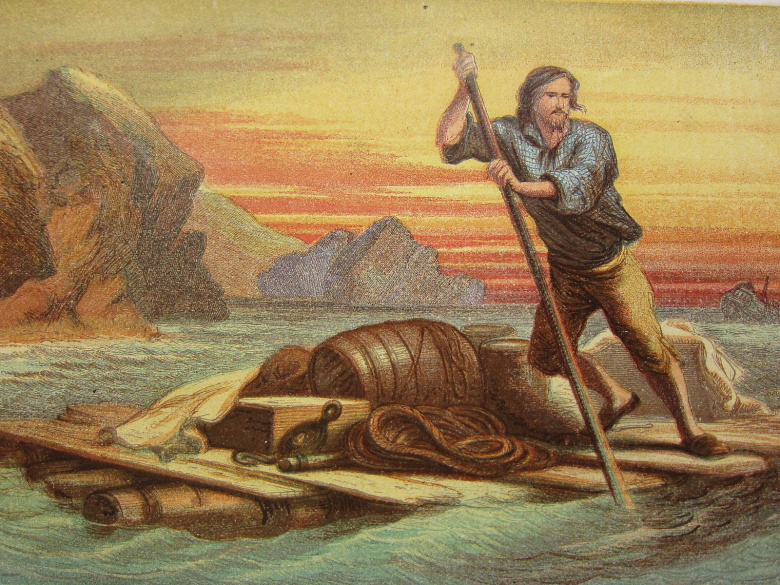
C’è un eroe che giustamente non compare nella galleria di figure del capitolo “eroi senza famiglia”, perché lui una famiglia ce l’ha. È Robinson Crusoe, il protagonista del celebre romanzo di Defoe. Lo ricordo perché anche lui nelle pagine iniziali del romanzo prende congedo dal padre, non senza avere ascoltato, con apparente devozione, il sermone del genitore che tenta un impossibile ravvedimento del figlio.
Robinson è fermamente deciso a imbarcarsi per i Mari del Sud ma il padre lo vuole trattenere illustrandogli i privilegi della sua classe sociale di appartenenza, la “Classe Media, ovvero ciò che si può chiamare la condizione superiore della vita inferiore, da lui giudicata per lunga esperienza come la classe migliore del mondo, la più conveniente alla felicità umana, per nulla esposta alle miserie e alle pene, alle fatiche e alle sofferenze che affliggono i braccianti dell’umanità. Al tempo stesso sottratta ai tormenti dell’orgoglio, del lusso, dell’ambizione, dell’invidia che affliggono le classi alte dell’umanità”.
Questa orazione casalinga, capolavoro ideologico fondativo del ceto medio, è destinata al fallimento. Robinson partirà e imparerà a stare solo nel mondo e a cavarsela senza le garanzie e i privilegi che il padre si è prodigato di illustrargli nel loro ultimo colloquio.
Tra gli “eroi senza famiglia” sono molto belle le pagine dedicate al capostipite Lazarillo de Tormes: “Andavo così ramingo di porta in porta con ben scarsi frutti dato che la carità se ne è risalita in cielo, quando il caso mi fece imbattere in uno scudiero, che veniva per strada, pettinato e vestito con grande decoro e dai modi impeccabili”.
Sarà il suo nuovo padrone, perché i miseri avventurieri come lui nei padroni trovano dei padri putativi.
Barry Lindon, Renzo Tramaglino e Tom Sawyer sono figure segnate dall’assenza paterna ma proprio perciò libere di inventarsi un futuro. Di Renzo Tramaglino Ficara sottolinea un tratto notoriamente tragicomico: la sua inesperienza del mondo, la sua ingenuità è anzitutto riconducibile alla sua inadeguatezza retorica. I suoi errori nascono dalle parole sbagliate, quelle che appaiono inadatte alla situazione: “fate di questi discorsi tra voi altri, che non sapete misurare le parole” gli dice pretestuosamente l’Azzeccagarbugli.
A questa rassegna di avventurieri dell’anima, spesso ignari del loro destino ma animati da un irrefrenabile desiderio di vita, fa seguito un gruppo di poeti per i quali la relazione con il padre è stata nei modi più diversi occasione di introspezione lirica. Tra questi Leopardi, a cui Ficara ha dedicato negli anni studi importanti, e che qui ci presenta nella sua relazione con il padre Monaldo.
Sono pagine di rara eleganza che sanno dare del padre del poeta una dimensione per certi aspetti inedita, sottraendola alla vulgata corrente che lo presenta come una figura priva di umanità, ottusamente bigotta, un arido erudito totalmente insensibile alla sofferta ricerca poetica di Giacomo.
Eppure, le lettere di Monaldo al figlio non contengono soltanto raccomandazioni morali, o insegnamenti teologici. Vi si trovano inaspettatamente osservazioni che pare traggano ispirazione dall’antropologia settecentesca, dallo studio del commercium mentis et corporis:
“poiché siamo di spirito e di corpo, bisogna accordare anche a questo la parte sua, e vivere qualche poco alla carlona, mangiando e dormendo quando e quanto il corpo domanda discretamente, persuadendoci che la ragione deve guidare l’istinto, ma non sopprimerlo, e che per essere troppo ragionevoli qualche volta si opera contro ragione”.
“Monaldo sensista, materialista e magari epigono di La Mettrie?” si chiede Ficara. I precetti paterni non persuadono tuttavia il figlio geniale, non ne spengono la sofferenza. L’irenica conciliazione tra l’anima e il corpo gli appare anch’essa un’illusione.
Il vero punto di ancoraggio che sa offrire al figlio poeta stabilità nel mare incerto della vita è la disciplina della forma. L’esattezza dello stile, come osserva acutamente Ficara, “è per lui una seconda natura e l’insufficienza di uno stile che si accinge a essere e non si adempie, o il suo mero voler essere, gli sembrano peggiori dell’assenza totale di stile”.
La disamina poetica della figura paterna, a cui Ficara ha dato voce spaziando dalla letteratura antica, dai poemi omerici fino al Novecento, si chiude con Simone Weil e il suo misticismo logico: “Dio e nulla, per lei, si inseguono e confondono insistentemente”.
In questo viaggio originalissimo alla ricerca dell’imperfezione paterna leggiamo in filigrana un riconoscimento alle prerogative della letteratura, alla sua funzione conoscitiva, alla sua peculiare valenza filosofica, che risiede nella capacità di umanizzare l’ideale e nello stesso tempo di idealizzare l’umano costruendo quel ponte tra l’idea e la contingenza che scalza ogni visione dualistica, riportando la bellezza entro i confini dell’esistenza.
Se «Padre» è un nome che implica la fede, come ritiene Lacan, il padre nella letteratura non è un dio della lontananza ma della prossimità, un dio udibile, comprensibile, che piange la partenza del figlio come accade a Monaldo quando Giacomo decide di recarsi a Roma: “Figlio mio, voi siete per la prima volta solo in mezzo al mondo”.