Una nuova serie di traduzioni / Ivy Compton-Burnett. Più donne che uomini
Periodicamente qualche benemerito editore mette in cantiere il rilancio di Ivy Compton-Burnett, la grande Signorina, per usare la denominazione ormai canonica di Alberto Arbasino. Ogni volta sembra quella buona. E ogni volta quella buona davvero lo è, perché passa il tempo e ogni rilettura di ciascuno dei suoi libri porta qualcosa di nuovo, come si conviene, e un intatto piacere per l’intelligenza. Semmai stavolta è l’intelligenza a difettare ai tempi. Ma i tempi non sono tutti noi. E quindi eccoci qui, voi ed io, a renderle l’ennesimo doveroso omaggio, e a rallegrarci di noi stessi come lettori.
A vent’anni dall’ultima proposta di un suo romanzo (Un’eredità e la sua storia, trad. E. De Angeli, Adelphi, 1999), ora, nel cinquantennale della morte (27 agosto 1969, a 85 anni) l’editore Fazi ha annunciato una nuova serie di traduzioni e comincia con quella, per mano di S. Tummolini, di Più donne che uomini, del 1933, quarto dei 19 romanzi (più uno ripudiato, Dolores, del 1911) che la scrittrice con cadenza grossomodo biennale ha licenziato a partire dal 1925: la storia di un collegio femminile di fine 800-inizio 900, della sua fondatrice e direttrice, Josephine Napier, della sua famiglia, che prevedibilmente nasconde segreti a lungo ignorati ma che stanno per venire a galla in una concatenazione inesorabile, e del corpo insegnante. Per una volta un collegio raccontato dalla parte di chi lo governa e vi lavora e non di chi, giovane, ne subisce i rigori, e gli orrori, come abbondantemente raccontato per quel periodo da Musil, Rilke e Walser, per citare solo alcuni dei casi maggiori.

Ancora uno spazio circoscritto, per non dire asfittico, come in tutti i libri della Signorina: country houses spesso un po’ fatiscenti o bisognose di cure, come le sostanze dei loro proprietari, abitate da famiglie allargate che si estendono almeno a tre generazioni; vere e proprie istituzioni totali dove succede, mai direttamente sulla scena però, praticamente di tutto: incesti, tradimenti, figli segreti, conflitti per il patrimonio e l’eredità, morti auspicate e, talvolta accidentalmente (ma non si sa mai…) come qui, provocate, e tutto il repertorio classico che dalla tragedia antica, passando per il teatro elisabettiano, arriva, volendo, fino al feuilleton ottocentesco e alle telenovelas odierne. Niente di nuovo, niente di diverso. Come dice la signorina Luke, una delle insegnanti di Più donne che uomini: “Ah, ma queste sono le cose primordiali! L’amore tra uomo e donna, il matrimonio, la maternità. Le cose non toccate dalla civiltà, primitive, immuni da quel che si chiama progresso”. Il nucleo degli eventi, quasi immutabile e elementarissimo, è quello. Tragedie tra le trine, di solito raccontate e commentate in modo svagato, con quel “gelo letale” che secondo Manganelli è il fondamento stilistico della scrittrice, durante il tè pomeridiano o davanti a un camino, in salotto, in cucina o in sala insegnanti. Tutto è basato su inverosimiglianze spacciate per normale routine, coincidenze e piccole forzature a cui nessuno bada o che tutti fingono di non vedere, nell’apparente omogeneità dei giorni, dove i fatti rilevanti sono pochi e avvengono fuori scena o in tempi remoti, e nessun cambiamento si profila né si auspica, fino all’evento imprevisto, di solito un arrivo o un ritorno inatteso, che darà una sterzata al tran tran quotidiano. È un mondo centripeto, sempre sull’orlo dell’implosione. Gli spiragli sono pochi. Più donne che uomini, però, forse perché sono le relazioni femminili a dominare è, nonostante la sua quota di drammi di prammatica, una delle poche, parziali eccezioni.
L’azione è il discorso. Tutti non fanno che parlare, spiattellando a viso aperto la ferocia su cui poggiano e prosperano le buone maniere, deputate a contenerla e renderla accettabile in ogni società e a maggior ragione in quella, rigidamente gerarchica e formalizzatissima, narrata dalla Compton-Burnett.
Tutti i romanzi sono ambientati prima della prima guerra mondiale, che anche per la sua vita personale costituirà l’inizio delle tragedie famigliari: dal fratello amatissimo morto in guerra, alle due sorelle che si suicidano poco dopo, alla vita domestica di cui prima Ivy aveva subito i rigori e la scarsa affettività e che poi dovrà governare a sua volta con rigore… Il recinto storico dell’epoca vittoriana-edoardiana è indagato nelle sue peculiarità sociali e nelle sue regole e contraddizioni, nessuna delle quali viene trascurata, senza essere però tematizzata in modo frontale, se non raramente (ma in questo romanzo la condizione femminile, l’educazione, i rapporti gerarchici e i legami regolari o meno consueti sono spesso oggetto di discorso, franco e senza indulgenze, sotto il velo dell’ossequio alle convenzioni); esso infatti delimita uno spazio che più che riflettersi in un resoconto storico, crea una specie di bolla fuori dal tempo in cui le vicende narrate acquisiscono una risonanza che le proiettano, o ribaltano, in una dimensione più ampia, per non dire universale: e certo, per quanto estranei certi formalismi ci possano sembrare oggi, lontani e artefatti come le forme dei discorsi di molti personaggi shakespeariani, nondimeno sembrano parlare, proprio in virtù della loro distanza, e non a discapito, esattamente di noi, qui e ora.
E comunque, sembra dire la Signorina, non cambierebbe nulla, perché così stanno le cose. Le storie sono poche, e si assomigliano tutte, come dirà presto anche Beckett.

Il dialogo, questo fatuo intrattenimento infinito, funziona “come cortina fumogena”, dice benissimo Paolo Ruffilli nell’introduzione a Fratelli e sorelle (Garzanti, 1982). Le chiacchiere fanno da “riempimento sonoro di uno spazio per svuotarlo, contemporaneamente, dei suoi contenuti”. Dicono tutto e non comunicano, alla fine, niente. Si parla per evitare di soffocare nel silenzio, e insieme per impedire che esploda e si squaderni nelle parole che davvero dicano e vadano a effetto costringendo le persone e le relazioni a cambiare, cosa che però accade comunque, prima o poi.
Invece del classico “less is more”, qui sembra vigere l’opposto “more is less”. Si parla tanto per dire poco. “Meno si dice, meglio è, afferma Josephine, per velare quello che ha bisogno di essere velato e salvare la faccia di chi ha bisogno che gliela si salvi. È una questione di decoro.” “Mi sento a disagio con la gente la cui vita è un libro aperto. Ho tanto in me da dover nascondere”, dice altrove Felix.
La matrice degli eventi procede in totale autonomia e le vittime designate precipitano senza fare resistenza incontro al loro destino, al quale tutti gli altri guardano con scarsa partecipazione, convenienze a parte, per rimettere in moto il meccanismo che li condurrà a esiti identici. Bene. Ma quello che conta è tutto il resto, come su questo telaio si dispongono non gli eventi o i personaggi, ma le parole, i discorsi di cui essi sono i meri strumenti, anziché, come nella restante letteratura, i portatori e responsabili. La loro psicologia è ridotta all’osso e funzionale ai discorsi. Parlano tanto di sé e degli altri interlocutori, come se avessero accesso al loro intimo, e in realtà i tratti psicologici e esistenziali sono solo quelli, pochissimi, necessari ai discorsi per potersi formulare e rispondere, dibattere e combattere, l’un l’altro. Fini tremende e indolori, e che suscitano emozioni risicate, doverose, anche se a volte plateali, quando appunto la forma lo esige. Poi amen. Capitolo chiuso. Compiuto il giro, cambiato il minimo indispensabile (ma chi ricorderà davvero com’era prima?), il mondo riprenderà a girare su se stesso dando l’impressione di essere immobile.

E infatti il mondo non cambia, pare abbia risposto la Signorina a chi le chiedeva del perché dell’ambientazione limitata a quel ceto sociale, che spazia da una piccola nobiltà di campagna spesso in difficoltà a una borghesia professionale o intellettuale che non si sforza nemmeno troppo di migliorare – anche se in Più donne che uomini c’è l’orgoglio di un’attività creata e allargata con il proprio lavoro e per i proprio meriti –, e uno è meglio che parli di ciò che conosce bene e lo indaghi a fondo. La fantasia ha i suoi limiti. Ma lei, all’interno dei suoi, apparentemente ristretti, ne dimostra tantissima. La fantasia non consiste solo nell’invenzione di chissà che storie e paesi e figure mirabolanti, ma negli scrittori si caratterizza principalmente come capacità di riempire le pagine di sfilze di parole (frasi) sorprendenti, emozionanti, divertenti e illuminanti. In questo Ivy Compton-Burnett è seconda a pochissimi.
“Possiamo, dalla nostra fantasia, far nascere un mondo molto utile. Non so perché la menzogna non operi bene come la verità” [dice Jonathan a Felix, amico e amante, dopo che alcuni dei misteri della storia hanno trovato una prima spiegazione]. “Spesso opera meglio; per questo ci se ne serve.” Felix si interruppe e i due amici scoppiarono a ridere. “(…) Mi fa piacere credere che sono stato l’intimo amico di un mascalzone.” … “Tu hai un avvenire di innocenza davanti a te.”
Il numero dei personaggi di Più donne che uomini è insolitamente numeroso e la scrittrice, dopo aver sbrigato in poche righe il ritratto di ciascuno, comincia quasi subito a farli interagire nel suo tipico torrenziale susseguirsi di dialoghi senza indicare le cesure né i locutori, che spesso si sovrappongono e confondono, come figure di uno stesso coro, distinguendosi solo sporadicamente, ove la caratterizzazione è proprio indispensabile. I discorsi toccano i più svariati argomenti con un ritmo così serrato di battute che il lettore è spesso disorientato, incerto se esserne più ammirato o annoiato. Una cosa non esclude l'altra, del resto: è il piccolo dramma dell’aderenza al dettato, a cui il fuoco di fila delle battute a volte costringe. La distanza ha i suoi vantaggi.
Infaticabili chiacchieroni coatti, i personaggi, senza eccezione, si esibiscono in squisiti esercizi di algida perfezione che alcuni vorrebbero fosse pura grazia, sul filo dell’inconsistenza (quella che in passato si chiamava l’arte della conversazione, consistente nel farcire il vuoto della convivenza con quello, raffinato, delle parole); come se fossero sopra un solido terreno, quello delle convenzioni, mentre invece sotto è tutto un brulicare di nefandezze (che non è tragedia, perché non esiste tragedia al tè alle quattro) che fluttuano nel vuoto.
È la letteratura innalzata all’arte, sublime, del pettegolezzo, da dove tutti congiurano a scalzarla con nobili intenzioni: le peggiori, come si sa.
I commenti della voce narrante sono rari e, anche quando sembrano una descrizione o la narrazione di un dato di fatto, hanno l’effetto di una stilettata inferta al malcapitato di turno con serafica malignità; o con vero candore, che in genere è peggio. Nei rari casi in cui invece lo sguardo è, altrettanto pacatamente, benevolo, resta come il sospetto che la benevolenza non valga tanto di per sé, come elemento tra gli altri del reale, quando come complemento necessario della malizia, che la completa e le è inseparabile, e che allora può essere sottaciuta, con un senso antifrastico a cui il distacco o l’ostentata oggettività conferiscono una rilevante percentuale di indecidibilità. Lo stile è il trionfo di quello che Flavia Ravazzoli (citata in Serena Cenni, Il sortilegio della parola, Bulzoni, 1989) chiama “‘l’asse attenuativo’ [che] comprende tutte le figure della negazione, della reticenza, della (pseudo)contraddizione… litote, allusione, eufemismo, disfemismo, preterizione, ironia” in tutte le sue sfumature, dalla malizia all’indifferenza alla ferocia, e persino all’indulgenza.
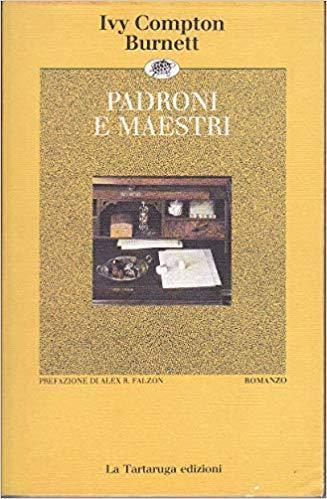
Più donne che uomini riprende l’ambientazione in una scuola privata del primo romanzo della scrittrice, Padroni e maestri (1925, trad. N. Rosati Bizzotto, La Tartaruga, 1992, con prefazione di A. R. Falzon). Con esso condivide anche la presenza dell’omosessualità, non clamorosa ma esplicita e vissuta senza la vergogna che la società del tempo quanto meno pretendeva, tollerandola se vissuta con discrezione, nel privato risaputo ma sottaciuto, salvo condannarla anche penalmente, come Oscar Wilde ha avuto modo di verificare, quando veniva allo scoperto in modo sfacciato. A parte la relazione ventennale tra il fratello di Josephine, Jonathan, padre di Gabriel, e Felix Bacon, rampollo amabile e arguto di una famiglia nobile locale, che poi però sposerà una delle insegnanti del collegio per continuare la dinastia in rispetto della tradizione: Edipo che non vede l’ora di rientrare nei ranghi alla morte del padre che in precedenza aveva fatto di tutto per deludere pur considerandolo figura inarrivabile di riferimento (ma appunto per questo: in conflitto finché vive; introiettato in tutto e per tutto, finalmente cannibalizzato una volta assurto alla vera dimora delle divinità, da dove non dovrebbero mai assentarsi: in cielo); a parte questa tra i due uomini, anche tra le signorine insegnanti, l’enigmatica signorina Rosetti, avrà modo di confessare, dopo aver detto di provare affetto per Josephine, che “la [sua] felicità dipende tutta dalle donne”.
E donne sono spesso le figure dominanti, nonostante la società vittoriana fosse patriarcale da cima a fondo, e quasi sempre quelle che assumono tratti positivi, da Mildred di Il buio e la luce (trad. di Alfredo Tutino, La Tartaruga) a Josephine e la signorina Rosetti in questo romanzo.
Come sono affascinanti pur nella loro sgradevolezza queste donne oltremodo rette, rigide e glaciali quanto passionali nel fondo accuratamente celato, formalmente impeccabili sia nel comportamento che nelle parole anche quando dicono verità sgradevolissime, laceranti, crudeli persino, e che proprio per questo possono esercitare il dominio il più inflessibile e più vessatorio ammantato da interesse per l’altro, da grande generosità verso il destinatario, cioè il vessato, la vittima, in genere uno stretto famigliare, e che cadono in piedi anche quando si direbbe cha abbiano le ginocchia spezzate, la messinpiega impeccabile nonostante le durissime batoste! Che carattere manifestano anche nel più crudele strazio!, senza cedere alla disperazione, almeno in pubblico, o nominandola nello stesso momento in cui si mostrano tetragone, e rifiutando la compassione mentre sembrano esigerla, quantomeno come atto dovuto, esso pure formale e ciononostante sentito, o così significato attraverso i segni sociali di prammatica. Terribili!, macchine da guerra e sensi di colpa, non fossero i loro interlocutori protetti dalla stessa corazza formale, gelide e raggelanti… che vien però da rimpiangere nella nostra deriva di strazi esibiti, e tanto meno sentiti. Da ammirare, anzi.
Non che gli uomini, sgradevoli lo siano meno. Con l’aggravante che, titolari di beni e quarti di nobiltà, o dell’autorità e dell’indipendenza che la tradizione garantisce loro anche quando meno se la meritano (e anzi, spesso in ragione inversa), fanno ciò che vogliono senza pensare alle conseguenze o fiduciosi di farla comunque franca qualora i misfatti o i capricci o le sventatezze a cui induce la sensualità (un maschio è pur sempre un maschio…) venissero allo scoperto. Quando sono costretti a confessarlo, pretendono di essere scusati (sono fatti così, et donc!). Raramente sono delle carogne, ma la somma delle loro debolezze provoca effetti peggiori che se lo fossero, specie quando di nascosto cercano di porvi rimedio. E non cambia se, come in Più donne che uomini, l’uomo è l’omosessuale Jonathan, che però da giovane ha provato a copulare secondo i crismi con il peggior risultato possibile, un figlio indesiderato, con una partner a sua volta omosessuale, per amor di simmetria, e tanto poco materna da non volerne sapere del figlio, scaricato al padre che a sua volta lo scaricherà alla sorella, la quale invece, in maniera neanche troppo sorprendente, lo amerà moltissimo nel modo in cui amano queste donne, leggermente giocastesco, ma assoluto, e quindi opprimente.

Le donne al fondo sono quasi tutte perfide (per natura o per necessità, non si sa…), anche quando dolci, sia con i figli che pure adorano (mai tutti con la stessa intensità però, a dispetto dell’esteriore equanimità), sia soprattutto con le figlie, amate con il sentimento di riserva e spesso asservite ai loro desideri presenti e alle necessità future, e ancor più verso le altre femmine, quelle più interessanti e meno scipite, viste come avversarie e fraudolente rapitrici, potenziali o reali, dei figli (come in questo libro, da parte di Josephine, la figlia dell’ex fiamma del marito, che stranamente, una volta tanto, del marito non è figlia, come avviene in altri romanzi: ma come avrebbe potuto benissimo essere), e potenziali autrici delle nefandezze di cui le faranno invece oggetto loro, giocando d’anticipo. In Più donne che uomini però c’è anche una sottile rete di connivenza e simpatia tra la direttrice e le insegnanti, e la malizia affiora senza soverchiare la stima e a volte persino un’inconsueta simpatia. Tutto normale. Tutto il gran volersi bene tra donne che sembra oggi corrente, la sorellanza trionfante, è venuto dopo. In epoca vittoriana la bontà era ancora in cammino.
Gli oggetti del loro affetto, comunque sia declinato, ci mettono niente a essere tramutati in oggetti (e quindi in insolvibili debitori) dei loro sacrifici e benefici, di cui l’amore non è che un aspetto che le convenienze impongono di non enfatizzare nell’istante stesso in cui viene accennato, o alluso, a buon intenditor… Basta uno sgarbo. Un abbozzo di contraddizione, o la tracotanza della scelta indipendente: come la decisione Gabriel di sposare quella sbagliata. Come se ce ne possa mai essere una giusta. Mostrare, controvoglia ovviamente, di accettarlo, non sarà che l’inizio di una nuova lotta. Continuons le combat!
L’arte materna del ricatto, come noto, conosce sottigliezze che nemmeno la diplomazia eguaglia. Il double bind si raddoppia in infinita partenogenesi. Una delle forme predilette è quella che viene prodotta di rimbalzo, rinfacciando mentre si fa mostra di elogiare. L’elogio, si sa, è il ricatto più efficace. Perché è buono.
Non sarà tuttavia possibile evitare di farne uno alla grande Signorina, qui. Senza malizia, però. O no? Vedete voi. Arbasino, e altri con lui, si sono chiesti: ma la signorina sapeva? Intendendo se era consapevole della sua assoluta singolarità e della straordinaria e rivoluzionaria coerenza del suo stile rispetto al romanzo tradizionale (perché una volta, e non solo tra gli avanguardisti, era diffusa questa stramba idea: che un romanzo tradizionale ci fosse). È importante avere la risposta? Quanto alla scrittrice come persona, può restare sospesa all’infinito. È certo invece che i suoi libri lo sapevano eccome. Basta leggere poche pagine per verificarlo.







