Come non diventare famosi
Viviamo nell’era delle ricette facili. Ci lasciamo rassicurare dalla promessa di poter imparare a giocare a scacchi in dieci minuti, scoprire le tre regole d’oro per far soldi, sostenere una conversazione su La Recherche senza averla letta, scolpire il corpo con soli cinque minuti di esercizio giornaliero e dominare la mente grazie a un corso di tre ore (sei lezioni). C’è un tutorial per tutto: per riparare il manico di una pentola a pressione senza correre il rischio di farla esplodere e per diventare resilienti, empatici e assertivi; per imparare a fare qualcosa e per imparare a essere qualcuno. Potrebbe sembrare un titolo clickbait, l’ennesimo prodotto della moda motivazionale, Come diventare famosi. La scienza segreta del successo di Cass Sunstein (Cortina, 2025). Ma non lo è: non è una guida, non è un manuale, ma un saggio critico che si interroga sulle ragioni profonde che fanno emergere un prodotto culturale, una persona, un oggetto e lo rendono famoso. Cosa hanno allora in comune, al di là delle evidenti differenze di superficie, Bob Dylan, i Marvel, Gesù, la Gioconda, il MacBook Air, i Beatles e Jane Austen? Perché persone altrettanto valide, quadri bellissimi e oggetti ben fatti non si sono affermati? Perché i Beatles e non i Dave Clark Five? Perché Jane Austen e non Mary Brunton? Il mondo è pieno di “lost Einsteins” e “forgotten Superstars” – come recita il sottotitolo originale del volume – che non sono riusciti a fare breccia nell’empireo delle star.
Spoiler: la prima regola per avere successo è essere consapevoli che non esistono regole per avere successo – è questa la tesi centrale del volume. E ce ne dà conferma il mondo stesso del marketing e del branding, dove, nonostante l’impiego di tecniche raffinate e sondaggi sofisticati per intercettare i trend, anche gli esperti si trovano spesso a dover fare i conti con risultati inattesi. A volte prodotti su cui si scommette si rivelano clamorosi flop; altre volte, quelli inizialmente sottovalutati finiscono per diventare fenomeni planetari – come nel caso emblematico di Star Wars raccontato nel libro. A volte il successo può giungere all’improvviso per poi rivelarsi effimero, oppure maturare lentamente, esplodere decenni – o secoli – dopo la creazione. Alcune opere godono di un trionfo commerciale pur essendo considerate di scarso valore dalla critica, altre conquistano elogi entusiastici ma non riescono a incontrare il favore del pubblico.
Con uno stile accattivante, fatto di domande dirette e complicità con il lettore, Sunstein intreccia studi scientifici, ripercorre i risultati di esperimenti sociali (come il celebre Music Lab sulla viralità dei brani musicali), racconta aneddoti personali e riporta ricostruzioni biografiche, invitandoci a diffidare delle spiegazioni semplicistiche. Nella seconda parte del volume si concentra su casi esemplari, ricostruendo carriere, snodi fondamentali e traiettorie di successo. Storie affascinanti e ben documentate, che hanno il sapore delle favole e raccontano di persone comuni, quando non specificamente disagiate o sfortunate, che spesso proprio nel momento in cui stanno per toccare il fondo, per abbandonare un’ambizione, per intraprendere una strada diversa, risalgono la china. Bob Dylan, da esordiente rifiutato a Nobel per la letteratura; i Beatles, scartati dai discografici prima di diventare icona planetaria; e tanti altri.
In termini molto goodmaniani, Sunstein non si interroga tanto su cosa sia il successo quanto piuttosto su “quando” sia il successo, chiedendosi a quali condizioni – relative nello spazio e nel tempo – un prodotto, un oggetto, un’idea, una persona, un luogo riescano a imporsi. Lo fa a partire da una serie di netti rifiuti: il rifiuto del determinismo (non esiste una formula – “la regola d’oro” – per il successo), del fatalismo (non basta il caso), dell’ottimismo motivazionale (non è vero che è sufficiente impegnarsi per farcela). Consapevole che la qualità non è garanzia di successo, ma anche che il caso da solo non basta, Sunstein oscilla tra il riconoscimento della forza autonoma di certi talenti e la coscienza che l’affermazione di quel talento dipende da tante variabili esterne. Ne risulta un quadro instabile e stratificato, popolato da faide, effetti di rete, slanci del caso, colpi di genio e piccole grandi sfortune.
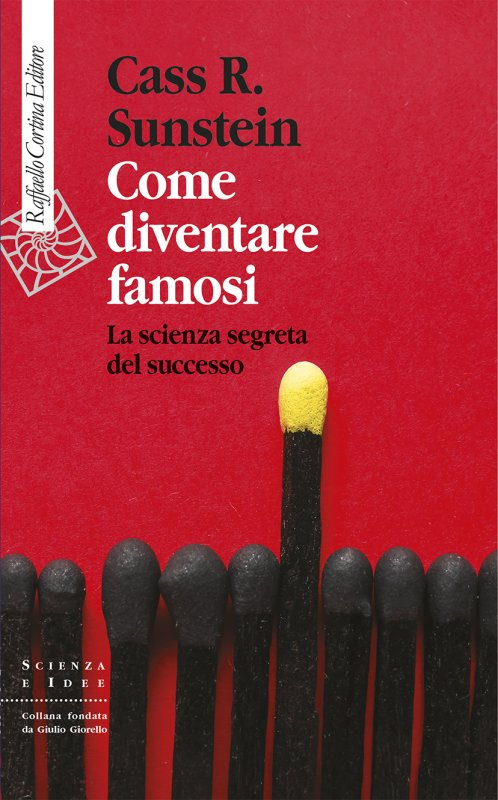
A co-concorrere per la via del successo sono tanti elementi, che, variamente combinati, assumono di volta in volta uno peso specifico differente. Può intervenire innanzi tutto l’incidente, qualcosa che per caso fortuito accade: un incontro, un impedimento, una congiuntura favorevole possono agire da detonatori del talento. “Che cosa sarebbe successo se non fosse accaduto questo…?” è una delle domande ricorrenti – evidentemente senza risposta – che pone Sunstein quando racconta dei Marvel, di Cassius Clay o di Taylor Swift. C’è poi la qualità, condizione necessaria ma non sufficiente della fama – e forse neanche troppo necessaria per un successo di breve durata come alcuni di quelli a cui siamo abituati. Ci sono tratti della personalità, come la caparbietà, l’ambizione, la costanza, la creatività che sembrano caratterizzare chi ce la fa. Ci sono fattori sociali, come la sintonia con lo Zeitgeist, l’aderenza allo spirito del tempo – concetto più volte evocato nel libro, ma anche spesso messo in discussione (come definirlo? e siamo sicuri sia davvero determinante?). Certo, va constatato come talvolta il successo arrivi postumo, proprio perché lo spirito del tempo è cambiato ed è diventato più ricettivo verso una certa proposta. D’altro canto, la mutevolezza dello Zeitgeist mostra quanto il successo sia relativo e culturalmente mutevole. Ne è esempio la memoria collettiva, continuamente costruita e ricostruita, che può trasformare nel tempo un eroe nazionale di chiara fama in un vituperato colonialista sfruttatore – Black Lives Matter docet.
Il successo richiede anche una certa sensibilità nel lanciare nel mercato culturale un prodotto che sia innovativo ma non troppo, riconoscibile ma non scontato. Ogni fare è un rifare, sosteneva Goodman, nel senso che ogni nuova invenzione attinge sempre, in maniera creativa, da un repertorio di conoscenze antecedenti. Il troppo nuovo respinge, il troppo noto annoia. Equilibrio difficile da trovare e questione di certo interesse di questi tempi. Secondo alcuni ottimisti, infatti, è proprio per l’incapacità di muoversi in questo spazio intermedio che l’intelligenza artificiale, almeno per ora, non riesce a produrre veri contenuti di successo. Basandosi sull’apprendimento e sulla riproposizione di elementi rassicuranti e in un certo senso già (troppo) noti non è in grado di sorprendere davvero. Stan Lee invece innovò eccome il modo di concepire il supereroe, pur conservandone alcuni tratti classici. Così, attraverso tentativi, intuizioni e qualche errore, diede vita all’universo Marvel – come racconta Sunstein – differenziandolo da quello tradizionale degli eroi DC: un mondo popolato da protagonisti fallibili, talvolta goffi, profondamente umani. Il resto è storia.
E poi c’è l’effetto San Matteo, concetto che Merton conia e Sunstein riprende a partire da un versetto del Vangelo di Matteo (“Poiché a chiunque ha, sarà dato ed egli sovrabbonderà; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha”). Si tratta di quel meccanismo per cui chi ha già visibilità tende ad averne ancora di più. Un vantaggio competitivo in grado di generare cicli virtuosi – o viziosi, a seconda del punto di vista – di successo. Lo si ritrova in letteratura, nello spettacolo, persino nella scienza (si pensi al principio della premialità accademica) e funziona come una cascata: chi ha già un credito viene collocato in un punto da cui ogni ulteriore successo è più facile. Più un caso diventa noto, più se ne parla, più le informazioni circolano, più la notorietà cresce e la fama si consolida – in fondo è il principio su cui si fonda la figura (il successo?) dell’influencer. Quando si punta l’occhio di bue su un caso, si genera un interesse che si autoalimenta: anche se non è il mio genere non posso non andare a vedere Barbie al cinema, perché non posso non saperne parlare.
E il successo si nutre del continuo passaggio dall’online all’offline, con videoclip che fanno il paio con concerti dal vivo, corsi in rete che si abbinano a eventi di team building, comunità di consumatori che si incontrano alle manifestazioni promosse da un dato brand, estimatori di serie tv del momento che organizzano una visione collettiva della première. Il fandom, su cui fanno leva sempre di più produzioni audiovisive e non solo, costruisce e ricostruisce brand, carriere, oggetti di culto e, insieme, rafforza il senso di identità dei partecipanti. Il prodotto culturale si trasforma in prodotto cultuale, e il fan in adepto. Quando si accende Spotify non si ascolta semplicemente una canzone, ma si esprime il proprio sistema di gusti (musicali) e più in generale ogni atto di consumo è un atto di espressione identitaria, che allo stesso tempo corrobora quel senso di appartenenza a un’élite simbolica. Sunstein la chiama polarizzazione di gruppo.
Come diventare famosi è un libro che non ci spiega come sfondare, ma ci aiuta a comprendere perché certi fenomeni sfondano e altri no. È un invito a cogliere la natura relazionale e instabile del successo. Al bando le ricette facili, dunque, e con esse la linearità, le soluzioni lampo e i risultati garantiti. Più che una formula, il riconoscimento critico di una rete di successo, che, come ogni rete, ha i suoi nodi, le sue interruzioni, le sue asimmetrie.
In copertina, fotografia di Jakob Owens.







