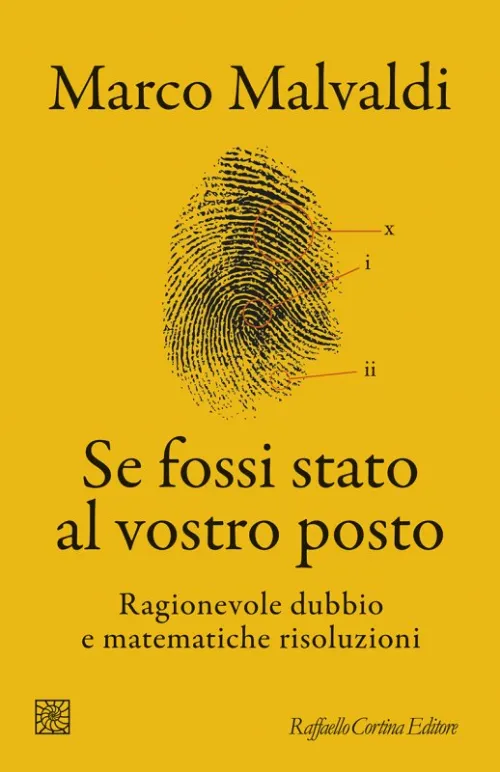Malvaldi: occhio alle percentuali!
La tavolozza cromatica del genere letterario ‘giallo’ ha subito nel tempo alcune variazioni. Inizialmente i suoi confini erano legati a una precisa epoca storica, erano netti, rigidi, sorti sulla scia dei “feuilleton” ottocenteschi, centrati esclusivamente sul delitto, sulle indagini basate sul metodo logico-deduttivo con cui smascherare il colpevole. L’esigenza di sicurezza contro la devianza, la vittoria dei buoni sui cattivi, il trionfo della società sana ma ferita dal crimine, era la ragione, tra le molte, del successo di quel genere letterario, non sempre raffinato ma dilagante. Nella seconda metà del diciannovesimo secolo la società stava subendo una profonda trasformazione anche attraverso lo sviluppo tumultuoso dell’industrializzazione, mentre la crescita della popolazione urbana favoriva l’aumento della delinquenza. Sotto la spinta di movimenti come il positivismo, però, i fenomeni criminali venivano affrontati con la fiducia di poterli spiegare (e punire) scientificamente. In questa cornice culturale e filosofica anche gli autori di “gialli” confidavano che le azioni umane fossero prevedibili e quindi rispondessero a determinate leggi che consentivano di venire a capo di misteri che nella sostanza erano solo apparenti. Quei confini però con gli anni si slabbrano e diventano vischiosi. Ai paradigmi classici quali la ricerca della verità con schemi enigmistici, il tributo alla genialità, il bisogno di ristabilire l’ordine violato se ne aggiungono altri. Filtrano nuove riflessioni sulla crisi della Città generatrice di devianza, sulla valutazione dell’ambiente circostante, sul dramma della vittima ma anche del colpevole. A queste si uniscono le difficoltà crescenti nel cogliere gli eventi con la sola logica, anche per l’incrinarsi della fiducia nella scienza conseguente alla tesi rivoluzionaria di Heisenberg del principio di indeterminazione. Crescono le paure e le angosce, si dilata l’ansia di giustizia, il lettore rabbrividisce di fronte alle pulsioni aggressive ed è portato a invocare la punizione.
Marco Malvaldi con il recente saggio Se fossi stato al vostro posto (Raffaello Cortina, 2025) si inserisce in questa dimensione storica e in particolare sulla prima fase e cioè sul razionalismo illuminista di Dupin, il detective di Edgard Allan Poe. Questi, come segnala l’autore, si impegna nella spiegazione deduttiva attraverso resoconti di crimini e indagini, ravvisando nello studio dei numeri un aiuto forse decisivo alla risoluzione dei problemi. Il suo obiettivo è mostrare come la teoria delle probabilità possa aiutare a ricostruire un fatto criminoso. Perciò prova a scandagliare le cronache relative, ad esempio, all’assassinio di Mary Cecilia Rogers. Il legame con il ragionamento matematico è stretto, come già rilevato in passato (Toffalori Il Matematico in Giallo, Guanda 2008) e diviene protagonista nei racconti “Racconti del mistero e del raziocinio” di Poe. Malvaldi, con Poe, si propone di evidenziare come narrazione e calcolo statistico possano, e forse debbano, intrecciarsi per ricostruire i fatti e stabilire le responsabilità. Nell’alternarsi di esempi e paradossi il saggio intende far emergere la ragione per cui questi due linguaggi, apparentemente diversi, siano indispensabili per confrontare le versioni, valutare le prove e prendere una decisione.
Ma è così nella realtà quotidiana? Lo scritto di Malvaldi suscita una riflessione immediata ed inevitabile. Come stanno effettivamente le cose oggi nella realtà quotidiana dei tribunali? Giudici-investigatori-avvocati in carne ed ossa lavorano e ragionano così? E se le cose non stanno così, questo avviene per scelta o per mancanza di preparazione scientifica? Il saggio rappresenta la realtà oppure immerge un problema giuridico nelle seducenti atmosfere letterarie, entrando a far parte degli studi su “Diritto e letteratura”? E ancora, se di probabilità si parla a quale si riferirebbe la vita processuale quotidiana? A quella oggettivo-statistica basata sul calcolo della frequenza dell’accadere, oppure a quella soggettiva, cioè al “grado di credenza” sulla possibilità che un evento si realizzi o si sia realizzato?
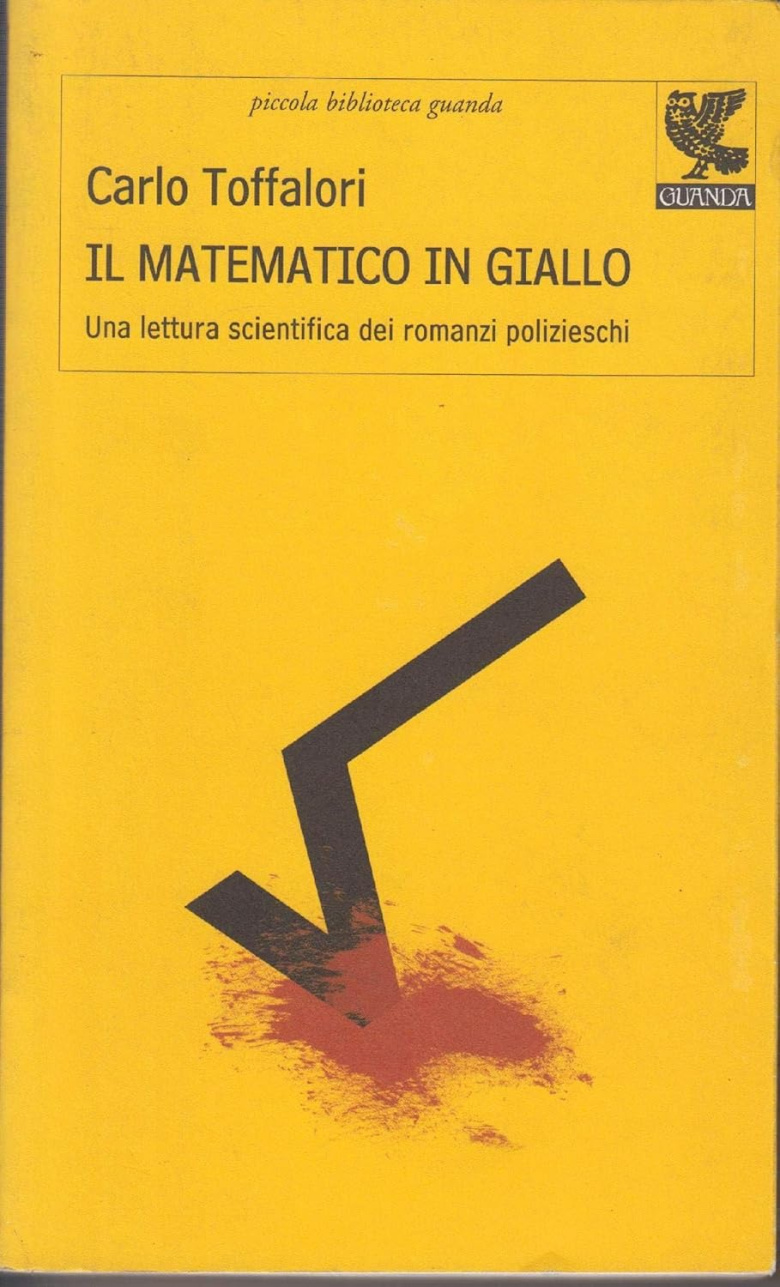
Nelle aule giudiziarie di questi anni la bussola per chi deve decidere è il “libero convincimento”, decisiva conquista di autonomia, nel lontano passato, per sfuggire all’ingerenza del sovrano. Questa libertà non è però assoluta e perché non degeneri in arbitrio si richiede sia «razionale», non a caso indicando questo termine come la “misura dell’incertezza di un fenomeno del quale non si possa predicare né la falsità (o inesistenza) né la verità assoluta (o esistenza)». L’obiettivo è raggiungere una narrazione plausibile, sensata, proiettata verso la verità in quell’antico rito sociale, il giudiziario, incaricato di determinare l’eventuale colpevolezza e la conseguente punizione. Ma di quale verità si parla, di quella assoluta o di quella relativa? La ‘veritas’ dei romani, inoppugnabile perché proveniente dalla fede (di qui l’anello nuziale, la vera, chiamata anche ‘fede’) che conduce al ‘ ver-detto’, oppure la ‘aletheia’ dei greci che implica uno svelamento e una scoperta? Le tensioni inevitabili si concludono sempre con la vittoria laica di un tribunale terrestre, di operatori giuridici che ritengono di poter superare gli ostacoli e non si fermano davanti ad essi. Quindi il convincimento si forma senza imposizioni, ricostruendo i fatti e valutandoli “ragionevolmente”, utilizzando il metodo ‘epistemologico’ della conferma, confutazione o falsificazione delle ipotesi, affidandosi al contraddittorio tra le parti e alla possibilità di produrre prove contrarie. Il fatto storico, non avendo natura scientifica, non è ripetibile in laboratorio e può rivivere solo attraverso le tracce lasciate. Ed ecco il problema cruciale: come valutare le prove? Con quali criteri? Quale è il livello di prova necessario per condannare “al di là di ogni ragionevole dubbio” come stabilisce il codice (art. 533 c.p.p.)? Il termine “ragionevole” già designa un percorso e un obiettivo che rifuggono dall’assoluto. L’attenzione si sposta così dal probabile al provabile, cioè al ragionamento concreto in cui “non è consentito dedurre dal coefficiente di probabilità statistica” alcuna automatica conseguenza. La decisione giudiziale si fonda sul “verosimile”, sulla “ragionevolezza” che permette di scegliere la versione più plausibile e così porsi come garanzia contro ogni arbitrarietà. Se si apre uno scarto tra “essere vero” ed “essere considerato vero” si deve rinviare alla nozione di “accettazione”, per cui in base a sufficienti elementi è razionale accettare come vera la proposizione del ragionamento. Altro criterio è la coerenza che, non potendo assicurare la verità, costituisce una “presunzione di verità” da combinare con gli elementi che la convalidano. Pertanto la “verità” è costruita sulle informazioni disponibili, su un risultato che nasce dal confronto tra diverse narrazioni, una delle quali razionalmente più credibile e idonea per la decisione. La “verisimilitudine” è poi l’approssimazione alla verità, e gioca un ruolo rilevante con altri parametri per chiarire come verità, probabilità e contenuto informativo delle diverse ipotesi interagiscono fra loro per determinarne l’accettabilità razionale dell’ipotesi. Nel libero convincimento, cui si accennava, entra la prova statistico-probabilistica? La risposta oggi è molto incerta per varie ragioni. Una è che un modello processuale scientifico non può e non è in grado di misurare il “quantum” probatorio di partenza, senza il quale non è possibile procedere a calcoli di sorta. Come precisato, «delle statistiche nude non si deve generalmente tener conto nel dibattimento penale, salvo alcune eccezioni» specificatamente previste dalla legge. Inoltre «il giudice deve accertare una relazione su un singolo caso e non su un insieme di casi, come nella statistica».
Sono necessarie regole (gli standard) che determinino la soglia oltre la quale si considera una ipotesi come “provata”, come “giusta” e cioè socialmente accettabile, quantunque sia una verità solo “apparente”, un “simulacro”, qualcosa di inevitabilmente nascosto. Inoltre non si può sottovalutare lo squilibrio dell’onere sulla prova, cioè le maggiori difficoltà per la difesa e l’agevolazione per l’accusa.
La fondatezza dell’ipotesi accusatoria non può basarsi sulla frequenza con cui l’evento da provare viene osservato. Pertanto, per rendere processualmente fruibile una prova statistica, occorrerebbe “individualizzarla”, per cui non è consentito «dedurre automaticamente e proporzionalmente dal coefficiente di probabilità statistica la conferma dell’ipotesi».
Per quanto ancora sarà come oggi? Il domani cosa riserva?
Sempre e comunque, lasciando in disparte i numeri e le aule dei palazzi, vale un’osservazione. Gli attori giudiziari, investigatori, giudici, avvocati sono pervasi e forse anche dominati da una sensazione di incertezza, inevitabile quando le decisioni riguardano le persone. Come gestire questo stato d’animo nello scegliere varie ipotesi sul tappeto, come confrontarsi con ‘il probabile’? (Capone, Universo letterario del probabile, Bollati Boringhieri, 2022) ed anche con il caso, con quel tiranno che sembra dominare la complessità del mondo ostacolando la comprensione degli accadimenti (Giannoli, Il caso, un tiranno, Franco Angeli, 1986)?
Nella ricerca di chiavi di lettura che nutrano i fatti di ‘ valore probatorio’ è comprensibile che non venga abbandonata la richiesta di scientificità per uscire dalle incertezze soggettive. Alcuni tentativi sono stati avanzati per rendere il ragionamento legato a parametri quantitativi, e taluno (tra tutti di recente Tribe) ha teorizzato con tiepida fortuna il “probabilismo giuridico”. Con esso si ritiene auspicabile utilizzare strumenti, come i metodi matematici e il calcolo della probabilità, che consentano di pervenire a risultati rigorosi. Le obiezioni non sono mancate, centrate sui problemi già noti, e cioè sulla difficoltà di misurare quantitativamente la probabilità degli avvenimenti, sul problema del come quantificare il “valore probatorio” della decisione individuando le regole relative al grado di credenza o accettazione.
E si arriva così agli algoritmi, alla meccanizzazione del giudizio su cui ci si è già intrattenuti (vedi qui “Giustizia digitale”). Tra quelli sperimentali uno dei più noti è il Compas (Correctional offender managment profiling for alternative sanctions), (ampiamente su questo tema vedasi Filippone, “Il caso Compas e il tema della giustizia predittiva, tra opacità e distorsioni”, in Aequitas Magazine, 2025), adottato da alcune Corti americane per prevedere su base statistica la probabilità della recidiva, cioè della ricaduta nel reato, e per quantificare la pena. Attraverso l’inserimento di dati oggettivi concernenti il passato criminale, le condizioni socioeconomiche e personali dell’imputato e ben 137 domande, Compas misura il rischio di recidiva come basso, medio o alto. Non solo: è utilizzato anche per calibrare l’intensità del controllo dei soggetti in libertà vigilata,
Il saggio di Malvaldi è stimolante perché coglie un’esigenza effettiva, cioè come superare l’incertezza nel decidere giudiziario. E con questo obiettivo l’autore intreccia specialismi differenti che cercano di capire il presente con l’aiuto del passato e guardando al futuro. Purtuttavia, scorrendo quelle pagine, il pensiero melanconico e grato va a a quella bussola di orientamento antica, popolare, equilibrata, resistente agli anni, raramente sconfitta, del ‘buon senso’. E di esso si sono serviti con successo in tante storie i vecchietti del Bar Lume, creati dallo stesso Malvaldi. E possiamo aggiungere, non solo da loro.