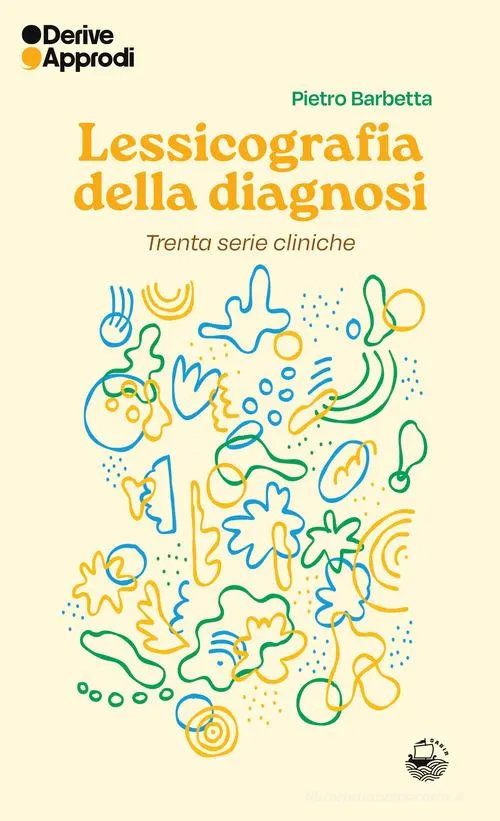Pietro Barbetta: le parole delle diagnosi
Scrive Pietro Barbetta: “Diagnosi unisce due termini: il prefisso dia-, attraverso, come ad esempio nel caso di dialogo – discorso attraverso l’altro –; il suffisso -gnosis che ha a che fare con la conoscenza. Letteralmente diagnosi significa conoscenza attraverso l’altro, con l’altro; indica una relazione di conoscenza reciproca”.
Lessicografia della diagnosi (DeriveApprodi, 2025) è un viaggio attraverso i modi in cui la diagnosi è pensata e narrata nel mondo occidentale e oltre, un excursus mirato a esplorare i sintomi in contesti diversi, proponendo una visione transculturale dei metodi terapeutici: nel mondo violento e antimetaforico che ci troviamo ad abitare non semplifica e non risolve, propone il dono della molteplicità epistemologica, la gentilezza della relazione umana, l’attenzione ai nodi attuali del sapere. Barbetta, durante tutto il libro, insegue i “luoghi comuni” della psicodiagnostica non per il piacere sovversivo di demolirli o di capovolgerli ma per la curiosità di vedere quali altri “luoghi della diagnosi” durante il cammino terapeutico sono diventati visibili. Le classificazioni tradizionali del DSM, più che essere inesatte, si mostrano inefficaci come strumenti di diagnosi se la prospettiva diventa transculturale. Già Deleuze, in Critica e clinica, aveva demolito il concetto di “deficit” nella schizofrenia per esplorare le diverse ricchezze che al contrario ci offre lo “stato delirante”.
La posizione critica verso la diagnosi significa rifiutarla come logica classificatoria oppressiva, ma questo rifiuto non apporta elementi nuovi. Se si riesce a vivere la diagnosi come luogo d’incontro fra scienza, arte e filosofia, se la si colloca in un’atmosfera che coniughi insieme riti, medicina classica, antropologia, poesia, psicoanalisi, otteniamo un quadro sfaccettato, complesso, rizomatico, che ci guida verso territori da mappare ancora, lontani dal paradigma delle opposizioni, e dove filosofia e clinica si intrecciano come flutti di mari diversi ma simili. Qui cito un esempio della sua riflessione: “A Matte Blanco, come psicoterapeuta, interessa comprendere l’altro sistema logico dell’inconscio e del delirio, che rinuncia all’ipotesi asimmetrica... In altri termini: mentre il delirio contempla anche la logica gerarchica delle asimmetrie, la logica formale esclude il delirio della logica simmetrica”. L’autore smonta la diagnostica del potere con perentoria chiarezza. Il suo metodo traversa molti saperi e non si blocca in considerazioni evidenti o risolutive. Ogni soluzione è la morte della ricerca appassionata. Barbetta mappa la verità per strati, per “persone”, con il minimo di schemi: i temi trattati – malinconia, angoscia, ossessione, ciclotimia, spaltung, tossicomania, borderline, adolescenza, infanzia – sono creature vive, portavoci di una loro irripetibile storia. L’idea che lo sostiene è quella del viaggio, dell’ascolto, in sé e fuori di sé. “Qualcosa che ci insegnano i filosofi: si tratta di porgere l’orecchio, entrare in relazione con l‘orecchio dell’altro, creare oto-biografie. Oto-biografia – da ous, orecchio – indica l’assunzione di una postura di ascolto curiosa, che metta in sospensione la conoscenza certa, acquisita. Come ci si dispone di fronte alla lettura di un romanzo, di una poesia, o alla visione d’opera teatrale, di un film. Non si tratta solo di auto-biografia, né semplicemente di biografia, il prefisso oto- di oto-biografia – come suggerito da Jacques Derrida – indica un flusso che parte dalla bocca dell’uno e giunge all’orecchio dell’altro. Qualcuno giunge a me, mi chiama con il mio appellativo: ‘Dottore, sto soffrendo’”.
La psicologia transculturale si occupa della normalità, di dove si nasconde e di come si differenzi dalla non-normalità. La diagnosi del sintomo non è un lavoro neutrale. Non bastano i sintomi clinici a insegnarci una buona diagnosi differenziale. Un soggetto malato è un soggetto complesso, inclassificabile, non risolve enigmi diagnostici. Esiste, per Barbetta, un pensiero del fuori, un sintomo che reagisce a qualcosa che accade “da fuori”: al corpo sintomatico, chiuso nei limiti del suo malessere, subentra un corpo narrativo, che sappia raccontare la sua storia a chi lo curerà. “Le vicende di Pierre Rivière, negli anni Trenta del secolo XIX, sono singolari: sgozza la madre, la sorella e il fratellino. L’omicidio sconvolge i giudici che chiedono consulenza ai medici per valutare l’infermità mentale del giovane; chiedono inoltre a Rivière di redigere una memoria delle ragioni dei suoi gesti... il soggetto si fa giudice in un tribunale della mente, che prepara meticolosamente, gli strumenti, i modi e l’evento dell’omicidio”; di Pierre Rivière parla, per la prima volta, Michel Foucault in uno dei suoi libri fondamentali: “Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello”. Il gesto di Pierre, premeditato dal suo pensiero delirante, non è giudicato come atto alieno, separato dalla sua persona, ma “comprensibile” nell’ordine “altro” della sua mente, in quella “vita degli uomini infami” (è il titolo di un libro di Foucault) dolorosamente libera dai canoni.
La “comprensibilità” è un tema chiave nel libro di Barbetta: l’autore non si arrende alle spiegazioni riduttive o astratte di un trattato sintomatologico. Le sue storie, dove etimologia, antropologia, narrazione e pratica clinica si intrecciano, sono perturbanti proprio perché sviluppano un dialogo a più voci anche dove sarebbe naturale e legittimo il silenzio. L’autore parte dalla visione di un mondo mai arido o schematico ma ricco di analogie, immagini, risonanze: “L’arte della memoria rinascimentale, in particolare in Giordano Bruno, consiste nella coltivazione di sinestesie, che, a loro volta, evocano una visione del mondo sintagmatica, in cui le similitudini prevalgono sul paradigma delle distinzioni […] Il mondo delle similitudini prevede un sapere composto da analogie, vicinanze, contiguità, forme e colori, un mondo pieno di sinestesie”.

Barbetta utilizza un metodo conoscitivo che non si accontenta di spiegazioni parziali. Chi leggerà il libro sarà affascinato dall’ampia panoramica del suo sguardo fluttuante e curioso, clinico ma non solo. La “lessicografia della diagnosi” è una modalità di conoscenza che non consente di immagazzinare verità assolute, in vista di qualche scopo clinico o terapeutico. Tutto il sapere, anche quello relativo alle variabilità delle diagnosi, è interpretabile, non consegnato alla solidità di una definizione indiscutibile. In una delle “serie cliniche” analizzate nel libro l’autore si trova a parlare di una paziente, “Irma la smemoriosa”, una donna resa inerme e catatonica dall’uso prolungato di psicofarmaci, e del tutto chiusa al mondo. Alcuni psichiatri interpretano queste “chiusure” come “atti di finzione”, come “disturbi fittizi”, in definitiva simulazioni.
Leggiamo invece Barbetta mentre descrive la “Sindrome di Ganser” di cui soffre Irma: “La Sindrome di Ganser viene descritta dall’omonimo psichiatra tedesco Sigbert Ganser osservando le condotte di alcuni detenuti in attesa di giudizio nelle carceri […] Chi viene privato brutalmente della libertà, come nella contenzione psichiatrica, può diventare estraneo a se stesso al punto da provare una vergogna che lo conduce al ritiro dall’esistenza. Ganser osserva che non si tratta di finzione, a meno che non si ritenga che una persona possa fingere un disagio fino a lasciarsi morire o, come nel caso di Irma, a non riconoscere più la realtà della vita quotidiana che le sta intorno. Irma subisce il trauma della contenzione psichiatrica, il crimine di pace più efferato. La prova? Ogni volta che le si chiede la data di oggi, Irma risponde con la data del giorno del ricovero psichiatrico. Il tempo della sua vita si è fermato là”.
In questo caso, osserva l’autore, essere “estranei a se stessi” non è una condizione interiore, esistenziale, da risolvere con una terapia psicologica o psicoanalitica privata, ma un fatto che esiste, calato nel trauma del “fuori”: la contenzione, la violenza subìta. Senza cadere in un determinismo causa-effetto lo sguardo dello psichiatra, plurale, aperto, coraggioso, assume su di sé la sofferenza dell’altro, e rappresenta e descrive la storia di chi è “altro da noi” ma “consuona” con noi.
La via verso l’analisi delle libere associazioni è tracciata: “Le libere associazioni sono questo: ascolto il sogno altrui, a volte assopito, distratto, disattento come uno scolaro negligente, che non si è coricato presto la sera: ma nella mia disattenzione c’è qualcosa che punge, un punctum […] Chi sono mentre ascolto questi deliri onirici? Ho smarrito il principium individuationis, questo è forse l’ascolto di cui scrivono Nancy e Derrida […] essere l’orecchio dell’altro, avere una lingua che non è la mia, venire scossi, svegliati; questa è l’attenzione fluttuante […] il delirio è la vita che devia dal pensiero, è ricerca del senso singolare, connessione di elementi disparati, stream of consciousness”.
Con sottile ironia Barbetta accosta il punctum a qualcosa che “punge” e che irrita, svelando un senso di disarmonia. Si può includere l’impensabile nel pensiero? Si può, se non ci si inaridisce a costruire recinti che oppongano logica a follia. La schizofrenia, come afferma Matte Blanco, è un modo alternativo di pensare, e occorre accettare questa possibilità, considerando la dissociazione un modo radicale del dissenso. La psicodiagnosi è una biopolitica, e il suo stile non è evidente: lo troviamo viaggiando senza preconcetti, attraverso noi stessi, in questo mondo complesso e interconnesso, inventando un nuovo “dizionario della cura” che tenga conto dell’essere umano vivente in questo o in quel luogo, esterno o interno che sia: “dobbiamo guardare la psicodiagnosi con lo stesso sguardo che ha un etnologo mentre osserva un gruppo umano sconosciuto o un entomologo mentre osserva una specie di insetti nelle loro interazioni: la curiosità, il rispetto per un mondo meraviglioso”.
Se, in teoria, c’è la massima comprensione per il “disabile”, in pratica questa comprensione può trasformarsi in rimprovero se il terapeuta non usa il linguaggio in modo duttile, integrando e non discriminando. L’uomo è abituato a pensare per paradigmi e questo lo spinge nel territorio asettico della tecnica, illudendosi che la tecnica sia neutrale. Homo sapiens e homo demens devono invece intrecciarsi in un processo di circolarità e non di sottomissione l’uno all’altro. Si impara non dagli ordini della logica ma dalle risonanze che la relazione umana scatena, innescando cortocircuiti. Il sintomo psichico viene alla luce quando la logica dominante del discorso e l’impulso a essere liberi entrano in attrito. Non udire le “voci desideranti” che esprimono questo dissidio è simbolo di cecità terapeutica. Provare a trattare con esse, e con i sintomi che provocano, è il vero inizio del lavoro. Ogni conoscenza, ogni ipotesi psicodiagnostica, è un inizio che non prevede una fine e dovrà convivere con il proprio errare, con i propri errori: “nessuno può affermare che il trattamento psicoterapeutico di un malato lo guarisca, o ritardi il decorso del suo aggravamento. Quel che è in gioco è la singolarità: non si tratta di un trattamento medico particolare, ma di istoriare la vita, di avere uno spazio per raccontare”.