Gli scrittori italiani e la Bomba
Nel giugno del 1794 Immanuel Kant pubblicò sulla «Berlinische Monatsschrift» quello che è ancora oggi uno dei suoi scritti più misteriosi: La fine di tutte le cose. Alla base del brevissimo saggio – meno di una ventina di pagine – c’era la domanda sul perché «gli uomini si aspettano in generale una fine del mondo», di solito terrificante, e sul come sia legittimo concepirla. Ovviamente, un’immagine del passaggio dal tempo all’eternità è impossibile da costruire, perché all’uomo non è dato superare con il pensiero ciò che eccede l’esperienza. Per Kant, però, come sappiamo anche dalla più basica reminiscenza liceale, ciò che è impedito alla conoscenza speculativa può essere recuperato sul lato della moralità: così «l’idea d’una fine di tutte le cose trae origine non dal ragionamento sul corso fisico delle cose nel mondo, bensì da quello sul loro corso morale». Questa, dunque, la spinta a concepire il termine della corsa del mondo, e anche l’unico modo per immaginarlo, come tensione verso un compimento dei destini morali, che altrimenti rimarrebbero irrisolti e sporcati da una serie di mali, «ancorché siano in verità superati dai beni man mano crescenti».
C’è una pagina curiosa, in questo saggio, in cui Kant respinge con fastidio il «sistema di Lao Tze», che a suo dire fa coincidere il sommo bene dell’uomo con un annullamento-unione con il divino: quanto di più disdicevole, per lui, perché in quell’annullamento si dissolve ciò che meraviglia più di tutto e dev’essere preservato, «l’umana ragione». È in questo passaggio polemico che si sente soffiare un vento dall’abisso di non senso che altrimenti Kant ha tentato di tenere a bada anche nel pensiero della fine: non c’è annullamento beato, perché l’annullamento è silenzio, tramonto dell’uomo, schermo nero sullo sguardo che schiude il mondo.
Quella soglia dell’abisso, proibita alla speculazione filosofica, è proprio dove la letteratura ha cercato di stare, in particolare nel Novecento, quando le guerre mondiali e gli armamenti atomici hanno fatto capire che la fine di tutte le cose non era poi così impossibile da pensare. E che, per di più, non aveva niente a che fare con la moralità, ma quasi rendendo concreto il rovesciamento lacaniano Kant/Sade, ne era proprio la massima negazione. Come peraltro non aveva nulla a che fare con l’annullamento beato del sé – se poi in questo consiste il pensiero di Lao Tze. Maria Anna Mariani, con L’Italia e la bomba (il Mulino «Studi e Ricerche»), ha esplorato il modo in cui cinque scrittori della nostra contemporaneità – Moravia, Calvino, Morante, Sciascia e Pasolini – hanno deciso di stare su questa soglia, senza distogliere lo sguardo. E qui l’immagine della «soglia dell’abisso» ha un significato solamente contemplativo, perché – ancora una volta recuperando la questione della fine da un punto di vista morale – l’idea dell’annientamento del mondo impone una risposta che è proprio il contrario del rimanere a guardare da un limite sicuro, una sporgenza sul disastro. Il bystander, colui che «sta accanto» alla prospettiva della fine, è, in negativo, la figura chiave del libro: obiettivo comune dei cinque autori è scardinare la sua presunzione d’innocenza. Diverse sono le strategie e le «leve» utilizzate, comune è forse solo lo scacco, perché il bystander è ancora tra noi, i bystanders siamo noi – illusi da oltre un trentennio che la fine della guerra fredda e la «fine della Storia» à la Fukuyama avessero spazzato via la possibilità di un’apocalisse atomica. Distratti anche, non senza ragione ovviamente, dalla catastrofe ecologica di cui abbiamo avvertito in modo più acuto il pericolo, forse perché più assimilabile, nel suo incedere spietato ma più lento, dalla mente umana. Eppure, un senso d’inquietudine ha lasciato il segno nella vasta produzione di letteratura, televisione e cinematografia di marca distopica che ha caratterizzato gli ultimi decenni. (Anche se c’è da chiedersi di quale specie di inquietudine, e di reazione, queste opere siano portatrici – ci tornerò sopra quando parlerò delle pagine che Mariani dedica a Pasolini.)
La bomba, però, non è solo la pietra di paragone che permette di misurare l’engagement dei cinque scrittori verso le questioni del loro tempo, di cui quella nucleare è forse la più scottante. È anche una lente oscura ma molto potente, che permette di decifrare al meglio il loro modo di intendere la letteratura. Il lavoro di Mariani ha il pregio di evidenziare questo aspetto, che è evidente in modo particolare nel capitolo dedicato a Italo Calvino. Se si utilizza il tema della distruzione atomica come fil rouge si possono smontare luoghi comuni che ancora pesano sull’opera dell’autore delle Lezioni americane, testamento involontario che ha finito per inchiodare Calvino al tema della «leggerezza». Così come più di vent’anni prima Le Cosmicomiche, apparse in un momento di forti preoccupazioni ideologiche, aveva spinto molti commentatori a bollare il libro come una fuga dall’impegno. Quanto c’è di vero in questi giudizi affrettati ma destinati a resistere? Ben poco, ci dice Mariani, perché basta uno sguardo appena più attento per accorgersi che Calvino è «un intellettuale che ossessivamente conficca nella sua opera presagi di catastrofe». Non in senso nichilistico, ma proprio per risvegliare un senso di responsabilità che pare assopito, o meglio, sedato. Lo strumento è quello di riscoprire la paura, di recuperarla in senso positivo, in una mossa che Mariani assimila alla proposta di Hans Jonas nel Principio responsabilità (1979): una paura indirizzata non alla minaccia in sé (paura di), ma verso qualcosa che ci è assegnato in custodia (paura per). Calvino, dal canto suo, diffida dell’uso politico della paura (che ha portato all’ambiguo concetto della deterrenza, con cui ancora oggi ci confrontiamo, constatandone i limiti); così come diffida – e le cose sono collegate – dell’introiezione della paura come forma di difesa psicologica. Il rischio di entrambi gli usi è il logoramento del brivido, mentre esso ci deve stimolare da un punto di vista conoscitivo: portarci a riconoscere come la vita umana, che è effimera, deve farsi carico anche del non umano – il resto del vivente e le cose (gli oggetti, i manufatti), le durate abissali. Non solo, in senso quasi kantiano, preservare le tracce della ragione dell’uomo («proteggere l’archivio», come scrive Mariani), ma «allargare a dismisura la sfera della responsabilità» e «riconoscere la necessaria interdipendenza di umano e non umano». Quindi, anche spingere l’invenzione letteraria su scale di tempo che sovrastano la temporalità umana – e questa volta oltre, e anche contro, lo spirito kantiano – nel tentativo di raggiungere «un’ottica non antropomorfa», come disse lo stesso Calvino in un’intervista del 1978 con Daniele Del Giudice. È su queste basi, non su chissà quale desiderio di evasione, che nascevano Le Cosmicomiche (e il filone che ne sarebbe derivato). Un esito, quello di estendere l’immaginazione umana fin dove non sembra capace di arrivare (o dove gli viene impedito di arrivare dalla propaganda) non molto diverso da quanto emerge nella pratica letteraria di Moravia rispetto alla questione nucleare. Al netto di un atteggiamento sempre più disilluso verso la possibilità di cambiare le cose – obiettivo che lo spinse «controvoglia» a farsi eleggere al parlamento europeo – Moravia pare comunque cercare delle vie per «visualizzare» il disastro a venire, come ad esempio il racconto C’è una bomba N anche per le formiche (incluso nella raccolta La cosa, del 1983).
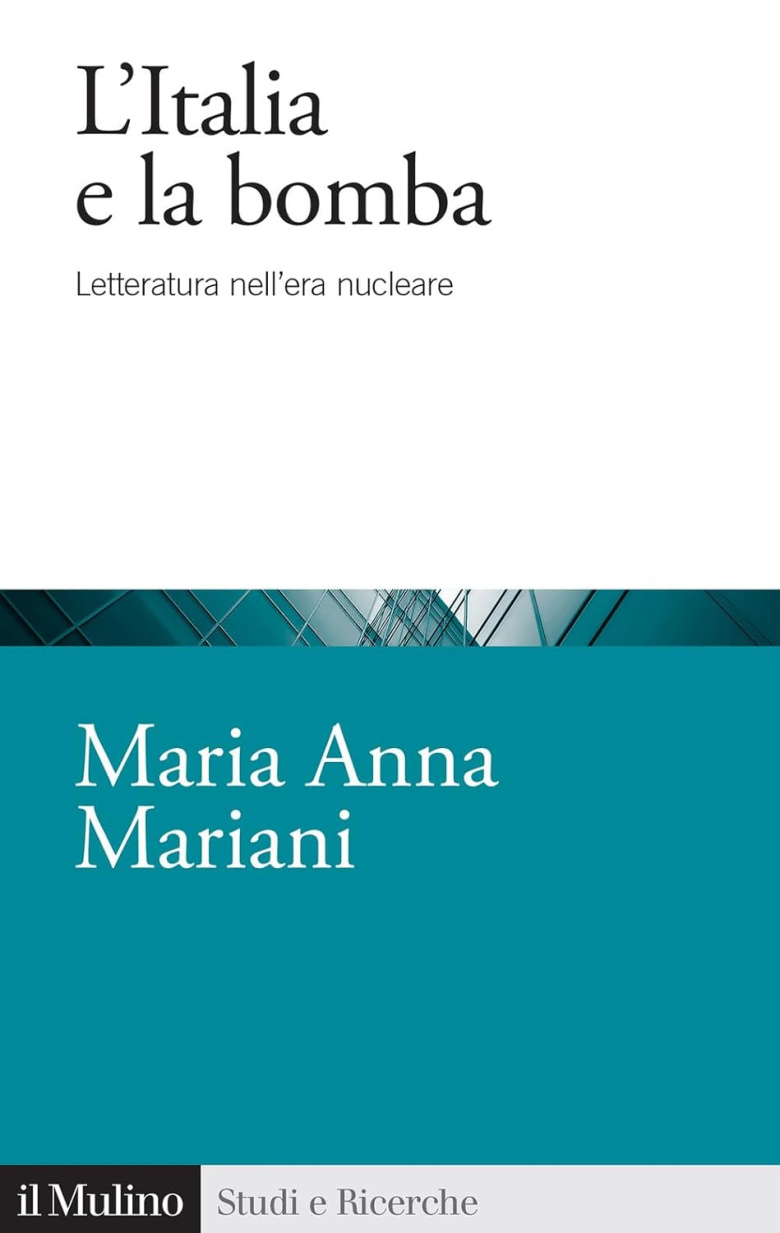
Il tema della normalizzazione della paura, e la necessità di un recupero del suo senso autentico, accomuna non solo Calvino e Moravia tra i cinque scrittori affrontati da Mariani. In tutti, si connette con la facoltà di immaginare oltre l’immaginabile, come può valere per il Majorana disegnato da Sciascia, che prevedendo le conseguenze delle proprie scoperte sceglie il ritiro dal mondo, l’inazione; oppure ha a che fare con la possibilità di scardinare associazioni mentali che diventano automatiche, e quindi anestetizzanti. Morante denuncia i tic linguistici (e visivi) che hanno portato a creare un’oscena familiarità tra distruzione e sessualità: Bikini, isola del Pacifico sede di test nucleari, diventa un tipo di costume da bagno, e «bomba sexy» il marchio della diva erotizzata.
C’è una linea – un nervo – che connette l’occhio e l’azione, politica e morale, come aveva compreso Sergej Ejzenštejn riflettendo sul montaggio cinematografico (e praticandolo). La giustapposizione delle immagini crea nuove metafore, nuovi significati, e questi provocano reazioni; Antonio Somaini, autore dell’importante saggio Ejzenštejn: il cinema, le arti, il montaggio (Einaudi 2011), ha scritto che per il regista russo si deve «montare l’opera per montare lo spettatore». Nel film-saggio La rabbia (1963), una delle sue opere forse meno conosciute e discusse, Pier Paolo Pasolini raccoglie le osservazioni di Morante e le filtra attraverso una pratica ejzenštejniana. L’obiettivo è un’invettiva sociale e politica ad ampio raggio, fatta attraverso spezzoni di filmati già esistenti, degli objets trouvés nel naufragio della civiltà occidentale: un mosaico che conserva però uno dei suoi apici emotivi e di significato nell’abbinamento tra il volto di Marilyn Monroe e il fungo dell’esplosione atomica. Se per larga parte del film la strategia di Pasolini è, attraverso accostamenti inattesi, la risemantizzazione delle immagini, in questo caso invece il regista-montatore procede esibendo sfrontatamente il nesso sessualità-consumismo-distruzione per cambiare lo sguardo dello spettatore, accendendo il suo spirito critico. Ancora una volta, Mariani è attenta a connettere le «negoziazioni» con il tema della bomba nucleare ad altri rami della produzione dell’autore che di volta in volta tratta. Per quanto riguarda Pasolini, è interessante ad esempio osservare che il metodo del montaggio – della giustapposizione dinamica di frammenti, della loro risemantizzazione e dell’invito etico rivolto al pubblico – è lo stesso con cui anni dopo sarebbe stata organizzata e concepita la raccolta degli Scritti corsari: «La ricostruzione di questo libro è affidata al lettore. […] È lui che deve organizzare i momenti contraddittori ricercandone la sostanziale unità». Questa in fondo è un’altra faccia della tensione verso forme non-chiuse che Pasolini avrebbe mostrato dal celebre saggio sulla sceneggiatura come «struttura che vuole essere altra struttura» (del ’65, poi compreso in Empirismo eretico) fino a La Divina Mimesis e Petrolio (usciti postumi).
Il nodo di montaggio che nella Rabbia lega insieme Marilyn e la bomba atomica ha come terzo filamento una sequenza di dipinti astratti di Jean Fautrier: nubi minacciose che sembrano privare lo spettacolo delle esplosioni atomiche di quanto conservano ancora di meraviglia fisica, per diventare solo i segni della peggior minaccia. Per Mariani, l’accostamento potrebbe evidenziare l’idea che osservare una catastrofe è ormai come guardare un bel quadro informale: entrambi, su uno schermo televisivo o dietro il vetro di una cornice, dominano i placidi interni borghesi. Una significazione perfettamente pasoliniana. In fondo, è lo stesso effetto che ci fanno le profusioni di narrazioni distopiche, origini di (rari) brividi da divano, più che di dilemmi morali. Ma, tornando al montaggio di Pasolini, se fosse possibile sopprimere la freccia del tempo, vi si leggerebbe una risposta a una provocazione ancora da venire: il frammento di un botta-e-riposta impossibile con Moravia, che nell’83, nel racconto citato sopra, smentiva l’Ecclesiaste in una delle sue formule più note: «non vi è nulla di nuovo sotto il sole». Non è vero – dice Moravia – perché dal 1945 qualcosa di assolutamente nuovo c’è, ed è la bomba: il Novissimo (il cristianesimo chiama così gli esiti della vita umana: il giudizio e l’aldilà) è la possibilità concreta della distruzione totale. Ma le nuvole esangui di Fautrier, piazzate nella sequenza da Pasolini, sembrano far parlare ancora l’Ecclesiaste contro Moravia, dicendo che anche il nuovo onni-distruttivo è una faccia del «soffio» di cui è intessuto il Tutto. O almeno, se non lo è del creato o dell’umano nel suo complesso, l’apocalisse atomica è l’estrema realizzazione di una civiltà, come afferma Morante: «La nostra bomba è il fiore, ossia la espressione naturale della nostra civiltà contemporanea, così come i dialoghi di Platone lo sono della città greca» (Pro o contro la bomba atomica, conferenza del 1965). Parole non troppo diverse da quelle che Martin Heidegger, con coscienza tutt’altro che pulita, aveva pronunciato in un’altra celebre conferenza, del ’49, dal titolo L’impianto: «L’agricoltura è oggi industria alimentare meccanizzata, che nella sua essenza è lo Stesso (das Selbe) della fabbricazione di cadaveri nelle camere a gas e nei campi di sterminio, lo Stesso del blocco e dell’affamamento di intere nazioni, lo Stesso della fabbricazione di bombe all’idrogeno». Non c’è separazione essenziale tra civiltà e barbarie; la tecnica che serve a far crescere è la stessa che permette di distruggere, in entrambi i casi su vasta scala.
Vorrei tornare, in conclusione, sul passaggio di Kant che ho riportato sopra: la stilettata contro il «carattere mostruoso» del «sistema di Lao Tze», che sembra auspicare l’annullamento dell’uomo, della sua personalità, nell’abisso del divino. In quelle righe si intuisce forse l’ombra di qualcosa che, nella sua eroica lotta con l’oscurantismo da cui si distaccava, l’illuminismo aveva dovuto mettere da parte: una forma diversa di ragione, di conoscenza. Per François Jullien, «il contrario della conoscenza è l’ignoranza, il suo contraddittorio è la connivenza». Una parola che in italiano suona male, che porta alla mente ignavia o assenso a qualche impresa malvagia. Insomma, una parola che sembra siglare alla perfezione l’atteggiamento del bystander. Ma proviamo a togliere dalle orecchie queste tonalità. Per Jullien, la connivenza indica invece «un sapere ombroso, che resta integrato in un ambiente, non si astrae da un paesaggio, non si estrae da un condizionamento, non separa la teoria dalla pratica né un “io” dal mondo». È un pensare fuori dalla modellizzazione – dalla conoscenza come rete gettata sulle cose. L’esempio del paesaggio è calzante, perché c’è paesaggio solo quando il soggetto che osserva riconosce un legame con l’ambiente che lo circonda: o meglio, il legame è la sola condizione perché si presenti un paesaggio. «La connivenza è questo sapere che non ha rotto il suo attaccamento. Il bambino nel grembo di sua madre non ha che questo sapere» (Essere o vivere, Feltrinelli 2016). Dunque, ciò che per Kant era difficile da udire, nella sua posizione e nel suo tempo, era proprio il suono di questo «sapere ombroso», che equivocava con una sorta di suicidio beato. Ma è proprio questo sapere che è necessario recuperare, soprattutto davanti alla minaccia della «fine di tutte le cose». La letteratura può aiutare a recuperarlo, come mostra in particolare l’esempio di Calvino: spostando l’immaginazione in una distanza apparente dall’uomo, non per disperderlo nel panorama, ma per farlo maturare insieme alle cose, insieme al paesaggio, nel suo grembo.







