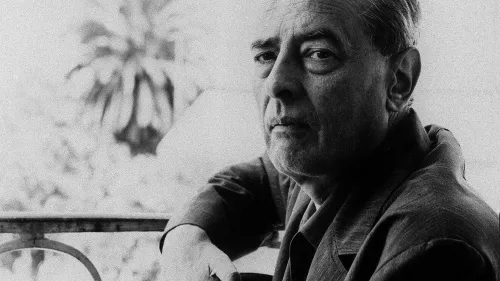A cinquant'anni dalla scomparsa / Gombrowicz o l’immaturità è il nostro destino
Il 24 luglio del 1969 moriva a Vence Witold Gombrowicz. E a Vence è seppellito.
Dopo aver vissuto l’infanzia e l’adolescenza tra i possedimenti terrieri del padre e Varsavia (era nato nel 1904 a Maloszyce, a duecento chilometri dalla capitale) e aver pubblicato una raccolta di novelle, Ricordi del periodo della maturazione nel 1933 e il suo primo romanzo, Ferdydurke nel 1937, sbarcò quasi per caso a Buenos Aires, dove lo scoppio della seconda guerra mondiale lo «bloccò» per circa ventiquattro anni. In effetti, la sua lunga permanenza in Argentina si deve meno a un blocco navale che a una sovrana indifferenza nei confronti dei destini del mondo. Non che gli fossero indifferenti le tragedie degli uomini. È che, da uomo concreto, non sopportava gli uomini che per servire una causa, giungevano al martirio, respirando inebriati le idee di Patria, Nazione, Popolo, Arte… Non sopportava nessun genere di impegno, a destra come a sinistra. Un’arte esplicitamente moralizzatrice o devota a nobili sentimenti per lui era un semplice controsenso: «Il vuoto? L’assurdo dell’esistenza? Il Nulla? Non esageriamo! Un Dio o degli ideali non sono necessari per scoprire il valore supremo. Basta restare tre giorni senza mangiare affinché un pezzo di pane diventi tale valore; i nostri bisogni sono alla base dei nostri valori». Non soffriva neppure “gli anticomunisti” di mestiere o i “dissidenti” di professione. Ne conobbe molti, soprattutto fra i suoi compatrioti, ai quali non risparmiò il suo feroce sarcasmo. Anche per questo, come per molti altri aspetti, la lettura del suo Diario, scritto tra il 1953 e il 1969, è oggi, post rem, estremamente rigenerante. Così come il suo Testamento (1968) scritto in collaborazione con Dominique De Roux.
Probabilmente in molti di quegli uomini Gombrowicz vedeva manifestarsi storicamente ciò che esistenzialmente aveva scoperto scrivendo il suo primo romanzo: che, cioè, l’uomo tende come un arco verso la Maturità, ma la freccia che quell'arco scocca e che inevitabilmente lo trafigge è quella dell’Immaturità. L’uomo che serve un’idea, un valore, qualcosa di molto più grande di lui, dissimula la sua stessa Immaturità e cade nella protervia e nella prepotenza dell’uomo di idee, di convinzioni. Cade cioè nell’infantilismo.
Mi viene in mente che in uno dei miei pellegrinaggi alla sua tomba, un mattino sentii delle urla invadere la quiete: al di là della siepe del cimitero c’era una scuola materna. Il creatore di Ferdydurke, anche da morto, era condannato a perpetuare la sua lotta.
Ricordate Shakespeare? «All is ripness». Tutto è maturità. Come raggiungerla?
Tutti i ferdydurkiani del mondo sanno che si tratta di una lotta infinita perché l’uomo si pensa sempre più intelligente di quel che è: «Più si sa, più si è stupidi». E così facendo non fa i conti con quanto riesce davvero ad assimilare. In altre parole, non fa i conti con ciò che lo forma, costantemente, senza tregua. Da sempre l’uomo è un creatore di forme. È perfino ciò che contraddistingue la sua natura rispetto a quella delle altre specie. Tuttavia, è allo stesso tempo un essere sociale e politico, il cui spazio d’azione è inevitabilmente «interumano». Tutti i nostri modi di esprimerci, di manifestare i nostri sentimenti, i nostri pensieri o le nostre opere sono formati e deformati da coloro con cui entriamo in contatto. Anche quando siamo soli ci specchiamo negli altri. La pace dell’essere ci è proibita, perché non smettiamo di divenire, di dare forma a noi stessi a seconda delle situazioni.
Gingio, il personaggio protagonista di Ferdydurke, a trent’anni si ritrova, grazie al professor Pimko, tra i banchi di un liceo. Deve constatare che il suo stato civile non ha più importanza. Il professor Pimko, gli altri studenti, il preside lo trattano come un adolescente. Il suo aspetto esteriore si è trasformato oppure il mondo è impazzito? Che fare? Quale dei due aspetti prenderà il sopravvento: l’immaturità o la maturità? Questa è la vera domanda, e su questa domanda si fonda il romanzo di Gombrowicz. Gingio attraverserà il mondo cercando una risposta: le tre tappe della sua avventura sono il liceo, la famiglia borghese dei Giovanotti e il castello di campagna. Nessuno lo aiuterà, nessuno si interesserà davvero alla sua ricerca d’identità. Un po’ quello che capita al personaggio di Rabelais, il grande progenitore, di cui Gombrowicz resterà sempre un lettore appassionato: Panurge non sa se sposarsi o no. Chiede responso a professori, a preti, a signorotti, a massaie, a chiunque, ma nessuno sa dargli una risposta. Nessuno è in grado di indicargli una strada per la maturità, che Panurge, innocentemente, pensa di potersi conquistare prendendo moglie.
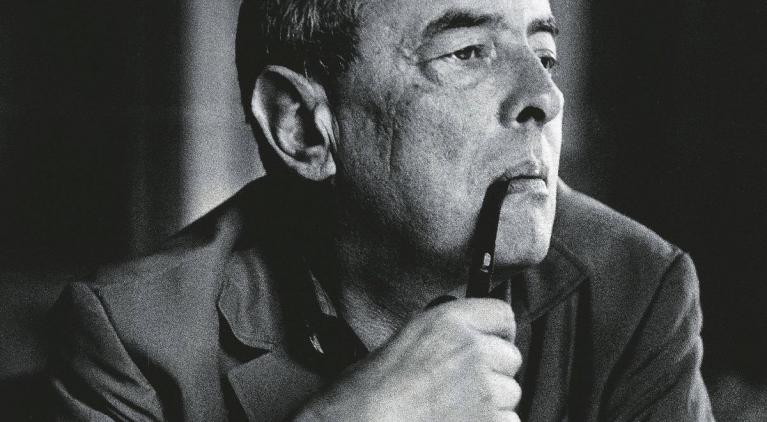
In effetti, l’esistenza, per Gingio, è un eterno «periodo di maturazione». L’immaturità è il destino dell’uomo: non sa perché è qui, in questo mondo, proprio in questa epoca e non in un’altra, non sa dove sta andando, l’avvenire è un enigma, il passato è corroso dalle termiti dell’oblio, la creazione è un mistero, la vita è una continua sorpresa. Quando ripete o ricorda un’esperienza non è mai sicuro di provare le stesse sensazioni, di conoscere meglio se stesso. La ripetizione di un evento non gli permette di elaborare una qualunque verità. Al contrario, Gingio è condannato a ripetersi in un eterno presente senza mai poter accedere al suo essere più profondo. Quasi fosse sprovvisto di memoria, è dominato dal demone del presente e dalla demoniaca presenza degli altri. Il suo corpo e la sua mente sono un campo di battaglia: è un essere in formazione o meglio in deformazione permanente, la sua forma dipende sempre dagli altri, deve sempre lottare per la sua maturità, ma allo stesso tempo combattere tale aspirazione che è in grado di infantilizzarlo. L’immaturità di Gingio è comica, ma l’uomo ferdydurkiano è tragico. Per Gingio non c’è tempo, non c’è pace, non c’è intimità, non c’è amore, non c’è nemmeno vera solitudine.
E non c’è scampo. Per tutto il romanzo il protagonista corre da un luogo a un altro, da una situazione all’altra, da un volto all’altro. Il romanzo finisce e Gingio sta ancora correndo. Come se Gombrowicz avesse presentito che la Storia avesse cominciato a quell’epoca del XX secolo – epoca di propaganda, di militarizzazione, di grandi miti (Violenza, Guerra, Gioventù), di scoperte tecniche al servizio di uomini in uniforme – a correre a una velocità superiore a quella dell’esistenza e che l’individuo in futuro sarebbe stato costretto a essere sempre in ritardo, sempre più incapace di lottare per la sua maturità, sempre più giovane, sempre più infantilizzato: un infante estasiato dalla velocità con cui la tecnica cambia il volto della Storia rendendolo irriconoscibile ai suoi stessi occhi di adulto.
Ed è quel che è successo negli ultimi cinquant’anni. Dalla morte di Gombrowicz.
Invece di fare i conti con la forma, con il fatto che non siamo esseri mai completamente formati, l’uomo, in nome dell’unica religione che gli è rimasta, il progresso tecnico, si è messo a formalizzare sempre di più il sapere, a renderlo sempre più astratto. «Il formalismo è un nemico mortale della forma», ha scritto Gombrowicz, intendendo che ogni formalismo che non sia controbilanciato dalla coscienza che ogni nostro sapere si gioca in uno spazio «interumano», dove le nostre «zone inferiori» hanno un ruolo decisivo, è destinato a creare un Sahara esistenziale. Un Sahara post-umano, algoritmico, tecnologicamente perfetto, popolato da esseri eternamente giovani, liberi dal peso di ogni esperienza storica.
«Non siamo dei, per questo scriviamo romanzi», diceva Ernesto Sabato, autore di un romanzo, Sopra eroi e tombe (1961), molto amato da Gombrowicz che, come è noto lasciò l’Argentina, salutando Virgilio Piñera e il piccolo gruppo di giovani che avevano contribuito a tradurre Ferdydurke in spagnolo, con un ironico: «Maten a Borges».
Aspiriamo alla purezza – alla Maturità, direbbe Gombrowicz – ma il romanzo ci riporta sempre a terra! Ogni conquista romanzesca è una conquista del mondo adulto, capace di sostenere lo sguardo di fronte alla relatività delle cose e alla comprensione imperfetta che l’uomo ha di esse. Ma essere adulti, secondo Gombrowicz, è tenersi sempre a una certa distanza – un passo à côté – dalle due insopprimibili aspirazioni umane: essere dio e essere giovani, essere immortali e essere continuamente freschi come rose.
Se il romanzo infine è per Gombrowicz un’arte e non semplicemente un genere letterario è anche perché il romanzo ha come missione quella di scoprire il mondo della prosa. La prosa, infatti, non è solo una forma del discorso distinta dalla versificazione, ma il volto quotidiano, concreto, momentaneo, «interumano», attraente proprio perché imperfetto, del mondo, alla cui continua formazione e deformazione dobbiamo restare fedeli per non cadere nell’assolutizzazione di verità tanto insostenibili quanto caduche.