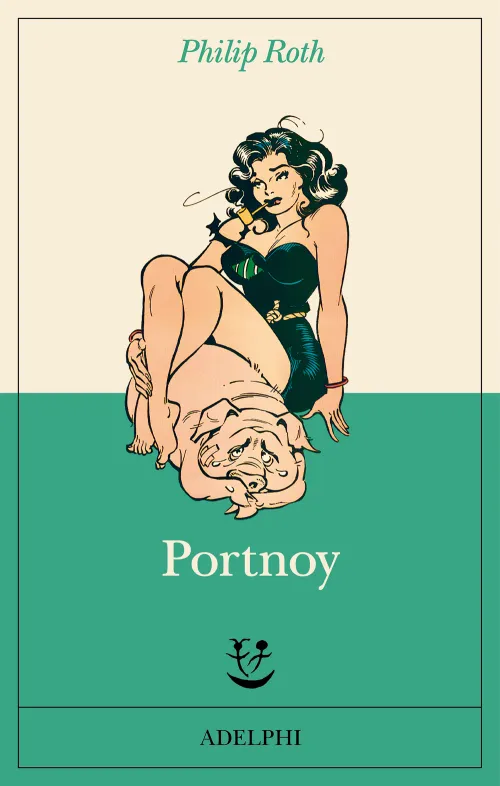Portnoy senza lamento
Il mio amico O. mi chiede: “Hai letto la nuova versione del Lamento di Philip Roth? Ti ricordi? Sin da quando eravamo ragazzi, negli anni Settanta del secolo scorso, quella meravigliosa bravata che è Portnoy’s Complaint (1969) non ha mai smesso di farci godere. In tutti i sensi… Non so perché, ma il traduttore ha deciso di intitolarlo solo con il nome del personaggio, Portnoy. Non capisco…”.
Goethe, nel 1819, in una lettera al critico musicale J. F. Rochlitz, scriveva che “ci sono tre tipi di lettore: il primo gode senza giudicare; il terzo giudica senza godere; il secondo giudica godendo e gode giudicando; è quest’ultimo che propriamente parlando ricrea l’opera d’arte”.
Sono passati due secoli, ma, fra le miriadi di teorie letterarie che a ritmo forsennato si sono succedute fino a noi, non ho trovato spiegazione migliore per descrivere i diversi tipi di lettore. Credo che soprattutto gli scrittori e i traduttori dovrebbero essere lettori del secondo tipo, far parte, cioè, di quella schiera, da sempre piuttosto ristretta, che, secondo Goethe, è in grado, godendo giudicando e giudicando godendo, di “ricreare” l’opera d’arte. Di fatto, la traduzione è una “ricreazione”, certo, ma una “ricreazione” fedele. Una bella traduzione è tale se riesce a essere fedele. A che cosa? Alla lingua originale? Certo, ma, come è noto, non esiste una parola di una lingua che coincida perfettamente con quella di un’altra. Che fare? Bisogna inventarsi un modo il più preciso possibile per rendere la parola straniera in italiano. Come? E che ne so… Dipende dalla capacità di “ricreazione” del traduttore.
In un articolo del 1995 Milan Kundera, scriveva che “la fedeltà di una traduzione non è una cosa meccanica, ma esige inventiva e creatività. La fedeltà, quando si traduce, è un’arte”. E aggiungeva:
“La forza di un romanziere non risiede solo nell’immaginazione, ma anche nella precisione semantica. Proust, in questo senso, non è meno esigente di Cartesio. Gli inglesi e gli americani conoscono il suo romanzo con il titolo: Remembrance of Things Past. Ricordo delle cose passate. Allusione al trentesimo sonetto di Shakespeare. Neppure il grande pubblicitario Seguela avrebbe saputo scegliere un titolo più bello e più vuoto. Il titolo di Proust, infatti, definisce esattamente una situazione umana, e le parole “ricerca”, “tempo”, “perduto” sono insostituibili. Ho appena scoperto che in tedesco Point de lendemain (Senza domani) di Vivant Denon è diventato Nur eine Nacht – Solo una notte. Banalità sentimentale nella quale tutta la raffinatezza del titolo francese, che di un enunciato dai toni tragici ha fatto un imperativo edonista, si annacqua. Il romanzo di Broch che s’intitola Die Schuldlosen, cioè Gli incolpevoli, in francese è reso con il titolo Les Irresponsables (Gli irresponsabili). L’immenso paradosso brochiano che parla della colpevolezza degli innocenti è abolito. Si soffoca il senso di un’opera fin dal titolo, che è la sua prima frase.
Il titolo è “la prima frase” dell’opera.
Io, di solito, dico ai miei studenti che ogni romanzo degno di questo nome è una casa, con le sue fondamenta, la sua architettura, la sua disposizione degli spazi interni ed esterni, il suo arredamento. Il titolo è la porta principale per entrarvi. Certo, si può sempre entrare in casa da una finestra, dalla porta di servizio, da un lucernario, o, dopo essersi arrampicati su una grondaia fino al tetto, dal camino. Capita, quando ci si dimentica le chiavi in ufficio. Ma perché entrare dal camino se abbiamo le chiavi di casa? Ecco, i titoli delle opere sono le chiavi di casa che gli autori consegnano al lettore, anche a quello più sbadato.”
Cosa rispondere al mio amico O. che non riesce a capacitarsi del perché nella nuova traduzione il titolo originale, Portnoy’s Complaint, consegnato da Philip Roth ai suoi lettori nel lontano 1969, si sia ristretto come una camicia centrifugata, nel 2025, in Portnoy? Beh, non lo so. Alla fine del romanzo, dopo diciassette pagine di glossario e diciotto pagine di postfazione a cura dello stesso traduttore, il lettore non trova la minima traccia delle ragioni di tale scelta. Un po’ strano. Non era forse la prima cosa che il traduttore doveva dire ai suoi lettori italiani? E penso soprattutto a quei giovani lettori italiani che non solo non hanno letto le traduzioni precedenti, ma che non sanno neppure chi è Philip Roth.
La risposta più banale è che potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria.
O forse no. Forse il traduttore, pensando proprio ai nostri giovani lettori, ha ritenuto che la parola “lamento” (Complaint) del titolo originale poteva essere loro sgradita.
Nel nostro tempo non bisogna lamentarsi, protestare, prendersela con i genitori, essere in disaccordo con il mondo, trasgredire le regole sociali, scherzare con chi ha perso il senso dell’umorismo, averne abbastanza della propria “fottuta” razza, della propria “fottuta” religione, della propria “fottuta” cultura, raccontare barzellette sconce, affermare senza paura cosa si pensa dell’altro sesso… Tutto ciò che, per altro, forma la colonna portante del monologo del protagonista del romanzo. Le parole d’ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti del nostro tempo – a differenza del silenzio del dottor Spielvogel, l’analista a cui il giovane e ribelle Portnoy espone senza peli sulla lingua le sue iperboliche prodezze sessual-esistenziali – sono tutte rivolte alla “crescita dell’autostima in un’epoca di estrema fragilità emotiva e di ansia da prestazione” (leggo in uno dei tanti manuali fai-da-te per adolescenti in difficoltà).
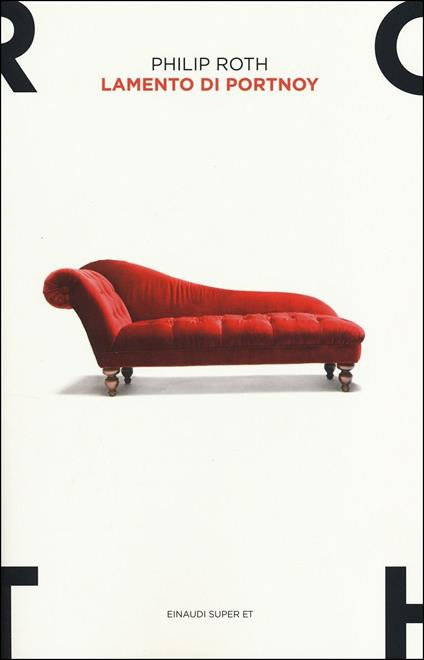
Per contro, mi dico, non è facile riproporre un romanzo come Il lamento di Portnoy, oggi Portnoy, in un’epoca come la nostra in cui la sessualità non solo non è più un tabù, ma non è neppure più la regione più profonda dell’esistenza, essendo diventata, da quel lontano 1969, onnipresente, totalitaria.
Come è noto, ogni forma di totalitarismo, sottraendo il ricordo agli individui, li trasforma in bambini. La nostra società tecnologica agisce allo stesso modo. La sua aspirazione ossessiva verso il futuro, il culto per i giovani, sempre al centro di ogni pubblicità, il suo disinteresse per il passato e la sua sfiducia, per non dire sospetto, nei confronti del pensiero fanno sentire un adulto, dotato di ricordi e di senso storico, una sorta di alienato capitato per caso in un giardino di infanzia.
La nostra, tuttavia, non è solo una società tecnologica, ma è anche una società pornografica, nella misura in cui la tecnologia, in nome della “trasparenza”, ha abbattuto qualsiasi frontiera tra pubblico e privato, realizzando un antico desiderio umano che tutti i totalitarismi hanno cercato di edificare – senza per altro mai riuscirci: quello di costruire un mondo privo di ogni ambiguità, di ogni ombra, di ogni segreto.
Ma non basta. La nostra società, oltre che porno-tecnologica, una volta trasformato il mondo in un giardino d’infanzia, popolato di bambini e adolescenti “privi di autostima”, emotivamente “fragili” e incapaci di lamentarsi del loro stato di minorità, ha dovuto inventarsi una sorta di puritanesimo linguistico (ciò che va sotto la nozione di “inclusività”) al fine di continuare a costruire il suo ideale.
Chissà se i professori di desiderio degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si sarebbero mai attesi che la loro ansia di liberazione sessuale si sarebbe trasformata nel giro di un paio di generazioni in “ansia da prestazione”?
Mettendo a confronto la traduzione Adelphi con la traduzione Einaudi, il lettore un po’ curioso si accorge subito, sin dal sommario, delle differenze. I titoli dei capitoli sono diversi. Praticamente tutti. Il primo capitolo nella versione Einaudi recita: Il personaggio più indimenticabile che ho conosciuto. Nella versione Adelphi diventa: La creatura più prodigiosa che abbia mai incontrato. Vado a vedere il titolo del capitolo in originale: The most unforgettable character I’ve met. Mah, da dove viene quella “creatura”? E l’aggettivo “prodigiosa”? Mi vengono in mente le parole di Kundera: “La forza di un romanziere non risiede solo nell’immaginazione, ma anche nella precisione semantica”. Credo che dovrebbe essere così anche nel caso di un traduttore. Ogni traduzione è una “ricreazione”, come ho detto: una ricreazione fedele. Essere infedeli in nome della “ricreazione” non è la stessa cosa che ricreare restando fedeli. E poi siamo sicuri che la parola “creatura” sia più “rothiana” che la parola “personaggio”? O che l’aggettivo “prodigiosa” riferito alla madre del protagonista, quella madre che gli si è talmente conficcata in testa che il piccolo Portnoy pensa che tutte le maestre non siano altro che suoi travestimenti, sia più esistenzialmente corretto di “indimenticabile”? Non so… In fondo, la lunga confessione del giovane protagonista è un’interminabile sequela di ricordi… Ricordi tanto indimenticabili da diventare vere e proprie ossessioni da cui il protagonista, per quanto si lamenti, si masturbi, scopi, o si arrabbi, non riesce a liberarsi.
Il secondo capitolo del romanzo, nella versione Einaudi si intitola Seghe, mentre in quella Adelphi Pippe. La versione originale è Whacking off, che diversi dizionari traducono indifferentemente con “farsi una sega” o “farsi una pippa”.
Ma, ragazzi, tra una “sega” e una “pippa” c’è un mare non tanto semantico, ma estetico. O no? Faccio riferimento all’estetica dell’opera, alla sua retorica, alla sua tonalità. Portnoy, il giovane incazzato che non ne può più di nessuno, né di sua madre, né di suo padre, né dei suoi avi ebrei né della società americana che manda a morire migliaia di ragazzi in Vietnam, ricordando le sue prime esperienze masturbatorie, avrà detto “sega” o “pippa”? Per me non ci sono dubbi, ma…
L’attacco del capitolo nella versione einaudiana suona così:
Poi arrivò l’adolescenza. Trascorrevo metà della mia vita da sveglio chiuso a chiave nel bagno, spremendomi il pisello nella tazza del gabinetto o nei panni sporchi del portabiancheria, o s-ciàcc, contro lo specchio dell’armadietto dei medicinali, di fronte al quale stavo ritto con le brache calate per vedere com’era quando schizzava fuori.
Nella versione adelphiana invece:
Poi è arrivata l’adolescenza – nel senso, metà della vita di veglia chiuso in bagno a svuotarmi il pirillo nella tazza del cesso, o nella cesta dei panni sporchi, o splash, contro lo specchio dell’armadietto dei medicinali, davanti al quale mi piazzavo a braghe calate per vedere che effetto faceva quando saltava fuori.
Quale traduzione preferite? Siete più per lo schietto “pisello” o per l’edulcorato “pirillo”? Amate più il ruvido “s-ciàcc” o l’incredibile “splash” (vi ricordo che si tratta di uno schizzo di sperma umano maschile, non di un getto d’acqua corrente)?
Comunque la pensiate, se la traduzione non è una “ricreazione” fedele, rischia di porre in secondo piano l’autore a vantaggio del traduttore.
Leggi anche:
Niccolò Scaffai | Le molte vite di Philip Roth
Alice Figini | Nemesi di Philip Roth
Niccolò Scaffai | I romanzi / Philip Roth. «Eccola, la vita umana»
Gianni Montieri | L'ordine sovvertito / Roth non esce di scena