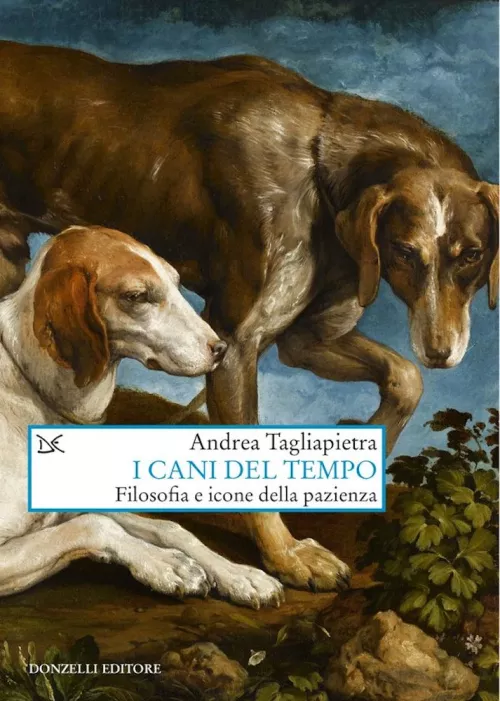Il cane come guida esistenziale
Si può pensare al cane come guida esistenziale, che, ritrovando un ruolo capace di andare oltre quello sminuente di giocattolo o status symbol, torni a indicarci la strada, secondo una linea tracciata da quando il lupo si è avvicinato a sapiens? Per indicarci cosa? Nientemeno che il valore della vita, per dirla con termini fuori commercio. Che poi consiste nello stare insieme agli altri viventi, in posizione paritetica, senza un soggetto cartesianamente opposto a un oggetto e convinto della sua assoluta leadership. E riappropriandosi della dimensione del tempo, sfuggendo alla logica del fare stordente, dominato dalla fretta, dall’impazienza e dagli schemi di chi esercita potere.
Da più parti si colgono i segnali di questa indicazione di svolta che deve però contrastare impianti di pensiero strutturati in senso antropocentrico (cultura giudaico-cristiana e umanistica occidentale), orientamenti di mercato (capitalismo), senso comune (che significa fare del cane la propria guida, soprattutto se il cane è il mio bambino indifeso?), ma che ora può far leva su una sensibilità diffusa disposta a riconoscere al mondo animale autonomia, complessità cognitiva e dignità, anche perché gli shock epidemico-ambientali hanno reso esplicito quanto la proterva separatezza di sapiens sia una minaccia per il pianeta. Che la “salvezza” stia nel ricucire il rapporto con l’animalità a cui apparteniamo e che questa sia esperibile soprattutto attraverso il cane il quale, a ben vedere, è uno dei pochi (talvolta si direbbe l’unico) esseri non umani con cui realmente conviviamo ancora, lo spiegano due libri usciti negli ultimi mesi: I cani del tempo. Filosofia e icone della pazienza di Andrea Tagliapietra (Donzelli) e La filosofia del cane. Orme per un futuro post-umanista di Manuela Macelloni (Mimesis).

Secondo Tagliapietra, il cane dà corpo alla dimensione del tempo. Ma non si tratta del tempo cosmico della fisica, né di quello ontologico della filosofia. Il suo è il tempo “che non passa”, ovvero il tempo della vita, quello, “a termine, vissuto da ciascuno”, e che ciascuno percepisce attraverso “l’esperienza dell’anima”. È un tempo differente da quello del mondo – il tempo della natura e della storia che ci scorre attorno. È il “tempo sentito”, quello di cui siamo composti, quello che, come scrive Agostino nelle Confessioni, è impossibile definire perché coincide con il tempo del corpo vivente, che dobbiamo cercare “nella nostra esperienza, nell’emozione del tempo che siamo e che ci apparenta con tutto ciò che vive”. Ritrovare questo tempo significa riannodare i fili del nostro destino individuale a quello collettivo. Ma dove sta “il tempo che non passa”?
La sua forma più evidente è la pazienza. Legata nella prospettiva antica al coraggio, alla saggezza, al controllo degli impulsi (così la vede Aristotele) o alla “sospensione assoluta della reazione” (è la convinzione degli stoici), e, in quella cristiana, alla speranza e alla forza, la pazienza si richiama etimologicamente alla passione, con cui condivide “una condizione di passività”. Chi pazienta si viene a trovare in una situazione che “appare non dipendere da lui” e dà l’impressione di non essere libero. Così la pazienza sembra oggi aver capovolto il suo senso ed essere intesa come debolezza, arrendevolezza o rassegnazione. Di qui la sua inattualità. Ma, proprio in virtù del suo disallineamento dal presente, la pazienza riveste un ruolo fondamentale. A lei è affidato il compito di sorreggere la nostra esistenza e di chiamarci “ad una dimensione essenziale del nostro essere, radicata nelle profondità della vita stessa, del nostro corpo come dell’ambiente naturale che ci circonda”. La pazienza è il segreto dei cani e alla pazienza dobbiamo tornare attraverso i cani. Per capire infatti quanto ci si sia allontanati da una rotta di navigazione equilibrata non possiamo procedere da soli. Facciamo fatica a comprenderci attraverso il nostro corpo. Abbiamo bisogno di una mediazione, che ci può essere fornita dall’immagine di un altro corpo. La pittura europea ha spesso scelto il cane per fornirci una traccia. Ed è quella che segue Tagliapietra.

I cani esprimono due tipi di pazienza: l’una consiste nell’attesa vigile del momento opportuno per agire. È la condizione espressa dai bracchi di Jacopo Bassano in I Due cani da caccia legati a un ceppo (1538-40), dal levriero pezzato della Nozze di Cana (1563) di Paolo Veronese, o, ancora dal levriero nero realizzato da Piero della Francesca nel Tempio Malatestiano di Rimini (Sigismondo Malatesta in preghiera davanti a san Sigismondo, 1451), o dal minuto cane bianco della Visione di sant’Agostino (1502) di Vittore Carpaccio, o, anche, dal segugio che cammina tra le gambe del cavallo in Il cavaliere, la morte e il diavolo (1513) di Dürer. L’altra è la sopportazione, cioè “l’aspettativa indeterminata nell’ordine del tempo continuo, cronologico” ed è la forma di “pazienza anestetica” che connota Argo (in cui è ravvisabile anche la “pazienza affettiva” che lo accomuna a Penelope secondo l’interpretazione del pittore inglese Joseph Wright of Derby in Penelope disfa la tela alla luce di una candela del 1783-84) in attesa del ritorno di Ulisse (che vive la pazienza sia come sopportazione sia come strategia). La pazienza che nasce dalla sopportazione è segno di fedeltà. Nella tempera su tavola Tobia e l’angelo (1470-75) di Verrocchio, tra i piedi dell’arcangelo compare “un cagnolino bianco, probabilmente un barboncino o un maltese”, forse dipinto dal giovane allievo Leonardo da Vinci. Il cagnolino “sta semplicemente accanto, è una presenza silenziosa e senza nome, quasi invisibile” e “svolge la sua azione di custodia senza esibirla”.
Il levriero e il terrier presenti nelle due incisioni (tra loro strettamente legate) che Albrecht Dürer realizza nel 1514, Melencolia I e San Girolamo nello studio, rappresentano i corni del problema: il quieto sonno del terrier esprime la pazienza misurata del santo che illuminato di luce divina traduce la Vulgata e si oppone alla stanchezza esausta del levriero su cui grava l’accidia del malinconico. Il messaggio è chiaro. L’accidia – in termini moderni la noia – può essere sconfitta solo dalla pazienza. Grazie ad essa capiamo che “non vi è un traguardo da raggiungere, ma solo un percorso da seguire”. La pazienza ristabilisce l’equilibrio tra il tempo interiore e quello di fuori, la cui distonia è all’origine dell’inazione sofferente del saturnino. Ma la strada maestra per rientrare nel tempo della vita, nel “tempo a termine del vivente, quello che si dimentica sullo sfondo dell’esistenza” è l’esperienza del dolore.

Nel 1820-21 Goya dipinge sulle pareti della Quinta del Sordo, la casa che aveva acquistato presso il Manzanares, El perro, la più angosciante delle sue Pinturas negras. La testa di un piccolo cane emerge a fatica sopra quella che sembra la cresta di un’onda scura. Una massa marrone appena più chiara di quella sottostante incombe alle sue spalle. Il cane di Goya trasmette “l’esperienza del dolore” che “ci richiama dentro al tempo… ci fa sentire la durata del tempo che siamo”. Così il tempo “diventa paradossalmente esperibile con evidenza proprio quando comincia a mancare”. Il dolore apre la strada alla cura, al senso dell’altro. Nella tela Lazzaro e il ricco epulone (1550) di Jacopo Bassano sono i cani gli unici esseri a mostrare interesse per Lazzaro ricoperto di piaghe.”I cani sono così emblemi della pazienza nella sua fragile labilità, ovvero nel suo puro e inquieto radicamento corporeo. La pazienza si configura come “cura senza aspettativa”, “dono del tempo”, “virtù della cura degli altri”, di tutti coloro che umani o non umani appartengono alle categorie reiette, a quegli ultimi “su cui si concentra l’immane violenza che caratterizza il volto della nostra epoca, in cui sembra si sia dimenticato ciò che più importa”. Un’epoca soggiogata dall’impazienza, che “può essere ritenuta la cifra contemporanea dell’esperienza soggettiva o, se si vuole, la causa stessa della sua mancanza”. L’impazienza alimenta sia il “prestissimo della produzione, la frenesia compulsiva del consumo, la vertigine della circolazione e la frequenza della comunicazione”, sia “la civiltà della spettacolo” fondata sull’idea che non ci siano “limiti naturali insuperabili” e che l’uomo, grazie alla scienza e alla tecnica, “possa plasmare indefinitamente le proprie potenzialità”. Per compiere l’ultimo passaggio, bisogna ancora osservare il cane. A fronte dell’esperienza della noia profonda (il terzo tipo di noia secondo Heidegger, dopo quella legata ad un oggetto o ad una situazione e quella che nasce dentro di sé) l’antidoto si trova “in una forma di pazienza, in un richiamo alla singolarità della cura e all’esperienza della realtà nelle sue manifestazioni più comuni e semplici, come quelle del sentire che è proprio della nuda vita, condivisa da tutti i viventi”. È l’esperienza “del lasciarsi essere una cosa che sente” rappresentata dall’olio su cartoncino di Henri de Toulouse-Lautrec, Piccolo cane nero (1888) e dal Cane di fronte al mondo (1912), olio su tela di Franz Marc. Marc ha rappresentato “Il piacere puro dell’esperienza, a cui ci si abbandona senza aspettative, (che) prende il sopravvento sulla ricerca affannosa dei significati, sulla presunzione del possesso e della disponibilità delle cose”. È questa l’esperienza più prossima per accedere a ciò che Rilke, nell’ottava elegia duinese, chiama l’“Aperto”.

Si tratta di una conclusione molto simile a quella cui giunge Manuela Macelloni. Il suo punto di vista è quello del post-umanismo, che, prendendo slancio dalla zooantropologia, si propone di andare oltre una visione del mondo antropocentrica, rifiutando l’idea di una differenza di grado (ontologica) tra ciò che è umano e ciò che è animale. Macelloni insiste su un aspetto. L’uomo non gode di una superiorità spirituale e/o culturale rispetto agli altri viventi. La convinzione propria dell’antropologia filosofica, ribadita da Plessner all’inizio del Novecento, ovvero che l’uomo sia un “animale carente”, che ha colmato il divario rispetto alle altre specie grazie a qualità intellettive superiori, è rigettata. È necessario perciò rileggere il mito di Prometeo ed Epimeteo. L’uomo non è l’esito della creatività di Prometeo, né gli altri viventi sono gli eredi del fissismo di Epimeteo. Detto in altro modo: l’uomo è diventato se stesso grazie all’“epifania animale”, grazie agli scenari esistenziali resi possibili dall’altro da sé (si pensi all’osservazione del volo degli uccelli), grazie al processo fondato sulle relazioni e sulla cura che queste portano con sé. L’azione di Prometeo ed Epimeteo, inoltre, deve essere sottratta a una concezione teleologica del tempo, perché l’uomo è in continuo divenire. Il postumanismo si propone in questo modo di “rompere l’opposizione soggetto-oggetto per cogliere l’unione Uno-Tutto” e l’animale diventa “guida totemica per interagire con la propria identità”. Citando Roberto Marchesini, Macelloni ricorda che “l’essere umano è fatto di momenti non di destinazioni”. Per cui è importante “imparare a lasciarsi andare, consegnarsi a quel flusso mobile che è la vita”, nonché “ricomprendersi esseri desideranti”, superando le secche dell’individualismo e la pericolosa convinzione che l’uomo sia “la perfezione dinanzi a un mondo fatto di imperfezioni”. Proprio il cane, il nostro “compagno evolutivo”, può far rinascere il concetto di relazione, a patto però di non farne “un feticcio”, o “l’estensione dei (propri) bisogni, delle (proprie) insicurezze”. Riscoprendo la relazione, dobbiamo imparare a “farci stupire dalla diversità”, sfuggire al narcisismo del controllo che ci fa incontrare solo “l’aspettato e il conformante”, ma mai “il diverso e pertanto il perturbante”. Ricorrendo all’altro celeberrimo mito platonico, è pertanto necessario uscire dalla caverna. Dobbiamo imparare, seguendo la filosofia del cane, a non perdere di vista le domande essenziali. È necessario “aspettare, avere pazienza, stare fermi”, sottraendosi alla logica di sfruttamento e sopruso”. Da tutto ciò nasce la prospettiva filosofica del postumanismo, orientata su “un pensiero corporeo, un pensiero d’amore”, che impone la compromissione con le “alterità animali”. Per riuscirci è necessario smettere di pretendere che il cane si trasformi “in qualcosa che sia conforme alle nostre aspettative” e aprirsi alla pluralità dei punti di vista, sentendosi “parte di una realtà che non è esclusivamente produttiva ma ricreativa e in quanto tale generativa”, accettando l’idea che il corpo sia “un magico e temporaneo recipiente del Tutto”.
L’approdo di Tagliapietra e Macelloni è un invito, comune, a smettere di essere impermeabili a ciò che ci circonda. Ritrovando l’animalità possiamo riorientare le prospettive, smettendo di consumare il tempo e tornando a viverlo, in una condizione di spontaneità canina, possibile rimedio alla distruttività antropocentrica del nichilismo.