Il cuore oscuro degli unici indiani buoni
La presenza dei nativi aleggia nella letteratura gotica americana sin dai suoi albori come una presenza silenziosa e spettrale. In un romanzo come Wieland: or, The Transformation (non a caso sottotitolato An American Tale), opera del 1798 di Charles Brockden Brown, considerato il capostipite della narrativa gotica negli Stati Uniti, eventi misteriosi, sentimenti morbosi e passioni represse si susseguono sullo sfondo della guerra franco-indiana (1754-1763). Il padre dei protagonisti, apprendono i lettori, era giunto nel nuovo mondo dalla Germania con uno scopo preciso, ossia convertire gli indigeni. L’uomo fallisce, ma proprio perché è dal fallimento di questa impresa che la catena di orrori del romanzo prende le mosse, è difficile non rilevare che la violenza contro i nativi sta alla base dell’immaginario del terrore americano. Alla base, ma non al centro, tuttavia, perché si tratta di una violenza che il più delle volte è evocata o presente in filigrana, ma mai esplicitamente raccontata. Se pensiamo a due capisaldi dell’horror contemporaneo come The Shining (1977) e Pet Sematary (1983) di Stephen King, ritroviamo questa presenza più viva, o meglio più non-morta, che mai: l’Overlook Hotel è costruito su un antico cimitero nativo, ed è questa coincidenza a renderlo un luogo maledetto; mentre in Pet Sematary è seppellendo i morti, di nuovo, in un antico cimitero micmac che questi possono essere fatti tornare in vita – ancorché in forme perverse e maligne. I nativi sono evocati, addirittura posti a custodire le origini dell’orrore, ma non sono mai raccontati; un’omissione tanto più significativa se si considera che quella che ritorna in forma spettrale non è solo la presenza di antiche civiltà, ma di civiltà spazzate via dall’arrivo dei colonizzatori europei con una violenza che è costantemente rimossa dal discorso pubblico e storiografico.
Il motivo della maledizione legata ai nativi è riappropriato e rovesciato da Stephen Graham Jones nel suo Gli unici indiani buoni (2020), pubblicato nella collana Darkside di Fazi Editore nel 2023. Il titolo, non a caso, riprende un detto diffuso negli Stati Uniti ai tempi delle guerre contro i nativi: l’unico indiano buono, proverbialmente, è un indiano morto. Jones, che è di origini native, nello specifico della tribù dei Blackfoot, non ha cominciato la sua carriera di scrittore come autore horror, ma vi si è convertito presto, e in questi ultimi anni si è affermato nel genere, vincendo tre Bram Stoker Awards: due nel 2020, per Gli unici indiani buoni e la novella Night of the Mannequins, e nel 2021 per My Hearth Is a Chainsaw. Coerentemente con la parabola autoriale di Jones, Gli unici indiani buoni è un romanzo decisamente horror per essere opera di uno scrittore che si è formato fuori dal circuito del genere (un romanzo slasher con scene di maestosa e gustosa mattanza), e allo stesso tempo un romanzo narrativamente articolato e stilisticamente più ricco della media del genere (ancorché una ricchezza non sempre resa in maniera adeguata dalla traduzione).
Gli unici indiani buoni segue quattro nativi (Ricky, Lewis, Cass e Gabe) dieci anni dopo una battuta di caccia finita male: avventuratisi, per dare la caccia a un gruppo di wapiti (cervi tipici della zona), in un’area della riserva il cui accesso è consentito tradizionalmente ai soli anziani, i quattro sono intercettati e sanzionati dalla guardia forestale. Non è solo la legge degli uomini, tuttavia, in cui i quattro incorrono, ma anche la vendetta di una dei wapiti che inseguono e uccidono insieme al cucciolo che aspettava, e che dieci anni dopo torna per farli fuori uno per uno, ora prendendo forma di donna, ora di orda di wapiti, ora di spirito metà umano e metà animale.
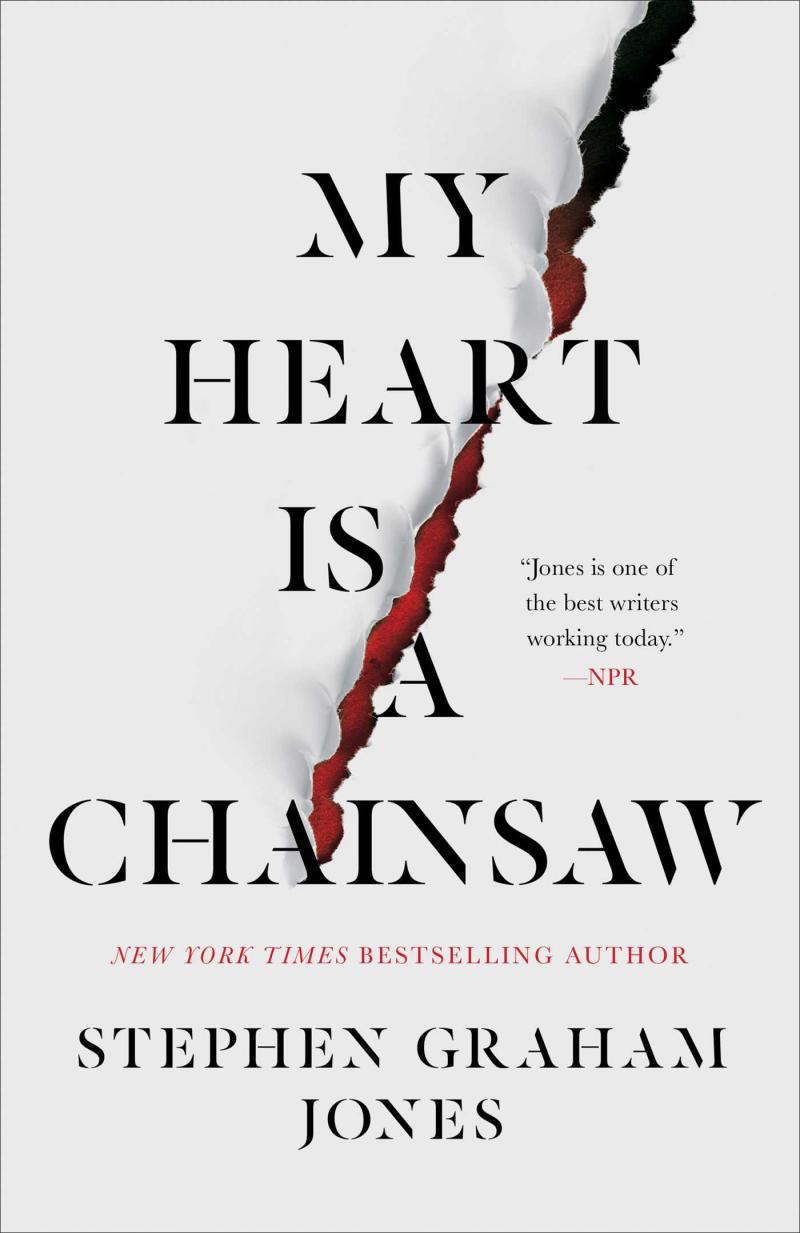
La storia si snoda sullo sfondo della vita, monotona e deprimente, nella riserva, e all’orrore soprannaturale fa sempre da contraltare quello, molto più concreto, della violenza bianca contro i nativi. Il romanzo si apre con una scena che mette insieme le due cose: Ricky, il primo dei quattro a morire, abbandona la riserva dopo la morte per overdose del fratello, e si ritrova linciato da un gruppo di bianchi ubriachi fuori da un bar mentre un branco di wapiti, apparso quasi dal nulla, gli blocca la strada. In generale, la vita nella riserva è descritta con una minuzia quasi dolorosa, nella sua mancanza di opportunità, noia, e allo stesso tempo di costante ansia e pericolo di violenza da parte dei bianchi: sensazioni, queste, che vengono dalla coscienza di vivere in un Paese che ha relegato la popolazione nativa in poche aree sorvegliate, e che ha definito la propria identità precisamente in opposizione ad essa.
La vita nella riserva è una vita di alienazione, nutrita di droghe, cibo spazzatura e intrattenimento insensato (gli anziani, catatonici, sono parcheggiati davanti alla televisione a guardare un canale che trasmette immagini da un parcheggio locale); e in cui le tradizioni e i riti nativi sono mediati attraverso la loro riproposizione mercificata sotto forma di souvenir, luoghi comuni, o tropi hollywoodiani. In questo senso, la trasgressione dei quattro uomini che dà il via a questa storia dell’orrore è la conseguenza naturale di un mondo in cui non è letteralmente più possibile rispettare le tradizioni: in cui alla tradizione si è sostituito il suo simulacro, spesso filtrato attraverso una lente coloniale. Lewis, il protagonista della prima sezione del romanzo dopo il prologo, cerca di lasciarsi questa vita alle spalle, trasferendosi fuori dalla riserva e trovandosi un normale lavoro d’ufficio; e l’intuizione di Jones non è tanto che il suo passato si ripresenti, a un certo momento, come presenza soprannaturale, quanto in ritorno traumatico dei ricordi e dei tic della vita opprimente nella riserva.
L’infrazione di una norma sociale, soprattutto nel contesto di una simile alienazione culturale, non giustificherebbe, a rigore, la spietatezza della punizione a cui i quattro uomini sono sottoposti – una spietatezza che il lettore non manca di godersi nelle funamboliche scene gore che intervallano il romanzo. Se lo spirito della wapiti perseguita Ricky, Lewis, Cass e Gabe è perché questi hanno infranto un divieto che regola il rapporto tra la loro società e l’ambiente, ma dietro la sua furia c’è anche l’irriducibilità della vita animale. La vendetta della wapiti è una figura dell’impossibilità di ridurre l’agentività della vita non-umana a un ordine preciso, all’interno come all’esterno di griglie culturali. È una vendetta che colpisce, viene da dire, a prescindere dalla trasgressione compiuta, per pura furia verso un dato elementare e vitale (l’uccisione di un cucciolo) che nessun impianto di tradizione può davvero normare e giustificare. La narrazione di Jones non si esime dall’assumere, a tratti, il punto di vista della wapiti, mostrando la fragilità e la furia che stanno dietro la sua azione soprannaturale. Il cuore oscuro di Gli unici indiani buoni non sta tanto nel suo ritmo incalzante o nelle sue scene di sangue, quanto nelle dinamiche di violenza e sfruttamento esercitate dagli occupanti di diversi livelli di una gerarchia dell’esistere razzista e specista: dall’essere umano sull’essere umano, e dall’essere umano sull’animale.







