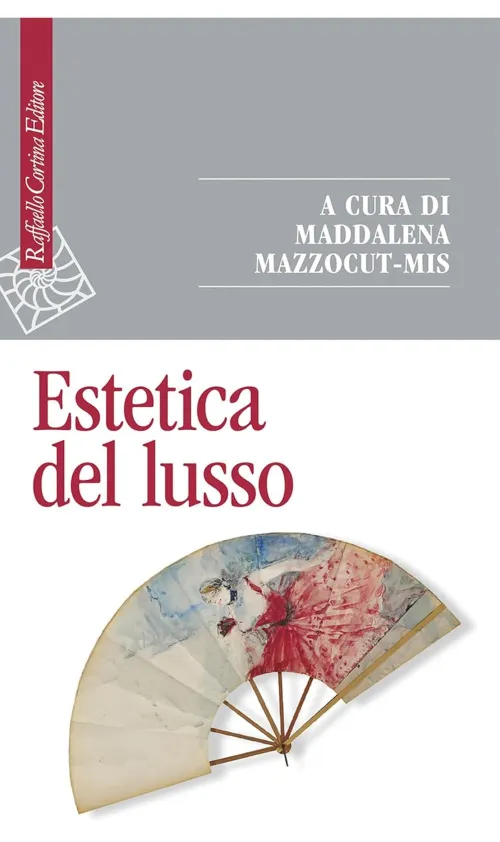Il potere del lusso
Il concetto di lusso presenta a prima vista una natura ambigua e scarsamente definita. Probabilmente, perché può essere collegato a dei beni che sono estremamente differenti tra loro, anche se sono accomunati dal fatto di essere solitamente considerati “non necessari” o “superflui”. L’idea della “non necessarietà”, però, possiede anch’essa una natura ambigua. Può essere, infatti, considerata accettabile solamente se si ragiona a partire da un modello economico che interpreta le scelte di consumo come determinate dai bisogni fondamentali dell’individuo che trovano nei prodotti la loro soddisfazione. Se, cioè, si pensa che le persone siano sempre alla ricerca di una qualche utilità nei beni e dunque che tutto ciò che non è utile è “un lusso”. In realtà, una vastissima letteratura sociologica, antropologica e semiotica ha mostrato chiaramente negli scorsi decenni come le persone cerchino nei beni di consumo anche molto altro: status sociale, prestigio, affetto, emozioni o soddisfazione edonistica.
Quello che è certo è che nella storia delle civiltà umane la produzione e la vendita dei beni di lusso hanno sempre avuto un ruolo estremamente rilevante. Il lusso, infatti, viene da molto lontano. Ha avuto inizio all’interno delle civiltà primitive grazie a uno spreco di beni che avveniva all’interno di particolari eventi sociali. Come, ad esempio, la festa-banchetto potlàc di cui parlava già negli anni Venti del Novecento Marcel Mauss nel celebre Saggio sul dono (Einaudi), una festa dove gli oggetti donati o distrutti diventavano dei simboli del valore sociale, del prestigio e del potere di chi li possedeva e stabilivano o confermavano le gerarchie sociali esistenti. Si ritiene, inoltre, che in tali occasioni gli oggetti svolgessero anche delle funzioni mitiche, religiose e magiche.
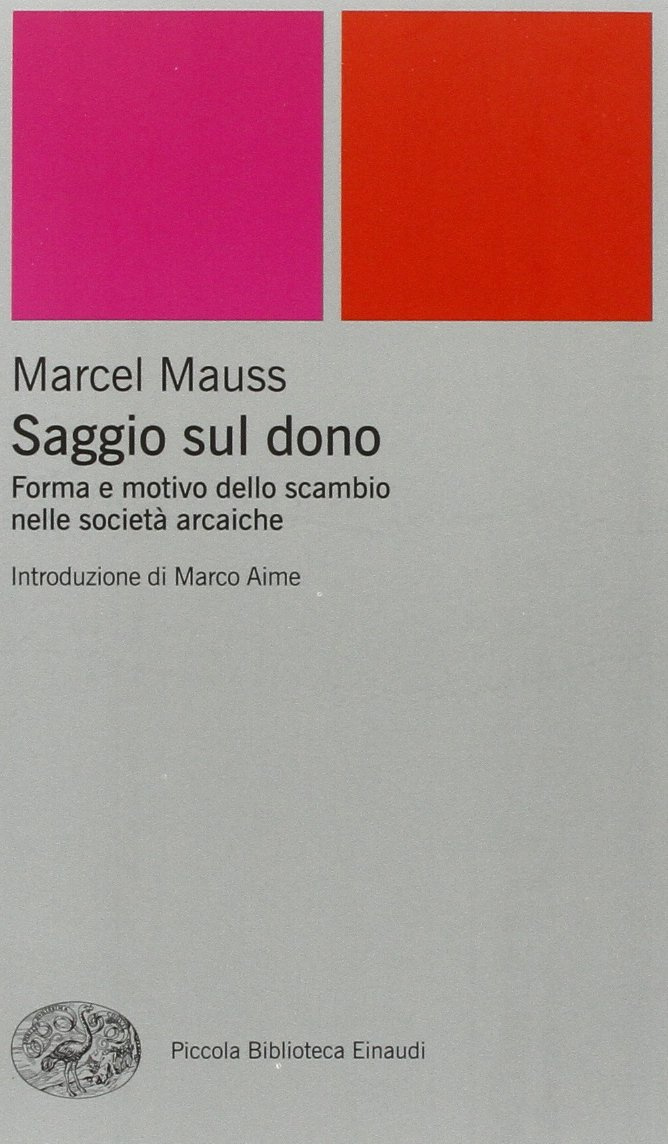
Durante la fase del predominio aristocratico in Occidente, le grandi famiglie italiane hanno giocato un ruolo importante rispetto all’utilizzo dei beni di lusso. Nel Rinascimento, infatti, hanno avviato un consumo di beni di lusso che ha fatto da modello per i comportamenti degli aristocratici presenti negli altri Paesi europei. I beni di lusso sono diventati un simbolo d’inalterabilità e di permanenza e hanno assunto così un ruolo funzionale alla volontà dell’aristocrazia di legittimarsi socialmente come un ordine sociale permanente e di diretta derivazione divina. I signori hanno rivaleggiato tra loro elargendo numerosi doni alla collettività e offrendo feste sontuose, per riceverne in cambio gloria e prestigio, per manifestare cioè la loro potenza e la loro superiorità. Dunque, anche nelle società aristocratiche, il lusso non era considerato qualcosa di superfluo, ma uno strumento necessario per far funzionare e rafforzare un sistema sociale basato fondamentalmente sull’ineguaglianza.
Non è un caso, perciò, che già nel corso del Settecento si sia sviluppata la celebre “polemica sul lusso” che ha visto la partecipazione di quasi tutti gli intellettuali illuministi. I quali, però, di solito si sono schierati compattamente contro il lusso, con l’eccezione solamente del filosofo Voltaire, che ha celebrato a più riprese le virtù del lusso. L’ha fatto, in particolare, nel poemetto Il mondano, un vero e proprio inno al piacere di consumare beni pregiati provenienti da tutto il mondo. L’ha ricordato Maddalena Mazzocut-Mis, che insegna Estetica all’Università degli Studi di Milano e ha recentemente curato il volume collettaneo Estetica del lusso, pubblicato dall’editore Raffaello Cortina. Questo volume è una delle poche analisi del lusso prodotte negli ultimi anni in Italia. Forse per questo non si tratta di una trattazione sistematica dell’argomento, ma di una raccolta di riflessioni di vari autori, tutti di area filosofica, su differenti problematiche, che mostrano comunque la vastità e la ricchezza dei significati e delle implicazioni sociali posseduta dall’argomento lusso.
Abbiamo ritenuto opportuno, pertanto, concentrarci su uno dei capitoli contenuti in questo volume e riprendere dunque le riflessioni presentate da Marco Franceschina. Il quale si è focalizzato su alcuni aspetti rilevanti dell’esperienza contemporanea relativa ai beni di lusso. In particolare, ha analizzato la somiglianza esistente tra il rapporto sviluppato con i beni di lusso e quello con l’opera artistica. È evidente, infatti, come oggi le aziende del settore del lusso facciano massicciamente ricorso agli artisti, cercando di associare la loro immagine alla propria. Si tratta di quella strategia di collaborazione tra marche che solitamente nel marketing aziendale viene denominata “co-marketing” e che in questo caso invece, come ha fatto lo studioso Jean-Noël Kapferer nel volume Lusso. Nuove sfide, nuovi sfidanti (FrancoAngeli), è stata spesso chiamata “artificazione”, cioè sostanzialmente trasformazione del prodotto in un’opera d’arte. Ovviamente, non si tratta di una vera opera d’arte, ma comunque, grazie al ricorso alla creatività degli artisti, di qualcosa che vi assomiglia fortemente o almeno viene percepito come tale da parte dei consumatori.
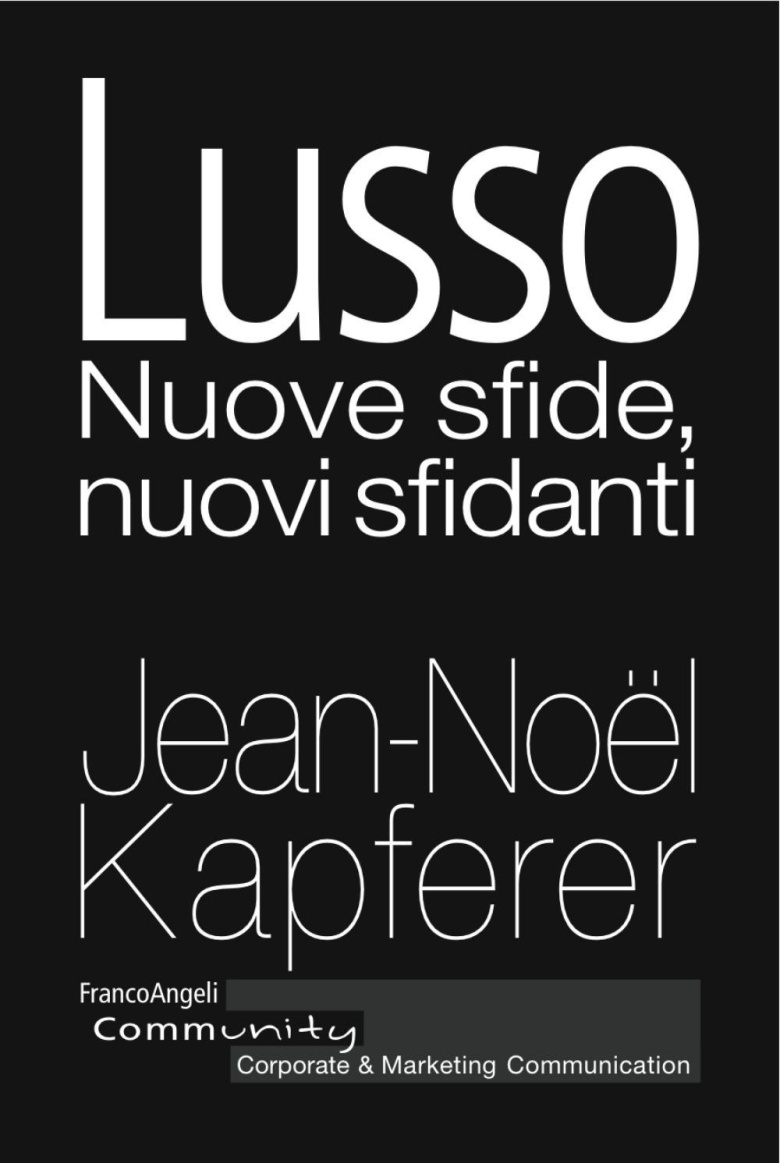
Tutto ciò, naturalmente, ha delle notevoli ripercussioni sulle relazioni tra gli individui e i beni, perché evidenzia chiaramente come tali relazioni vadano molto al di là della tradizionale concezione utilitaristica propria dell’economia. Vale a dire che «tanto la fruizione artistica quanto il possesso di un oggetto di lusso sono, in senso letterale, inutili» (Franceschina, p. 99). Si tratta, infatti, di spese esorbitanti per oggetti altrimenti consumabili a minor prezzo, ma comunque considerate dagli individui assolutamente indispensabili. Dunque, continuano ad essere utili, ma manifestano diversamente la loro utilità.
Ciò si concretizza, soprattutto, attraverso la possibilità propria dei beni di lusso di consentire agli individui di sviluppare delle strategie distintive che permettano loro di collocarsi nella maniera migliore possibile all’interno della gerarchia sociale, come è stato mostrato da una ricca letteratura sociologica prodotta negli scorsi decenni. Ma i significati relativi allo status sono soltanto una parte della ricca gamma espressiva che i beni di lusso sono in grado di manifestare. Non c’è da meravigliarsi, allora, se, come ha sottolineato Franceschina, tali beni svolgano un ruolo sociale così rilevante da caratterizzare in maniera significativa con i loro contenuti estetici il nostro modello di vita. Autori differenti come il sociologo francese Gilles Lipovetsky e il filosofo tedesco Gernot Böhme concordano, infatti, sull’idea che nelle società contemporanee sia in corso un radicale processo di “estetizzazione” che si basa sull’attivazione di un vero e proprio show value, cioè sulla «possibilità di un prodotto di mettersi in scena» (Franceschina, p. 119). In realtà, il concetto di estetizzazione viene da lontano. Viene cioè da Walter Benjamin e ha trovato in passato vari sostenitori, a cominciare da Michel Maffesoli. Lipovetsky e Böhme, però, l’hanno messo al centro della loro costruzione teorica e ne hanno fatto il perno della loro analisi delle dinamiche in corso nelle società avanzate.
Il primo di questi due autori, inoltre, ha sottolineato, all’interno del volume Il tempo del lusso (Sellerio), come il rapporto con i beni di lusso si sia radicalmente modificato durante gli ultimi decenni. È diventato, cioè, sempre più personale, intimo e soprattutto emozionale. Il lusso, dunque, appare essere maggiormente orientato rispetto al passato a soddisfare i bisogni personali di soddisfazione e la ricerca di gratificazioni di natura sensoriale.
Ciò corrisponde a un rilevante processo di cambiamento che ha interessato negli ultimi decenni la struttura della società. Dove la crescita dei processi di frammentazione e differenziazione interna ha portato a una progressiva disgregazione dell’organizzazione basata su diversi livelli di status sociale e ha reso meno necessaria perciò la funzione di comunicazione dello status di appartenenza che veniva tradizionalmente svolta dai beni di lusso. Se il consumo di questi, cioè, corrisponde principalmente a delle esigenze personali di gratificazione e di espressione del Sé, viene a modificarsi la funzione che essi svolgono socialmente: «Se, infatti, il prodotto di lusso riesce a intercettare la nostra dimensione più intima, sarà proprio questa a essere messa in mostra prima di tutto, e non la nostra appartenenza a un gruppo o a una classe» (Franceschina, p. 115).
Ciò, però, non comporta che il consumo di beni di lusso non possa allo stesso tempo presentarsi anche come uno strumento in grado di consentire il mantenimento in vita di una forma di pensiero mitico nel cuore di quelle culture fortemente consumistiche e “desacralizzate” che sono presenti nelle società occidentali contemporanee. Anzi, una fondamentale virtù del mondo del lusso risiede proprio nella capacità di tale mondo di permettere agli individui di conciliare il tempo accelerato e instabile del consumo e della moda con quello lento e duraturo che caratterizza la memoria e il mito. I negozi del lusso ne rappresentano un esempio evidente. In essi, infatti, tende solitamente a prevalere un’atmosfera dotata di una natura quasi sacrale.
Non rimane che chiedersi se esiste una possibilità di contrapporsi a questi fenomeni. Franceschina ha proposto di recuperare il concetto di «arte pura» elaborato in passato dal filosofo Adorno. Per il quale era necessario opporre all’industria culturale un prodotto artistico dotato di una natura “dialettica”, in quanto in grado paradossalmente di affermarsi pienamente nelle logiche della produzione capitalistica, ma anche di negare al tempo stesso tali logiche. Questo prodotto, infatti, è una merce e, nel contempo, una merce che nega il suo esserlo. È evidente come il concetto di «arte pura» di Adorno sia intrinsecamente ambiguo e dunque renda ancora una volta evidente la grande forza posseduta dal mondo del lusso e la nostra difficoltà a contrapporsi ad essa.
Leggi anche
Vanni Codeluppi, Status Symbol
Vanni Codeluppi, Lusso