La cura e il buio
Proprio in questi giorni intorno all’evento astronomico del solstizio invernale, vorrei parlare del buio. Del buio in fondo alla luce, che la genera e sostiene. E che sempre l’accompagna. Perché questo dice il linguaggio del sistema solare, del cosmo, che si dipana tra due misteri (la luce e il buio). In questo periodo dell’anno, proprio nell’allungarsi delle tenebre, si rigenera la luce. E così ogni volta. A giugno sarà il contrario.
Che c’entra questo con la cura? Non vorrei, qui, parlare da professionista della cura. La cura è anche una professione, certo. Anzi, varie professioni se ne attribuiscono la prerogativa. E neanche vorrei parlare della cura secondo i gerghi di quell’altra professione (la filosofia accademica), che vede tutto da lontano e tocca quasi niente, né si fa toccare. Per cui non parlerò di etimologie, della favola di Igino, riscoperta da Heidegger, e così via.
Proverei invece a comporre intuizioni da varie discipline (volendo, da una disciplina a venire), e riflettere sulla cura come struttura esistenziale, costitutiva, dell’essere che noi siamo. Non un mestiere, dunque – a meno che non si pensi al mestiere (tutt’altro dalla professione) di essere umani, di essere mammiferi a sviluppo lentissimo, che necessitano di tutto e a lungo. Per animali fatti in questo modo, come noi, bisognosi di accudimento continuo e di paziente messa in forma, la cura è questione di sopravvivenza. La cura, come preoccupazione reciproca, come forza delle relazioni, come necessità del convivere, come presa d’atto della fragilità di ognuno, dell’interdipendenza, dell’appartenenza a molteplici sistemi di simili e dissimili, ci definisce in modo peculiare e profondo.
È vero che guardando alla cura in questa prospettiva si rischia di estendere il termine fino a che si sfalda e svuota di significato. Ma è un rischio che va corso (mi preme qui citare il recentissimo testo di Nicole Janigro e Romano Màdera, appunto intitolato Cura – Editrice Bibliografica, 2023). È qui che medicina, psicoanalisi, filosofia, spiritualità si sovrappongono. Si occupano in modo diverso delle stesse cose: il bene, l’uno, l’integrità, la salvezza, nel gioco infinito delle differenze. Complessità e semplicità, armonia e mistero, connettono gli abissi della nostra interiorità e quelli del cosmo, diceva Gregory Bateson pensando al lavoro di Freud e alla propria ricerca, al loro indicare in fondo la stessa cosa. Il numinoso, dentro e fuori.
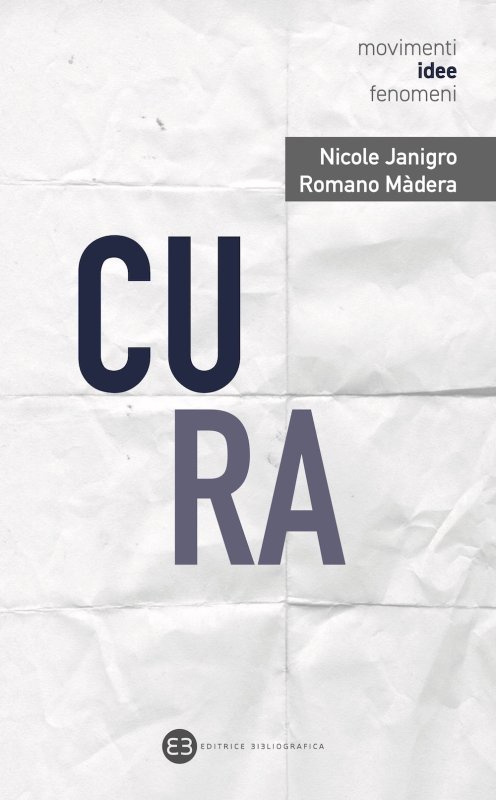
Dunque la cura è per noi compito imprescindibile. Per noi in quanto umani (sempre tenendo conto che di questo che chiamiamo “umano” non ci siamo ancora mai fatti un’idea precisa). La cura è umanizzante almeno quanto gli studi, la riflessione, il discorso – quel logos che tanto, se non esclusivamente, ci caratterizza. In effetti i presupposti genetici non bastano, umani non si nasce ma si diventa (se mai). Né il logos, né forse la stazione eretta, si acquisiscono senza cura – senza la sollecitudine, lo stimolo, il gioco, la vicinanza, l’incoraggiamento di un “noi” che si offre all’imitazione. E noi, ognuno di noi, imitando, ha imparato una lingua, a mettersi sui propri piedi, dapprima malfermi, e poi a camminare.
Credo che, oggi più che mai, sia importante accostarsi al tema della cura in quest’ottica, anche e soprattutto perché, come è sempre più evidente, la cura o è globale o non è. O è esercizio dell’attenzione al sistema individuo-mondo, o non è. È questa unità che ha bisogno di essere curata, esplorata, conosciuta di più e sentita. È lì che sta il senso. Nell’uno. E con questo non intendo alcunché di omogeneo o uniforme, bensì, in una genealogia che va dai presocratici al pensiero odierno dell’ecologia profonda, la consapevolezza dell’unità anche nelle divergenze, nelle discordie più aspre, nei conflitti. Consapevolezza di ciò che ci lega, come vincolo e come appartenenza. Perché forse questi mondi, al plurale, sono uno.
Ma noi non viviamo in questo registro. I beni e i denari ci fanno impazzire, la brama di riconoscimento pure. Gli affannosi inseguimenti di gratificazioni varie ci posizionano l’uno contro l’altro, uno contro tutti, secondo l’accreditata formula di Plauto e poi di Hobbes. Ci siamo abituati a convivere con questo. O meglio, a vivere soli, isolati, accettando il fatto di un mondo scisso in pezzi non comunicanti. Non posso qui approfondire perché l’opzione hobbesiana abbia avuto tanta fortuna, ma va almeno ricordato che, a partire da Cecilio Stazio fino a Spinoza, a Feuerbach, è stato anche detto: homo homini deus.
Quando penso al sistema individuo-mondo, alla correlazione tra cura del singolo e cura dell’insieme, ho in mente fenomeni molto concreti, e concomitanti interrogativi. Penso all’inquinamento ambientale e psichico, a tutte quelle imprese umane che compromettono le menti e gli elementi (la terra, le acque dolci e salate, l’aria), che fanno stragi di ogni forma di vita. Penso alle distanze insondabili che separano il privilegio dalla povertà abbietta, l’accesso alla cura dalla sua inaccessibilità, anche quando siano fisicamente in prossimità. Penso alle acrobazie a cui siamo costretti, nell’attuale regime omni-comunicativo, per conciliare l’inconciliabile: il buon andamento dei nostri investimenti finanziari con i loro effetti disastrosi altrove; le nostre feste con le guerre altrui; la ricerca oncologica con la Pianura Padana zona più inquinata d’Europa, secondo le più recenti rilevazioni del particolato fine; la brama di lunga vita con condizioni di vita umilianti; l’alta moda con i sottopassi foderati di rifiuti e coperte (ci si avvolgono di notte i senza casa). E così via. Sappiamo tutto ciò, ma vogliamo non saperlo.
Questo avvelenamento del profondo annulla lo sforzo individuale. O ne affievolisce l’impatto, come quando si va controcorrente. Ci abituiamo a chiudere gli occhi, per sopravvivere. E facciamo finta di dimenticare. Ma fingiamo soltanto. E intanto, dentro, la menzogna scava. La ricerca di senso, di cui parliamo non poco, è ormai un’emergenza, non solo perché il senso di per sé ama nascondersi, ma soprattutto perché viviamo nel nonsenso. E il nonsenso fa male, ammala. Perché allontana dal reale. Allontana (illusoriamente) da ciò a cui pure apparteniamo – dall’incanto, dal mito. Pasolini, in Medea, fa dire qualcosa del genere al centauro sapiente, Chirone.
Allora, da un lato, incuria assoluta, ipocrita, pervicace, rispetto al mondo e ai viventi. E, dall’altro, l’eccesso di cura di sé, che proprio in quanto eccessiva e ossessiva, diventa parodica. Diventa fissazione su di sé, rimozione del perturbante in ogni sua forma. Diventa ansia, richiesta convulsa di certezza, di rassicurazione e assicurazione, da parte di un individuo che può solo risultare indebolito, irretito, inadeguato, proprio per via della sua separatezza.
Questi sono gli sviluppi della cura, quando non trova una sua misura. Diventa cura nel senso dell’angoscia, si rovescia nell’opposto, nella farneticazione. In effetti la parola cura, in latino, si mantiene in equilibrio precario tra attenzione e inquietudine, occupazione e preoccupazione. E mentre l’attenzione ci rende capaci di avvicinare le cose, di sostare in intimità con esse, la preoccupazione ce le rende spaventose, ci aliena, fa sì che cerchiamo di dominarle avendo reciso il rapporto, guardandole da fuori, come oggetti. Come se fosse possibile. (Forse proprio questa ambiguità, più che un diretto interesse per la cura in senso terapeutico o pedagogico, stava al cuore di quello che Heidegger vedeva nella fiaba di Igino: l’essere umano, fatto d’argilla, per l’intera durata della sua vita posseduto da cura, in tutti i suoi sensi.)
E tuttavia il rischio, lo scompiglio, l’inquietante fanno parte della nostra condizione. Così come da sempre la mortalità, l’insolubile connessione con l’altro e gli altri, la sofferenza, le tragedie. La nostra difficoltà a integrare questo fatto non lo rende meno reale. Lo dicono tutte le culture tradizionali e le loro ritualità – quelle passate e quelle ancora vive, ad esempio le cosmologie indigene sudamericane di cui Rodolfo Kusch coglie la straordinaria portata filosofica. O le culture degli “invisibili” variamente declinate in differenti regioni africane. E anche nel passato greco-mediterraneo questa evidenza resta depositata, sebbene per lo più in silenzio. Basti pensare all’implicazione del pensiero antico nel mito, nelle pratiche dell’incanto, nell’incubazione visionaria. Basti pensare ai filosofi-medici arcaici come Empedocle, lo stesso Parmenide. O ancora Platone, che faceva della presa di coscienza del male, del dissesto, del buio, la motivazione principale della filosofia. E che definiva “medicina servile” quel modo di praticare la cura come se si trattasse di applicare meccanicamente protocolli, senza essersi avvicinati al dolore, conoscerlo in prima persona, aver cercato di comprenderne le cause profonde. Poiché dalla stessa radice provengono la cura e ciò che è da curare.
I riti prendono la paura sul serio, invece di averne paura. Della paura comprendono il potere di scindere, spegnere, alienare. Ma colgono che essa non è insensata. Che c’è in essa verità, che ha senso avere paura, che il pathos non è né patetico né patologico, né ancora disagio endogeno e privato, ma una condizione del tutto sintonizzata con la realtà spaventosa del mondo – poiché è anche sconvolgente, il mondo, e smisurato. Onorando la paura, l’orrore del buio, dell’ombra, in vario modo i riti ne propongono la lavorazione, l’attraversamento. E lo fanno offrendo protezione e misura a chi guarda in faccia l’abisso. Il rito sempre sorge intorno a questioni infine legate alla sopravvivenza, alla sostenibilità della vita.
Ma noi abbiamo smarrito i riti, la loro naturalezza, il loro potere di raccoglimento. Già anche solo queste parole ci imbarazzano. Invece avvaloriamo la tracotanza, la temerarietà, la grandiosità onnipotente. Marciamo nell’“esercito degli eretti” di cui parla Virginia Woolf – al quale esercito solo la malattia può sottrarci, nel senso di renderci non funzionanti, orizzontali, inutili a questo gioco assurdo.
Ma se la verità della paura è l’ombra, e se non c’è cura a prescindere dalla relazione con essa in ogni sua forma, allora andrebbero rinsaldate le relazioni in ogni senso: con gli altri, con le cose, con il cielo stellato o pieno di nuvole in corsa, con quello che sta in luce e il buio insidioso che l’inghiotte – con sé. In una declinazione filosofica della psicoanalisi si potrebbe ricordare l’anelito verso un mondo condiviso, verso la consapevolezza che, per il giorno che ci è dato vivere, questo mondo è in comune. Da Eraclito fino a Kant è stato detto: chi vive in un proprio mondo privato, esclusivo, dorme, sta sognando. E il suo sogno è un incubo.







