La Patria non è più l’Italia tutta
Aree Interne: letteralmente sono “quelle aree caratterizzate da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi, in particolare quelli relativi all’istruzione, mobilità e servizi socio-sanitari”. Secondo i dati del governo vengono classificati come centri di 'aree interne' 3.834 comuni italiani, in cui abitano 13,3 milioni di persone. Il 25 per cento della popolazione nazionale. Il 67 per cento di questi paesi sono al Sud.
Ora il nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI) – approvato dal governo nei mesi scorsi – in continuità con l’impianto place-based proprio della originaria Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) su impulso di Fabrizio Barca (allora, 2013, ministro della coesione sociale) intende:
“rafforzare la competitività e la resilienza delle regioni… promuovere l'inclusione sociale e accompagnare i territori con riforme strutturali e il potenziamento della capacità amministrativa… investire nei servizi pubblici, come sanità, istruzione, e trasporti pubblici”.
Tuttavia – va detto – il piano introduce una differenziazione su base demografica tra le stesse aree interne dividendo i territori così definiti in categorie distinte: quelli “rilanciabili” e quelli “senza prospettive”. Per questi ultimi (centinaia e centinaia di comuni montani, collinari, rurali) lo Stato non prevede più politiche attive di contrasto allo spopolamento ma propone un “accompagnamento verso un declino irreversibile”. Niente più investimenti, in quelle aree fragili, per portare i servizi, scuole, sanità, trasporti così da attrarre giovani e creare lavoro? Certo nel documento del governo si pensa – qui uno dei passi più incriminati – a “un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita”.
Si arriva a legittimare dunque l’abbandono istituzionale di larga parte del territorio nazionale, accentuando il divario tra città e aree interne e tra le diverse anime di queste stesse, col rischio di compromettere – è il timore di molti – la stessa tenuta sociale del Paese. Difficile parlare forse di strategia, caso mai sembra più disuguaglianza istituzionalizzata, con Patrie riconosciute e altre, sottodimensionate demograficamente, no. Alcuni giustamente fan notare (tra gli altri Franco Arminio su “Huffington post”, primi di luglio) con un soprassalto di disagio e scandalo come non si possa adottare per le comunità di esseri umani la stessa logica del profitto utilizzabile per un investimento economico. Le persone sono titolari di diritti, non sono prodotti finanziari. Sono un patrimonio da preservare, tanto più in questo Occidente in vistoso calo demografico generalizzato. È una questione che richiama gli stessi principi costituzionali. Non argomenti esclusivamente economici.
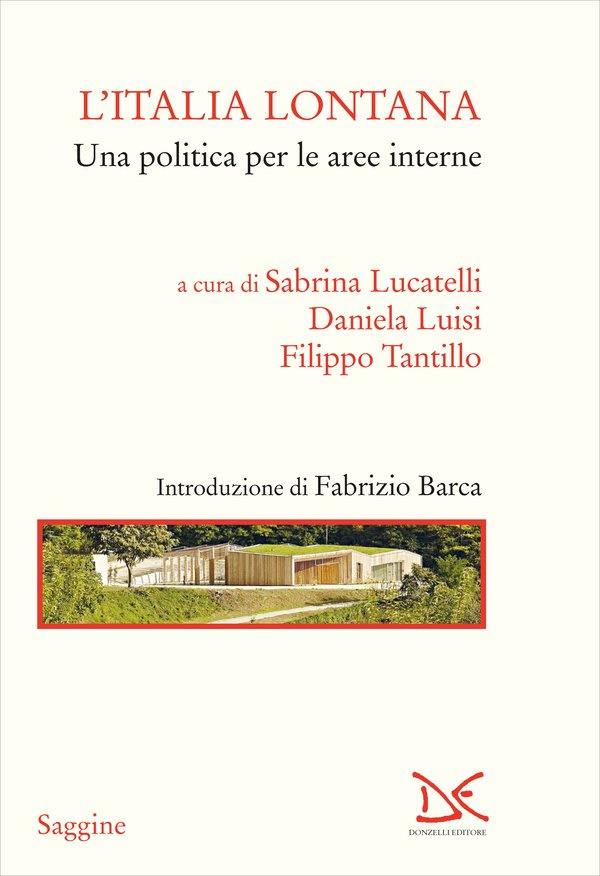
Del resto la Strategia nazionale per le aree interne di Barca era stata pensata non come semplice governante: vale a dire un’operazione tecnocratica volta a recuperare alla “normalità” del modello di sviluppo prevalente aree che ne sono rimaste escluse. Come Barca spiega bene nel volume Italia lontana. Una politica per le aree interne a cura di S. Locatelli, D. Luisi, F. Tantillo, Donzelli, 2022) è stata altra la valenza politica della SNAI. Rispondendo a una domanda su quanto l’attività economica in generale debba porsi il problema di far crescere non solo la ricchezza ma anche lo “stare bene”, di donne e di uomini che vivono in una determinata comunità, l’ex ministro afferma:
“Nel capitalismo, crescere – produrre più Pil, misurabile sul mercato – è uno dei fattori strumentali per raggiungere un pieno benessere. Nel capitalismo, lo sappiamo, la produzione organizzata sul mercato ha bisogno di un adeguato profitto – si noti bene, “adeguato”, soddisfacente e quindi comprimibile – altrimenti l’imprenditore non rischierà. Ma la ricchezza è solo una delle molteplici dimensioni, per lo più strumentale, dello “star bene, e quindi misurare il Pil serve, è la misura chiave del capitalismo, ma non esaurisce, tutt’altro, la misura dello “star bene”». E aggiunge: «È un cambio di prospettiva forte [...] La Strategia nazionale per le aree interne ce l’aveva dentro questo orientamento: gli indicatori suggeriti erano possibili misuratori dello star bene”.
E agiva secondo linee di azione privilegiate: interventi a favore della crescita economica ma insieme, a sostegno dell’espansione dei diritti di cittadinanza; una trasparente e rigorosa pianificazione territoriale; un metodo di co-progettazione finalizzato a far dialogare fruttuosamente competenze centrali e saperi locali; pieno coinvolgimento e responsabilizzazione delle autonomie locali, dei Comuni (S. Locatelli).
Certo questa scelta – nota Tantillo, ripreso da Costantino Cossu su “Dialoghi mediterranei” il 1° gennaio2024 – è entrata in conflitto sin dal principio da un lato con una cultura politica tradizionale e localistica molto restia a quella “cessione di potere” alla cittadinanza che è implicita nelle pratiche partecipative, e dall’altro con una cultura amministrativa fortemente centralistica. La stessa filosofia delle policy del Pnrr post Covid nelle sue ultime formulazioni non è quella dello sviluppo dal basso attraverso la valorizzazione delle risorse comunitarie e di pratiche alternative alle logiche di mercato finalizzate, allo “star bene”; semmai è quella delle grandi infrastrutture, dei progetti di sviluppo dei territori attraverso politiche decise centralmente e calate dall’alto.

Va detto che il governo stanzia per il rilancio (si fa per dire) delle aree interne 301 milioni fino al 2027. Per molti, tuttavia – se fuori da un contesto di medio-lungo periodo – saranno interventi spot, opere non concordate con le comunità, con ditte mirate e clientele elettorali. Per tutte queste ragioni il piano governativo (PSNAI) sembra portare alle estreme conseguenze, con la sperimentata inclemenza radicale nei confronti delle popolazioni fragili, le logiche di sistema.
È sconfortante prendere atto di quanto questa filosofia PSNAI, che poi diventa intervento politico, accentui ulteriormente gli squilibri territoriali, distinguendo tra aree interne salve e altre destinate a una fine prossima, in un Paese, il nostro, stretto già tra i Troppo pieni delle città e delle coste e i Troppo vuoti delle aree interne e della montagna povera. Così da destrutturare ancor più la dinamica centro-periferia e il rapporto città-campagna e ostacolare la realizzazione di quel cambio di paradigma cui tanti di noi, impegnati nel lavoro anche militante intorno a quelli che ho chiamato “paesaggi fragili”, si ispirano: dalla missione, non solo metaforica, della migliore antropologia (penso a Pietro Clemente) di portare il Centro in Periferia e di lavorare, (come fa Vito Teti) esemplarmente sulla Restanza alla riflessione preziosa dei Territorialisti sul riconoscimento del patrimonio territoriale presente nei piccoli comuni italiani, presidi a tutti gli effetti dei territori fragili, all’impegno inoltre del gruppo di Riabitare l’Italia che incentra i suoi sforzi proprio sulla sofferenza demografica e sulla contrazione insediativa di tante aree del Paese su cui si accanisce, così sembra, il PSNAI. Proprio in questi giorni su “Il Fatto quotidiano” Vito Teti, alla prospettiva della condanna a morte di migliaia di comuni oppone la necessità di ripopolare i paesi accogliendo quei nuovi italiani, molti, di cui il mercato del lavoro avrebbe bisogno come dicono l’Istat e Confindustria.
Tanto più, in conclusione, è importante scardinare, per contrastare questa narrativa darwiniana, le logiche attardate delle “geografie negative” imposte ieri alle aree interne e di confine nel disegno di sapore bellicista degli Stati nazionali e poi, nel corso di una industrializzazione sgovernata, a interi territori svuotati in favore delle città e delle pianure. Fino a decretarne ora, in conseguenza di quei processi, l’insostenibilità demografica via algoritmi e un destino di irreversibile declino.
Quando invece, nel delicatissimo corso dell’Antropocene, gli attributi più propri di queste aree fragili, il rispetto dei limiti ambientali anche dovuto alla mancata sovrappopolazione, l’argine alla cementificazione integrale in relazione al basso tasso di edificazione, in una parola la coevoluzione armonica tra insediamento umano e natura circostante, andrebbero valorizzati, rovesciandosi in positività, a monito della sopravvivenza stessa dei territori, di necessità ecocompatibili, nel futuro incerto che ci aspetta.







