L'amour, l'amour, toujours l'amour
Un libro, dunque, che dica dell’amore. La prima domanda che mi sono posta quando ho iniziato a leggere L’amore è cambiato di Annalisa Ambrosio (Einaudi 2025) riguardava le mie aspettative rispetto ai contenuti del libro stesso: cosa si può dire, in assoluto, dell’amore? Cosa può dire a me, questo libro, ai miei ventidue anni attraversati da tentativi più o meno rocamboleschi di tessere legami, e coltivarli, prendermene cura? Quanto è diversa la mia idea di rapporto a due rispetto a quella che troverò qui dentro? Con grande intelligenza, il libro di Ambrosio rifiuta di presentarsi come un prontuario per il mal d’amore contemporaneo; si incarica piuttosto di decostruire un mito – già in parte superato, nei fatti, nell’era post-romantica: il mito dell’amore romantico, nelle sue declinazioni di amore impossibile, tossico e bestiale.
In Per due come noi, una canzone di Brunori Sas, c’è un verso che dice: “Non confondere l’amore e l’innamoramento, che oramai non è più tempo”: è questo il punto cui giunge la riflessione contenuta in questo libro – distinguere l’amore dall’innamoramento, che è invece rimesso al centro come vero nucleo fondamentale della relazione a due.
Il ragionamento prende avvio da una riflessione di Michela Murgia in un’intervista rilasciata a Vanity Fair; la scrittrice paragonava l’innamoramento a una forma di malattia esantematica, come un morbillo: succede a tutti almeno una volta nella vita, ci si augura passi in fretta, poi – la scienza lo garantisce – non torna più, e siamo salvi. Una metafora interessante, in effetti, e però allo stesso tempo un po’ sbilanciata: mette in luce l’idea che l’innamoramento sia una forma di “vicolo cieco”, come nota Ambrosio, una condizione infausta dalla quale liberarsi il prima possibile. Meglio: dalla quale, per nostra fortuna, è certo che ci libereremo, prima o poi. Ambrosio muove proprio da qui: dal male che l’amore ci causa, tanto grande da spingerci a ridurlo a malattia dalla quale ci auguriamo di guarire. Ma dove sta l’errore? Perché siamo portati a ragionare così? L’inciampo sta, secondo Ambrosio, nella scelta di definire culturalmente l’innamoramento come “prima tappa di un cammino obbligato” quando invece – questa la sua conclusione – dovrebbe riacquisire la sua centralità.
Distinguere, dunque, l’amore dall’innamoramento – ecco la sfida. E giungere poi ad una riflessione aperta su cosa sia l’innamoramento, per rivalutarne gli effetti. Come fare? Ambrosio passa innanzitutto in rassegna i capi d’accusa rivolti all’amore.
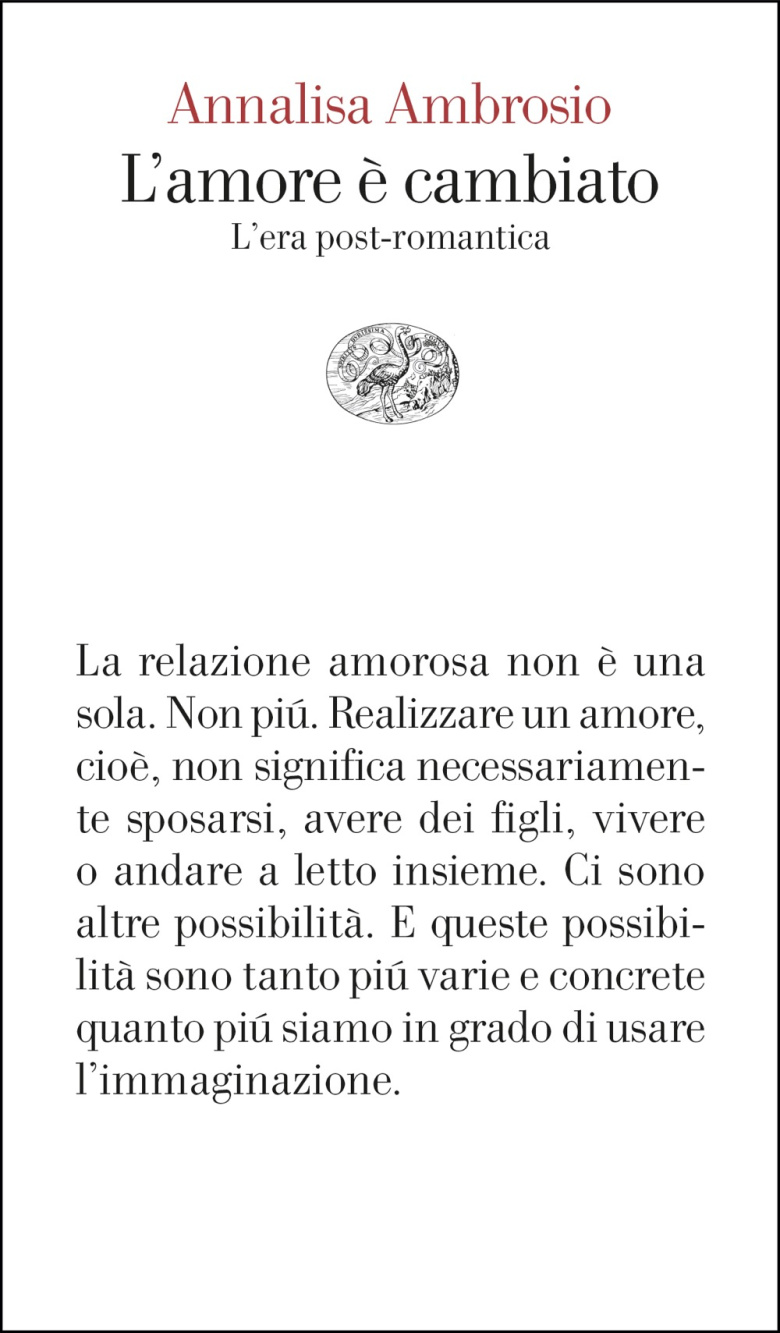
“La prima bugia […] suona così: un amore vero è intenso dal primo all’ultimo giorno e dura per sempre.” E vorrei prima di tutto notare che è forse quella che possiamo smascherare più facilmente, credo: un grande refrain delle conversazioni coi miei coetanei – siamo tutti figli, ormai, dell’era post-romantica – è proprio questo: vediamo come va. Da osservatrice e protagonista mi pare questa una grande verità alla quale approdiamo, seppure talvolta con fatica: sono sempre più rari i rapporti a due che nascono sotto il segno dell’intensità travolgente; siamo sempre, al contrario, più inclini alla cautela. Ambrosio sottolinea, convocando gli studi della sociologa Eva Illouz, che “un aspetto importante dell’utopia dell’amore romantico consiste proprio nella sua intensità combinata alla sua durata” – perché “è un dato di fatto che l’amore cambia forma e che è impossibile tenere la fiamma accesa per tutta la vita”. Lo sguardo è poi rivolto alla letteratura, campo in cui ci si è concentrati soprattutto sull’intensità amorosa, “descrivendo l’amore travolgente come qualcosa di incompatibile con la costrizione della durata” come insegna Anna Karenina. Ambrosio riflette su come la scelta sia ricaduta sulla rappresentazione dell’intensità perché culturalmente e giuridicamente la “forma contrattuale che ha provato a schematizzare la durata del rapporto amoroso è stata il matrimonio […] un contratto sottoscritto per sempre.” E così nel cerimoniale cattolico la formula diventa quella della fedeltà eterna, anche nelle avversità: “è commovente pensare che possa esistere un amore così, senza ombre, ma forse è commovente proprio perché è irrealistico, al pari di un cielo sempre azzurro o di un corpo sempre in salute?” si chiede l’autrice: la vita, in effetti, è molto meno rigida e schematica delle formule nelle quali scegliamo di incasellarla, talvolta. Ma l’insidia dalla quale Ambrosio mette in guardia, nascosta dietro questa promessa di duratura stabilità, è un’altra, “metafisica”, ma direi anche più pericolosa: “che da due si possa diventare una cosa sola, un ingranaggio privo di attriti per amalgamare insieme la passione del primo giorno e il passare del tempo”. Non dovrebbe invece essere un’altra la scommessa dell’amore più grande – accettare che l’altro resti altro da sé, accogliendo la fatica che questo comporta? “Restiamo due persone distinte, nella gioia e nel dolore, due individui che dentro hanno un oceano in costante movimento e che perciò hanno un sacco di argomenti su cui discutere. […] Per questo l’intensità e la durata si escludono spesso a vicenda e il mito dell’amore è falso e ci fa soffrire.” In un romanzo bellissimo di Natalia Ginzburg, È stato così, si legge: “Un marito è qualcuno che sai sempre dove si trova.” E se invece accettassimo di non sapere, almeno ogni tanto, dov’è l’altro?
Il capitolo quarto si sofferma sul nodo dell’amore tossico: “se si dovesse ricondurre a una frase sintetica la seconda bugia del mito dell’amore, suonerebbe: solo questo amore ti permetterà di realizzarti completamente, nonostante tutto.” E forse non siamo troppo lontani dal fare uno di cui abbiamo appena parlato: l’idea in gioco è quella di un amore totalizzante, “uno dei principali vettori di autorealizzazione di un individuo”. Il tema ha riguardato soprattutto le donne: “molte hanno pensato che la vita di coppia avesse un valore inestimabile, morale, incomparabile con qualsiasi aspetto economico, e in questo modo hanno scelto una forma di vita che le ha portate a diventare delle schiave d’amore.” Il tema è storicamente complesso, e il volto tragico della contemporaneità mostra invece quanto sia difficile per le donne sottrarsi a questo vincolo.
Ancora, un’altra bugia del mito dell’amore riguarda i corpi: non c’è sesso senza amore. “Dalla terza bugia del mito dell’amore deriva una grandissima sofferenza per tutti e tutte coloro che si spingono nelle braccia di qualcuno illudendosi ogni volta che il sesso sia solo un codice pin da immettere per accedere a qualcosa di più o di diverso, come assicurarsi dei messaggi di buongiorno e della buonanotte, auguri nel giorno del compleanno, pensieri nostalgici e voglia di fare insieme tante esperienze che non siano solo l’anticamera della vicinanza fisica”. La rivoluzione sessuale, nota Ambrosio, ha liberato il sesso dall’amore, ma com’è stato possibile, in prima battuta, che il sesso andasse giustificato con l’amore? Citando Foucault, Ambrosio porta a galla i costrutti sociali e culturali che hanno regolamentato il sesso, “andando a far coincidere le relazioni amorose con quelle sessuali e stabilendo dei cerimoniali in cui il sesso era cosa buona e delle occasioni in cui era cosa cattiva” – così la convinzione che ci non ci sia sesso senza amore ha portato ad una riscrittura delle regole di corteggiamento, “pratica ipocrita di fare una cosa per ottenerne un’altra, con una danza più lunga ed estenuante di quella degli altri animali.” Inevitabilmente, dunque, le nostre società “hanno stretto sempre di più e sempre più schematicamente le viti che tenevano uniti amore, sesso e famiglia, stabilendo dei confini netti per decidere cosa è lecito e cosa no.” Vorrei notare che anche questa bugia è tendenzialmente in via di decostruzione: mi pare di capire, guardandomi attorno, che ormai sia discretamente accettata l’idea del sesso senza amore. Non nascondo, però, che si tratta di una constatazione che faccio non senza perplessità, e che credo disponga sul tavolo nuovi interrogativi da tenere in considerazione, sui quali vorrei tornare a riflettere (tutti hanno a che fare, in qualche modo, con la precarietà dei legami e la mancanza di prospettive.)
Quello che abbiamo definito “mito dell’amore” altro non è che uno schema: un costrutto, il modo in cui la cultura occidentale ha rappresentato la parabola dell’amore di coppia – un modello evidentemente in crisi per ragioni che hanno a che fare con le bugie che vengono qui prese in considerazione. L’innamoramento presentato come “l’inizio dell’amore della vita, quella su cui si sarebbe fondata la costruzione della propria identità, del proprio conto in banca, e anche della propria felicità” è dunque un momento epifanico di illuminazione che avrebbe poi portato alla costruzione di una coppia salda.
Per ri-pensare l’amore è fondamentale “separare l’innamoramento e l’amore”, anzi, “una mossa di emancipazione decisiva per non finire a capofitto nel passato, in quella pericolosa continuità che ci fa soffrire.” In questo ripensamento c’è da chiedersi però se sia necessario trattare l’innamoramento “come una febbre o un prurito”: alla luce del fatto che non esiste più un itinerario definito e che non è detto che l’innamoramento ci porti dentro l’edificio della coppia tradizionale.

Questa la proposta: pensare l’innamoramento come esperienza umana dotata di valore autonomo, rivalutandolo come momento in cui ci si prospettano molte strade: “chiunque si sia innamorato sa che l’innamoramento è proiettivo, ti rimuove da dove sei ora per portarti in un’altra zona del tempo e dello spazio” perché da innamorati diventiamo “i narratori della nostra vita”, ci facciamo capaci di darle una o molte direzioni diverse: dunque l’innamoramento non è più l’anticamera della coppia, ma un laboratorio di futuri possibili, momento in cui proviamo a “riconoscere in una forma ignota il proprio ideale”, tentando di accettare la scommessa e la difficoltà che questo comporta, sorretti dal solo potere dell’immaginazione. Separato dal mito dell’amore romantico, l’innamoramento si carica di un’energia creativa e creatrice senza precedenti, e ci libera anche dalle catene delle aspettative: “nell’era del post-romanticismo un innamoramento può benissimo diventare un’amicizia, o un legame duraturo, o un rapporto speciale, di complicità o frequentazione. […] Se l’innamoramento è prima di tutto un lavoro dell’immaginazione trasformarlo in qualcosa d’altro non è innaturale, è ovvio.”
Mi interroga molto l’idea della carica immaginifica legata al momento dell’innamoramento: riconosco nella mia generazione, che pure è responsabile della creazione di tanti punti di vista nuovi, una certa stanchezza immaginativa nell’ambito delle relazioni. Sappiamo ancora immaginare il futuro dei nostri legami? Non sempre. È un paradosso, certo, e non saprei dire se quest’inerzia che mi pare di riscontrare sia da imputare al grande mare di precarietà in cui nuotiamo o ad una più generale reticenza di fronte alle responsabilità cui i legami a due ci richiamano.
Nelle ultime pagine del libro Ambrosio si sofferma sulla sofferenza che comunque si lega all’esperienza dell’innamoramento. Convoca ancora una volta la letteratura, che è un utilissimo serbatoio di immagini, menzionando il legame fra Marcel e Albertine nel romanzo di Proust. Marcel soffre quando Albertine si allontana: “solo il patire è in grado di dimostrargli che Albertine gli manca”. “La mancanza di senso dell’innamoramento, che a lungo abbiamo addolcito con l’idea del destino, è una mancanza di senso più ampia che investe il nostro essere”: sottrarre al destino il ruolo principe di autore delle nostre vite, rimettendo piuttosto al centro la nostra soggettività, illumina anche quest’aspetto: l’amore ci espone a una vulnerabilità buona, nostra, illuminando le zone più sbandate e balorde del nostro cuore. “Martha Nussbaum crede che la conoscenza dell’amore coincida con questa sofferenza e che questa sofferenza si debba piuttosto chiamare conoscenza. È la conoscenza di come vanno le cose tra le persone”. L’innamoramento, dunque, diventa così luogo del possibile in assoluto: luogo dei futuri possibili, e luogo privilegiato nel quale osservarci nelle nostre sofferenze, vulnerabilità e mancanze, perché “innamorati siamo poco filosofi e molto vivi, più vivi che mai, al punto da sapere (ed è quello il momento in cui l’acqua ci entra nel naso e non ci fa più respirare) che non lo saremo per sempre.” Una sofferenza connotata positivamente, dunque, rivelatrice, e che però è anche un problema: “siamo sempre più abituati a non subirla, a fare uso di antidolorifici”.
Innamorarsi, insomma, è così “il corso di vita più accelerato che c’è”: ci spinge a immaginare possibilità nuove, e ci porta però allo stesso tempo a vivere la grande contraddizione per cui liberi di sognare ci accorgiamo della vera natura dei sogni, esponendoci così ad un tasso di vulnerabilità che non sempre siamo disposti a tollerare. “Il punto non è che stiamo male, il punto è che stiamo guardando in faccia la realtà.” Un’esperienza, quella dell’innamoramento, “non tossica ma detossicante perché ci fa eliminare rapidamente tutto quello che non è utile per noi, svelando quello che conta davvero. E a contare davvero è che esistiamo e che il mondo ci attraversa.” Ma soprattutto: un’esperienza fra le altre, priva di qualsiasi carattere totalizzante, la cui eccezionalità risiede proprio nel fatto “che possiamo vivere quest’esperienza senza utilità”, facendo un passo indietro.
“Sarebbe un peccato rinunciare all’occasione di sentire così a fondo, ma d’altra parte è troppo semplicistico pretendere di costruirci qualcosa sopra, e per di più, giurare che sarà per sempre”. Torna, in conclusione di questo libro, qualcosa cui pensavo leggendo Erotica dei sentimenti di Maura Gancitano: “L’educazione sentimentale è un esercizio infinito e quotidiano che prevede di raggiungere una conoscenza profonda di sé e degli altri” – non sono sicura, ammetto, sulla possibilità granitica di possesso di conoscenza, ma credo nel valore dell’esercizio di cui Gancitano e Ambrosio parlano, nella reciprocità che la sfida dell’innamoramento comporta, nella necessità di capire come star bene, con se stessi e con l’altro da sé. Forse questo è il nodo che resta identico, mentre tutto il resto, pian piano, cambia un po’.
In copertina opera di Ron Hicks.







