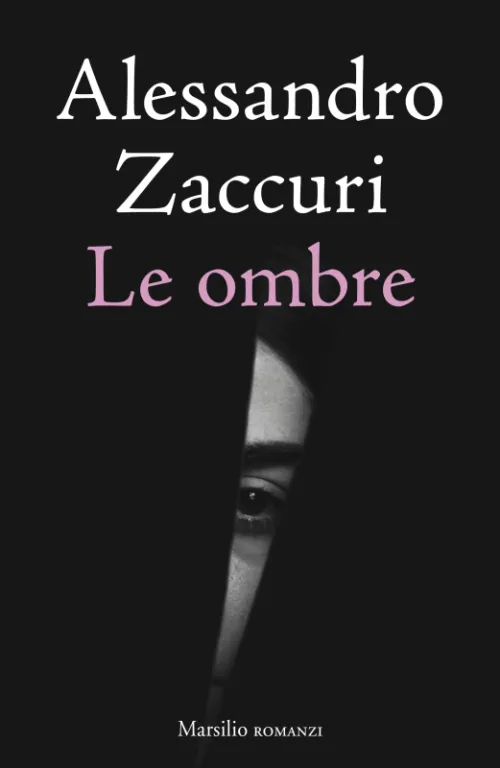Zaccuri: “dice il vero, chi dice ombra”
Guardati in giro: / lo vedi, che il vivo è dappertutto – / Prossimo alla morte, ma vivo! / Dice il vero, chi dice ombra.
Nella poesia Parla anche tu, Paul Celan invita a parlare senza “dividere il sì dal no”, a dare voce al proprio pensiero, a “dargli ombra”, perché nell'ombra dimora la verità, “Lì, nel luogo della mente dove opacità e lucore, vita e morte si fronteggiano l’una presso l’altra […] l’ombra e la verità vanno a braccetto, e la parola autentica con loro”, scrive Massimo Morasso su doppiozero.
L’ombra è luogo di prossimità e relazione tra luce e oscurità, vita e morte, realtà e immaginazione, uno spazio di ricerca della verità tra la superficie luminosa dell’apparenza e gli abissi cupi dell’oblio.
Il romanzo di Alessandro Zaccuri, che alle ombre è intitolato, (Le ombre, Marsilio Editore, 2025), indugia a lungo in questo interregno scuro, dove la luce filtra polverosa, tra scuri chiusi e memoria, e le ombre si muovono come incubi, abbagli e ricordi confusi.
Salvo, il protagonista, trascorre lunga parte della narrazione disteso in un letto, in una stanza buia, ostaggio delle ombre, in quella che sembra, di volta in volta, prigione o rifugio, incastrato tra sogno e realtà, mentre cerca di ricomporre, nel buio, ricordi e visioni, di ricostruire il momento in cui la sua strada prende una deviazione improvvisa e la sua storia deraglia.
Salvo è l’ultimo figlio di Don Ciccio e, nonostante i diritti di primogenitura, viene investito dal padre del privilegio di succedergli al vertice della famiglia, e lui attende con orgoglio e una certa impazienza di raccogliere il peso e l’onore del comando.
In apertura del romanzo, con il padre e i tre fratelli, vive in “soggiorno forzato” in un piccolo borgo del comasco, appena sotto il confine svizzero, e, mentre le donne e i figli li attendono in un sud nostalgico e remoto, gli uomini si trovano a difendere il nome e il potere della famiglia tra “gente su cui non si poteva fare affidamento: non conoscevano l’onore, non avevano mai voluto ammettere che grand’uomo fosse Don Ciccio. Lo chiamavano “il mafioso”, figurarsi. Che ne sapevano loro? Cresciuti sotto il sole pallido del confine, nemmeno si immaginavano che cosa significasse nascere in una terra spaccata dalla siccità e dal vento, dove ogni raccolto te lo devi conquistare con il sudore della fronte e le novene a San Michele”.
Salvo e la sua famiglia, avevano già trovato spazio tra le pagine di Zaccuri in un precedente romanzo, Lo spregio, che seguiva la storia del Moro e di suo figlio Angelo, impegnati a gestire una locanda tra le montagne a poca distanza dalla residenza settentrionale di Don Ciccio e dei suoi figli, destreggiandosi senza troppi scrupoli o fatica tra loschi affari di contrabbando e prostituzione.
Salvo e Angelo stringono un’amicizia tanto profonda quanto lacerante sarà la cesura causata dallo spregio del titolo. Salvo è colui che scampa a quel legame interrotto e lo ritroviamo nel nuovo romanzo, nella stessa casa, al capezzale del padre in fin di vita, pronto a ereditarne autorità e potere.
Lo spregio aveva già indagato la fragilità delle relazioni e dei legami maschili – paterno, filiale e amicale – segnati da eredità affettive ingombranti e rigidi schemi impliciti, e le difficoltà di tenere insieme, oltre alla spartizione di territori, affari e giurisdizioni, codici morali diversi e distanti, di tradurre dai silenzi dell’altro il linguaggio dell’onore, della fedeltà e della sopravvivenza.
Le ombre si gioca invece su dinamiche di potere interne alla famiglia, dentro un vocabolario condiviso, rudimentale e spietato, in un sistema di rapporti familiari fondato su gerarchie, alleanze, vincoli di sangue e obbedienza, su un equilibrio fragile di poteri in cui la tradizione diviene regola e il comando si conquista a caro prezzo.
In questo nuovo romanzo tornano i temi del tradimento, del rispetto di dinamiche familiari e di potere stringenti, ma muta il paesaggio, che passa dai boschi fitti del comasco, con la nebbia che sale come una certezza, a un Meridione indeterminato ma riconoscibile, dove la vegetazione si dirada, la siccità spacca la terra e i vuoti si riempiono di superstizione e magia. E con esso muta anche la grammatica del potere, il modo di decifrare gesti rituali, la colpa e l’onore, e sarà Salvo, questa volta, a dover fare i conti con la responsabilità dell’infrazione della regola, la violazione dell’ordine riconosciuto per tracotanza, ambizione, eccessiva fiducia o ingenuità.
Salvo, con i suoi vestiti griffati, il pallino della tecnologia e il desiderio di affermazione, con le sue letture e aspirazioni, che gli fanno guadagnare il soprannome “il professore”, Salvo che progetta di dismettere gli archivi di ferro e carta del padre, di digitalizzare gli affari opachi della famiglia, che immagina un nuovo corso e una nuova leadership e si approssima a scardinare un ordine fondato sulla ripetizione e sulla ritualità delle tradizioni, una liturgia sulla cui immutabilità si reggono senso, coesione e potere.
Proprio quando, alla morte del padre, si sente pronto a raccogliere l’investitura, Salvo deve lasciare il Nord in cui ha coltivato ambizioni e sogni di rivoluzione per iniziare la discesa verso la terra d’origine, verso le radici del potere familiare, un ritorno simbolico che ha il senso di un’iniziazione e il presagio di una resa dei conti. Lungo la strada di questo nostos tanto desiderato, accade qualcosa che interrompe il destino atteso e dà il via a un’altra storia.
Salvo si ritrova steso su un letto, attraversato da lampi di ricordi che incendiano la memoria e la inceneriscono, “si svegliò come ci si sveglia dentro i sogni”, nella penombra polverosa di una stanza quasi spoglia, con la luce scarsa che filtra tra le stecche delle persiane chiuse e un comò con quello che pare uno specchio, ma è coperto da un drappo, come nelle case dei morti.
“Il fuoco si era bruciato anche il tempo, questo doveva essere successo, e la sua memoria adesso era smangiata ai bordi e bucata al centro, come una fotografia buttata in un falò”, e dentro quel silenzio la voce di Agata porta una promessa di salvezza, elargita come una grazia.
Agata, maestra di scuola rimasta vedova a pochi giorni dal matrimonio, che porta il lutto come un segno di regalità e in paese è soprannominata Maria Stuarda, appare come una figura tragica ma risoluta, seducente e altera. Affidabile e fedele alla famiglia e alle tradizioni, viene chiamata al Nord per assistere Don Ciccio nei suoi ultimi giorni e ricompare poi accanto a Salvo, mentre è trasportato verso la casa della Santabella, fattucchiera nota in paese per conservare il segreto di un medicamento capace di ricucire strappi e ferite e di cacciare il fuoco dal corpo, che vive tra le montagne insieme a Bettina, sua aiutante poco più che adolescente, e a Carmine, taciturno custode del fuoco che scalda senza fine l’unguento miracoloso.

Se in Lo spregio il femminile era marginale – rappresentato dalla madre di Angelo, silenziosa, amorevole e mite, e dalla donna che il giovane frequenta, con poca costanza e scarso trasporto – e articolato tra i due poli lontani dell’accudimento e della carnalità, qui le figure femminili emergono con maggiore autonomia, conquistano fascino, ambiguità e potere, proprio in virtù delle ombre e delle contraddizioni che le attraversano.
Agata, la Santabella e anche la giovanissima Bettina, incarnano un femminile materno e seduttivo, capace di ammansire, manipolare, stregare e tradire, esercitano un potere magnetico e indecifrabile a cui Salvo, risolutamente consacrato a un potere maschile che intende sfidare, finisce per soccombere.
La casa della Santabella compare risalendo una strada di montagna, tra la boscaglia rada, in un deserto di pietre e olivi, dentro una valle da cui affiora il filo di fumo che sale dalle fondamenta della casa, dalla grotta in cui mani di donne da secoli preparano l’unguento capace di mettere riparo ai disastri del fuoco, levigare cicatrici, liberare la pelle dal morso delle ustioni, cancellarne i segni, restituire una pelle nuova, trasparente, immacolata.
In paese tutti conoscono la leggenda della Santabella, anche Salvo doveva essere stato esposto, durante l’infanzia, a quella mitologia popolare, prima di dimenticarla per votarsi ad “altre superstizioni, i soldi, il potere, le solite illusioni”.
Costretto nel suo letto di degenza, immobilizzato e solo, Salvo si lascia curare dalla Santabella, che insieme a Bettina spalma l’unguento sul suo corpo che ancora conserva la memoria del fuoco, mentre intreccia, in un dialetto arcano, litanie che, unite alle proprietà taumaturgiche del preparato, liberano la carne dalle fiamme e dai segni che queste hanno lasciato.
Senza luce né riferimenti, Salvo può fare affidamento solo sulla sua mente e sui ricordi che affiorano e vengono smantellati con affettazione e condiscendenza dalle donne che lo assistono; in balia delle cure e del dominio di queste, Salvo deve lasciare progressivamente il controllo sul suo corpo e sulla sua mente.
E mentre la sua carne risponde alle cure e si rigenera, dimenticando l’affronto del fuoco, compaiono ombre, sussurri, dubbi e sospetti, e l’inquietudine di non saperli decifrare, l’umiliazione di dover chiedere spiegazioni, di permanere in una situazione di impotenza e subordinazione.
La voce narrante, una terza persona che sembra condividere lo sguardo del protagonista, i suoi ricordi, le sue aspirazioni, si incrina di colpo, al momento dell’incidente, quando tutto si fa buio, e riprende a fatica le fila del racconto, facendosi strada tra le ombre, nel tentativo di proseguire la storia di Salvo con il presentimento che qualcuno, forse, la stia già riscrivendo.
L’attraversamento del buio occupa la maggior parte del libro, un lento processo di smantellamento delle certezze scandito da indizi, sospetti, allucinazioni e barlumi di speranza che conduce a una rivelazione amara: nel mondo di Salvo la verità non appartiene a chi la persegue, ma a chi detiene il potere di raccontarla. A questi spetta il compito di fare luce sulla storia, con quel gesto tramandato e riconosciuto, di sedersi, spalancare le mani e passare i palmi sulle cosce – lo stesso che usava Don Ciccio “quando si sentiva costretto a spiegare qualcosa di troppo evidente per dover essere spiegato” – per ribadire che le cose vanno come devono andare, come sono sempre andate.
Comanda chi custodisce le regole su cui il potere si fonda, chi è in grado di portare con disciplina e ferocia il peso che esso comporta, chi accetta il posto che gli spetta senza rivolta.
La storia di Salvo è il paradigma di queste leggi e in questo romanzo, così come aveva fatto nel precedente, Zaccuri descrive l’arco di un destino che si compie dentro un sistema chiuso, in cui ogni gesto di ribellione è previsto e soffocato e, senza l’illusione di un’impossibile assoluzione, va in cerca dell’umanità che resiste, oltre le leggi del potere e della sopraffazione.
Entrambi i romanzi, Lo spregio e Le ombre, finiscono con un sacrificio, reale e simbolico, una resa che serve a preservare lo stato delle cose. Se nel primo libro c’erano una risalita e la neve e, tra il bianco sporco, la possibilità di un ultimo gesto d’amore, il secondo si conclude con una discesa e con il fuoco, un’occasione di espiazione e purificazione, la possibilità di cambiare pelle e rinascere a nuova vita. Ma in entrambe le storie non c’è salvezza, l’espiazione non redime, il sacrificio non libera, nel mondo in cui si muovono questi personaggi la colpa non si estingue, si tramanda, come gli antichi rituali, le leggende, i segreti.
Leggi anche:
Ludwig Monti | Alessandro Zaccuri: libri che pregano
Mario Barenghi | Poco a me stesso: un'autobiografia alternativa
Chiara De Nardi | Scrittori e alberi