Blanchot e il silenzio delle parole
“Il nome dell’arco è vita; la sua opera, morte. /Chi sfuggirà al fuoco che non si addormenta mai?” (Eraclito)
Questa epigrafe posta a exergo del libro di Maurice Blanchot La parte del fuoco (Gallimard, 1949; trad. it. Il Saggiatore, 2025), è rivelatrice. La totalità scandalosa del suo essere critico e filosofo, ma non totalmente né critico né filosofo, è la molteplicità di uno scrittore che non sfugge alla “parte del fuoco”. Un fuoco insonne, ininterrotto. Blanchot è assorto nella costante presenza di un linguaggio che scrive se stesso senza definirsi in formule e senza appiattirsi in generi. Chi lo conosce sa quanto sia difficile (e non necessario) distinguere, nella sua opera, fra prosa narrativa, critica e filosofica. La poetica di Blanchot è il gorgo di una riflessione che si aggira nei confini-non-confini della transe, libro dopo libro. La sua parola plurale, sempre detta e sempre nascosta, non prevede una fine così come non prevede un inizio.
René Char dedica a Blanchot questa frase: «Si avvicina il tempo in cui solo ciò che seppe rimanere inesplicabile potrà aver bisogno di noi» (Maurice Blanchot, noi non avremmo voluto rispondere. In Maurice Blanchot, Riga 37, a cura di Giuseppe Zuccarino, p. 8). Parole che appaiono puntuali ed esatte: il tempo in cui l’inesplicabile ha bisogno di noi è sempre quello del poeta. E poeta si rivela Blanchot, rispondendo a Char con queste parole: «...Mi affido alla sua parola, la parola del testo poetico, e le rimarrò fedele: mantenere la rosa, mantenere la protesta, e, sparendo, ricordare, al di fuori di ogni ricordo, che l’inesplicabile consolazione prosegue, comincia. Non oltrepasserò più la prima pagina» (Riga, cit. p. 85). Blanchot, per Char, pronuncia questo definitivo commento: «Uno degli elementi della grandezza di René Char, per cui non ha eguali di questi tempi, è il fatto che la sua poesia è la rivelazione della poesia... e, come dice Heidegger a proposito di Hölderlin, una poesia dell’essenza della poesia. In Marteau sans maître, così come in Seuls demeurent, l’espressione poetica è la poesia messa di fronte a se stessa e resa visibile, nella sua essenza, attraverso le parole che la ricercano. Feuillets d’Hypnos, «queste note» di un «partigiano» scritte di getto giorno dopo giorno nelle difficoltà dell’azione e nell’assillo degli eventi, contengono le parole poetiche più forti e più semplici che la poesia abbia mai utilizzato per chiarirsi e riconoscersi» (La parte del fuoco, tr. it. di Andrea Pitozzi, Il Saggiatore, 2025, p. 115).
La necessità che la scrittura non sia solo un fatto letterario e testuale ma anche e soprattutto una realtà ontologica, un permanente “inizio”, è la necessità poetica dalla quale Blanchot non potrà mai prescindere. Quando definisce l’opera di Henri Michaux “mistero senza enigma”, coglie l’essenza dello scrittore-pittore, delineandone un ritratto critico che non lo delimita e non lo definisce ma, al contrario, ne amplia e contamina i confini. Chi si confronta con Blanchot è certo che l’oggetto della sua ricerca sarà destinato a sfuggirgli e non potrà che arrendersi a un materiale mobile e inquieto, estraneo ai codici interpretativi. Non ama, il critico-scrittore, nulla che definisca una forma precisa: rifiuta che una fotografia rappresenti il suo corpo come detesta parole troppo esatte e conclusive. Sceglie una zona di bonaccia, una conradiana “linea d’ombra” nella quale nascondersi con il dovere di navigare.
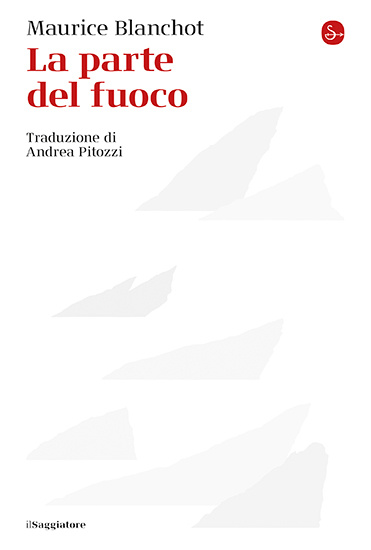
Per Blanchot parlerei di una vertigine ontologica che non riguarda né temi né stile né pensiero ma l’esigenza insopprimibile della scrittura. È come se Blanchot, pur dichiarando di non “oltrepassare la prima pagina”, aggira questo divieto e orchestra in ininterrotte variazioni proprio quella prima frase, che ci serve da porta scorrevole per entrare nel mistero della sua opera. Intessuta di estetica, pensiero, filosofia, teorie critiche e politiche, articolata in innumerevoli libri, saggi, interviste, contraddittoria, interminabile, geniale, intricata nei propri temi come in una gabbia che si spalanca, è un’opera che sviluppa all’infinito il suo inizio. Testimonia il suo Celan: “E cadiamo: / Eravamo. Siamo. / Siamo, carne e notte, insieme. / Nei viali, i viali”. Blanchot allontana la caduta e continua a cadere. Parla, anche se è “l’ultimo a parlare” (L’ultimo a parlare, Il Melangolo, Genova, 1984. traduzione di Carlo Angelino). Il pudore originario è mascherato da una polifonia di parole che riportano, tutte, alla notte definitiva del silenzio. Per lo scrittore esiste il “qui e ora” di una scrittura magnetica, senza andata e senza ritorno, un il y a attuale/inattuale a cui, su un piano epigrammatico-narrativo, solo Jabès si è forse avvicinato, redento dalla salvezza delle sue parabole. Blanchot, invece, nella sua narrativa raramente esplorata dalla critica (fa eccezione Giuseppe Zuccarino nel suo volume Immagini sfuggenti. Saggi su Blanchot, Milano, Mimesis, 2018, dove analizza il romanzo blanchotiano più perturbante, Le Très-Haut), si è cimentato con romanzi indecifrabili e irredimibili, come Thomas l’obscur. «È esattamente questa alternanza, fatta di sospensione e scoperta, di frustrazione e desiderio continuamente rilanciato, che si esperimenta leggendo i testi narrativi di Blanchot, già a partire da questo suo primo romanzo. Si è all’oscuro, come il protagonista eponimo, e ci si inoltra nel buio» (Luigi Grazioli, Blanchot l'oscuro, in Doppiozero).
Il progetto di Blanchot è diffidare del linguaggio e affidarsi alla scrittura. Più ci si inoltra nelle sue opere più si ha la sensazione di essere dentro una foresta arcaica, dove contano solo gli archetipi della scrittura e della morte, ma in realtà nulla è tangibile se non il silenzio segreto della sua parola plurale, inclassificabile. La “parola plurale” trova nell’intermittenza e nell’interruzione la posizione migliore per auscultare il fuori, l’ignoto. Che cosa sia poi il fuori e l’ignoto, l’”assenza d’opera” che sfonda attraverso la scrittura la monumentalità culturale del libro, neppure Blanchot ce lo spiega con chiarezza. Siamo in presenza di «buchi neri» della lingua che tentano di sfuggire a ogni concetto. La scrittura è turbine rarefatto, astratta tempesta, indefinito rovesciamento: nel fondo, l’“attrazione” del rapporto impossibile con Proteo. Proteo è chiaramente figura dell’inafferrabilità, come Tiresia è l’indovino che proferisce la verità in quanto mistero. Scrivere è stare dalla parte della notte, dalla parte di Proteo: è viversi come Tiresia che conserva il mistero e non come Edipo che lo risolve con la violenza conoscitiva.
Pur corteggiando temi filosofici, lo scrittore non vede, nella filosofia, l’ultima possibilità dell’uomo: quella possibilità la vede, la sente, sempre e soltanto nella scrittura che, segreta e oscura, arriva, oltre la volontà umana, all’interno del disastro del linguaggio. «Certamente si può scrivere senza domandarsi perché si scrive. Ma uno scrittore che guarda la sua penna tracciare delle lettere ha forse anche il diritto di sospenderla per dirle: Fermati! Cosa sai di te stessa? A quale scopo continui? Perché non vedi che il tuo inchiostro non lascia tracce, che tu avanzi liberamente, ma nel vuoto, che se non incontri alcun ostacolo è solo perché non hai mai lasciato il punto di partenza? Eppure scrivi: scrivi senza sosta, mostrandomi ciò che io ti detto e rivelandomi ciò che so; gli altri, leggendo, ti arricchiscono con ciò che essi prendono da te e ti danno ciò che tu insegni loro. Ora ciò che non hai fatto è fatto; ciò che non hai scritto è scritto: sei condannato all’incancellabile» (La parte del fuoco, op. cit, p. 321).
Blanchot, pur votato a questa scrittura incancellabile, crede essenzialmente alla verità del silenzio. Leggere/scrivere hanno un solo scopo: vivere la misura del disastro, del costante varcare un abisso per essere fuori di sé. Ogni risposta interroga la domanda, sempre inopportuna e fuoritempo, come un’illuminazione senza luce. Il critico ci avvisa, da punti diversi della sua opera-arcipelago, che la scrittura ha bisogno delle forme dell’arcipelago per definire la sua natura profonda di gorgo. Essere inghiottiti dal silenzio è la meta finale, ma non senza avere prima mostrato l’interminabile scia di parole che ci avvolgono. Così Blanchot scrive di Kafka: «La morte è laggiù, il grande castello che non si può raggiungere, e la vita era là, paese natale che si è lasciato seguendo un falso richiamo: ora non resta che lottare, lavorare per morire completamente, ma lottare significa vivere ancora, e tutto quello che avvicina allo scopo rende lo scopo inaccessibile» (La parte del fuoco, op. cit, p. 321).
Lo scrittore è un uomo concentrato solo nella sua vita interiore, un uomo che vacilla in regioni troppo elevate per i comuni mortali e vacilla solo, senza il sostegno di nessun compagno, condannato non a una morte risolutiva ma all’infinito, lungo tormento del morire. Come accadrà realmente a Blanchot, che si spegnerà ultranovantenne, afflitto da malattie invalidanti, non smettendo di dire e di sognare il non-dire. L’atto critico, disseminando scritture nel silenzio, ci assicura che non verrà mai a mancare la parola, perché la parola deve sempre mancare: la sua presenza è simultaneamente eco di un silenzio interminabile e scia di un’onda che mormora la sua “conversazione ininterrotta”. In Blanchot non esiste, nonostante la molteplicità dei suoi libri, una seconda pagina che continui la prima o la chiarisca, ma mille altre pagine che espandono la prima. Nulla limita l’inesauribilità della sua scrittura, che varca la forma visibile del saggio per suggerire una conversazione insondabile e segreta con la morte.

Nel suicidio premeditato del Kirillov dostoevskiano dei Demoni Blanchot sottolinea l’integrità di un atto che si oppone all’immensa indecisione della morte: il suicida si ritaglia lo spazio della fine personale, della sua “possibilità” di uscire dal vivente. Ma Blanchot prosegue, in modo originale, altre considerazioni: «La morte volontaria è rifiuto di vedere l’altra morte, quella che non si afferra, che non si raggiunge mai, è una specie di negligenza suprema, un’alleanza con la morte visibile per escludere quella invisibile» (Ibid. p. 87). La morte con cui da sempre lo scrittore si è alleato non trova riparo nella verità conclusiva dell’atto compiuto (il suicidio) ma nell’atto eterno e ripetibile della scrittura.
Nell’intervista apparsa in “Le Monde” il 22 luglio 1983, Dix écrivains et la gloire Blanchot risponde a cosa significhi la gloria per uno scrittore contemporaneo. Il breve testo, Nous travaillons dans les tenèbres (Noi lavoriamo nelle tenebre, a cura di Giuseppe Zuccarino, I libri dell’Arca, Edizioni Joker 2006), mette in crisi la natura stessa dell’intervista e rivela l’essenza del pensiero blanchotiano. Ne cito alcuni brani: «...scrivere sì, ma perché scrivere? Per poter morire (contento); e come gli sarà possibile scrivere? Solo se acconsente a ritirarsi dal mondo, ad entrare nella solitudine mortale; da cui quest’altra formula: morire per poter scrivere. (…) Scrivere è certo un lavoro, ma del tutto irragionevole, che non si giustifica e che nessuna ricompensa potrebbe soddisfare. Scrivere: un’esigenza singolare (chiamiamola bizzarra), più etica che estetica, poiché risponde a un “si deve”, senza obbligo né sanzione. È ancora al nostro vecchio maestro Henry James che sarebbe forse più giusto richiamarci per esprimere la stranezza di quest’esigenza, con cui né la gloria, né la fama, né la popolarità possono avere nulla a che fare: “Noi lavoriamo nelle tenebre – facciamo quel che possiamo – diamo ciò che abbiamo… Il nostro dubbio è la nostra passione, e la nostra passione è il nostro compito. Il resto è la follia dell’arte”. È una confessione? Orgogliosa o patetica? Ognuno è libero di giudicare» (ibid. pp. 62-63).
Ma a cosa servono i giudizi? Esiste solo la verità dell’abisso, che Blanchot, dalle sue pagine, conferma ancora e sempre: «Così la verità poetica ne ha deciso la sorte. La disfatta di Baudelaire, la sua lotta negli ultimi mesi contro le parole che lo tradivano, tutta questa difficoltà che altre migliaia di malati sconosciuti, afflitti dallo stesso male, condividono con lui senza smuovere la storia letteraria, sembra la fine eroica di una contestazione in cui si uniscono, per qualche istante, il tutto è abisso della parola e le poesie sicure, calme e belle che lo hanno guidato. Sacrificio ultimo con cui il poeta, senza saperlo, è portato a perdersi per realizzarsi e rendere presente la poesia sempre a venire, sempre da fare» (La parte del fuoco, op. cit. p. 151). L’esperienza di Blanchot è fuori linguaggio, fuori discorso, fuori vita: è scrittura di una scandalosa totalità, consumata come taccuino notturno ai margini del ‘libro a venire’. «Così, l’arte è il luogo dell’inquietudine e del compiacimento, quello dell’insoddisfazione e della sicurezza. Ha un nome: distruzione di sé, disgregazione infinita, e anche un altro nome: gioia ed eternità (ibid. p. 37).
Commentando le lettere ai familiari dell’ultimo Rimbaud, Blanchot osserva come lo stile del poeta sia piatto e secco, ma non se ne stupisce: ormai l’autore di Une saison en enfer ha cancellato ogni lirismo. «Scrivere ai “suoi” nella forma delle Illuminations, in questo si sarebbe mostrato incoerente, e una simile incoerenza avrebbe potuto essere segno di rovina. E poi, perché il linguaggio non avrebbe dovuto abbandonare Rimbaud, se scrivere non era più niente per lui?» (ibid. p 175) Blanchot ci dimostra come, per lo scrittore autentico, sia indispensabile accettare anche il deserto interiore, perché l’atto della scrittura si consuma solo nella totale sincerità, dalla “parte del fuoco”. Con un atteggiamento non diverso il critico si affida alla “ragione” della follia parlando di Poésie ininterrompue di Paul Eluard: «Prendere forma dall’informe/ Prendere traccia nella vaghezza/ Prendere senso nell’insensato: Non sta forse venendo alla luce nella poesia stessa, la forma del mistero della poesia e delle Lettere, se qualunque sia la follia a cui aspirano le parole, queste si fanno sempre una ragione della loro follia e ci conducono più in profondità all’interno di questa notte trasparente dove la notte non è che sottintesa» (ibid. p. 72). L’interminabile “sottinteso” di Blanchot è letteralmente il silenzio delle parole, quello che contiene la verità di tutte le parole scritte.
Leggi anche:
Luigi Grazioli | Blanchot l’oscuro
Silvia Vizzardelli | Maurice Blanchot: Per l'amicizia
Giuseppe Zuccarino | Blanchot e il superamento del libro







