Pontiggia leopardiano
In una intervista a Giuseppe Mendicino in occasione della pubblicazione di Nati due volte, Pontiggia affidava ai suoi lettori una possibile chiave di lettura del libro che era allo stesso tempo la dichiarazione di uno stile di vita: «Ci si innamora di quello che uno ha, la cosa straordinaria nei rapporti d’amore è che quello che uno ha appare come totalità». Apparentemente lontano dalla tensione leopardiana a un desiderio indefinito e indeterminato, incolmabile per natura, il suggerimento di Pontiggia è – osservato nel profondo – una delle attivazioni e dei riusi più belli e originali di quel passaggio zibaldoniano in cui Leopardi invitava a pregiare il poco: l’uomo superiore, «colla cognizione e sperienza del mondo, si può dire, benché sembri un paradosso, che si avvezzi a pregiare piuttosto che a dispregiare». Costui infatti, «trovandosi sempre in mezzo ad eccessive piccolezze, malvagità, sciocchezze […] si avvezza a stimare quei piccoli pregi che prima spregiava, a contentarsi del poco, a rinunziare alla speranza dell’ottimo o del buono» (Zibaldone, ff. 255-256 del 30 settembre 1820). Nella “strage delle illusioni” in cui il sapiente impara a vivere, l’uomo moderno e razionale, emblematicamente rappresentato da Filippo Ottonieri, deve necessariamente smettere di cercare «le maggiori felicità» e «pascer[si] delle minime, e anco da poi che sono passate, rivolgerle e assaporarle a bell’agio colla memoria» (Leopardi, Poesie e Prose, a cura di R. Damiani, vol. II, Milano, Mondadori, 1988, p. 142). Meditando su questi precetti morali, Leopardi vi trovava poi una singolare ed efficacissima sintesi nel «detto scherzevole» tratto da una incisione settecentesca di Larmessin: Glissez, mortels, n’appuyez pas, nel quale vedeva compendiata «tutta la sapienza umana, tutta la sostanza e il frutto e il risultato della più sublime e profonda e sottile e matura filosofia» (Zibaldone, f. 304 del 7 novembre 1820). Si tratta di un motto che ben potrebbe applicarsi al modus operandi (cioè al modus vivendi) di Pontiggia che, lontanissimo e anzi nemico di ogni patetismo, punta nella sua rilettura leopardiana a sottolineare e potenziare quei passaggi che con maggior forza ed emblematicità svelano la loro natura di architettura del reale; come afferma in L’isola volante, la letteratura è infatti e prima di ogni altra cosa ricerca speculativa che convoca verità e bellezza, cioè stile.
D’altro canto, come scrive nelle primissime pagine di I contemporanei del futuro, non possiamo dimenticare che i classici della letteratura chiamano in causa ab origine una nozione di disposizione e configurazione del mondo: nella loro provenienza etimologica dalle classes in cui era diviso l’esercito romano, essi avevano parte nel determinare, insieme al censo, il regimen morum cioè nell’offrire quell’ordine senza il quale nessuna «intelligibilità del mondo» sarà possibile. Memorabile a tal proposito la paginetta in cui Pontiggia, a partire dall’incipit del De bello gallico, spiega come rendere comprensibile una esperienza significhi passarla al setaccio di un atto di ordinamento stilistico: il celebre “Gallia est omnis divisa in partes tres” non è altro allora che un atto di grammatica dello sguardo. E la medesima attitudine si ritrova nel Leopardi che conosce guardando e delimitando il mondo: la siepe, la finestra del paterno ostello, la biblioteca o il crinale del Vesuvio sono altrettante strategie di una gnoseologia poetica che si esplica a partire da un intervento ordinatore.
Guardare al passato, al proprio rapporto con i padri, significa dunque per Pontiggia ordinare in prima istanza, ma in un secondo inaggirabile momento, ricondurre a noi, pensare quei padri in relazione al presente, per dargli consistenza e immaginarlo (cfr. L’isola volante, in G. Pontiggia, Opere, a cura di D. Marcheschi, Milano, Mondadori, 2004, pp. 1311-1312). Se, come dichiara ancora nell’intervista del 2001, «la narrativa è azione», allora il motore di entrambe non può che essere lo stile, intenso come voce individuale che si costruisce nel confronto e nel dialogo: seguendo il Leopardi del Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, più importante che avere una opinione, è saperla esprimere secondo le norme della civile conversazione (cfr. Delirio e declino della opinione, ivi, p. 1360). Nel tempo dell’opinionismo sfrenato, Pontiggia riattribuisce valore alla scelta del mot juste, a un tono conversevole che può realizzarsi solo a partire dal rispetto della parola altrui.
Da qui deriva l’interesse per l’etimologia che, per Pontiggia come per Leopardi, ha nel Lexicon di Forcellini un termine di paragone ineliminabile (Silenzio e parola all’origine del mito, ivi, p. 1369): tornare all’origine, non per gusto retrospettivo, ma per riconoscere nei «tronchi, rami e foglie» della contemporaneità quella «linfa che dà loro nutrimento» e che correndo «fin dal tempo in cui un presentimento si è articolato in suoni […], per la prima volta, è diventata una parola» (Radici, tronchi, rami, foglie, ivi, p. 1509). Per percepire, dietro i suoni, gli ultrasuoni della nostra storia.
Leopardi stesso, insieme a Keats e Hölderlin, è il poeta delle origini, di una indagine etimologica intesa come dialogo, di una «grecità ideale, rivissuta nelle forme dell’idillio cosmico, dell’estasi visionaria, della congiunzione di verità e bellezza» (cfr. Viaggio della poesia moderna nel mondo antico, in Il giardino delle Esperidi, ivi, p. 732). Per questo va riscoperto proprio come l’etimo di una parola abusata e frusta, per rendere manifesta, sotto la polvere delle categorie acquisite e delle idées reçues, la scintilla della vitalità: alle spalle dei “classici” possiamo intravedere le antiche partizioni delle centurie romane; nascosto nella banalità del “mito” si protegge il proto-suono misterioso della parola che emerge dal silenzio.
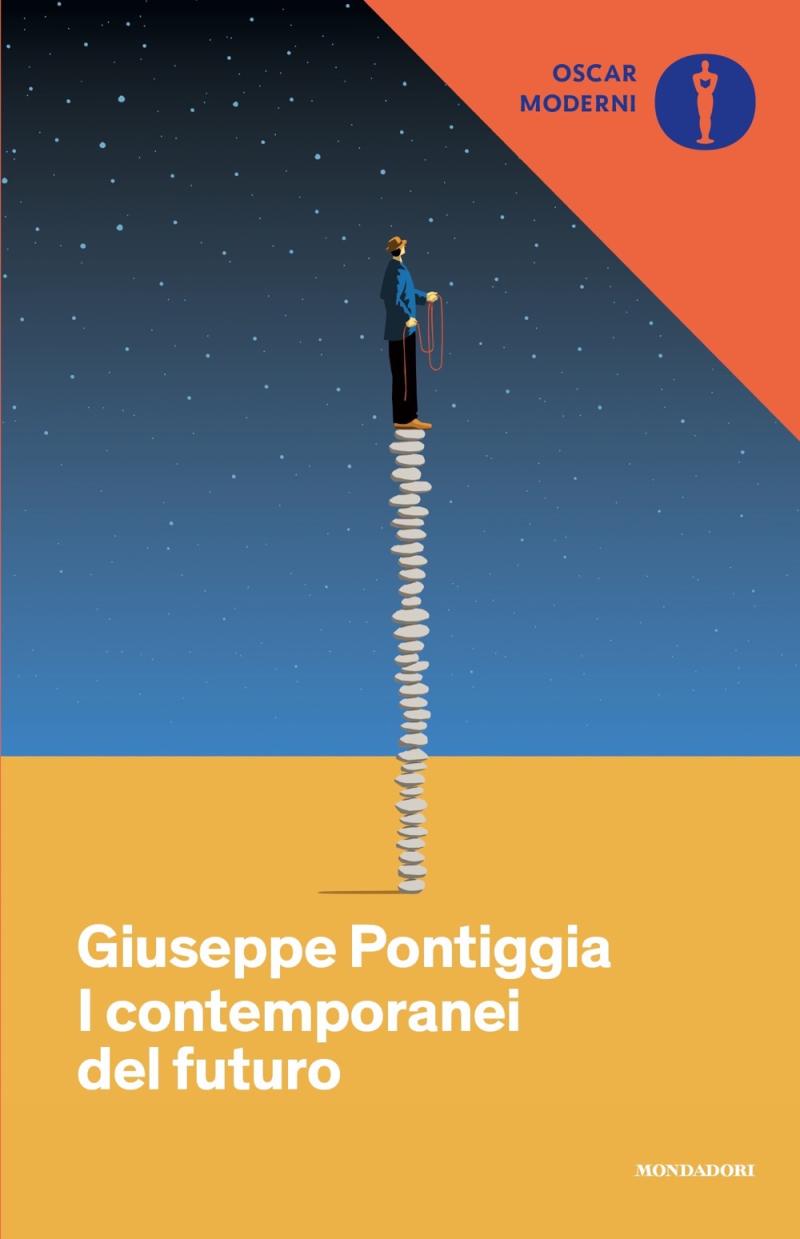
Allo stesso modo, dietro il fantoccio sbiadito del Leopardi da antologia scolastica che recita la «sacra distinzione tra pessimismo storico e cosmico» come una «giaculatoria ipnotica imposta a generazioni di studenti», palpita e commuove il Leopardi inarreso che vede nella poesia non solo una forma di consolazione ma un accrescimento di entusiasmo: Pontiggia opportunamente richiama un brano del 1° febbraio 1829 quando Leopardi attribuisce alla «lettura di un pezzo di vera, contemporanea poesia» la capacità di «aggiungere un filo alla tela brevissima della nostra vita». La poesia dunque «ci rinfresca, per così dire; e ci accresce la vitalità». Seguendo una intuizione di Francesco De Sanctis, qui ripreso attraverso l’imprevista mediazione di Alfredo Giuliani (che citava quel passo zibaldoniano nella prefazione ai Novissimi del 1961), Pontiggia non si limita a riportare il focus sull’opera d’arte capace di riaccendere l’entusiasmo anche quando «rappresenti al vivo la nullità delle cose», ma si fa maestro di un ingresso per così dire “trasversale” al testo letterario: non la parafrasi, bensì l’immersione nella «controcorrente del ritmo, delle assonanze, della musica» (Prima persona, ivi, p. 1714); non il profilo stantio da storia letteraria, ma la mediazione offerta da voci poetiche altre, anche apparentemente lontanissime come nel caso del binomio Leopardi-Giuliani. Il neoavanguardista Giuliani, ammettendo che la poesia «rispetto a qualsivoglia oggetto o esperienza o gioco linguistico» che l’abbia suscitata è «una cosa in più», dimostra che l’energia dei classici sta in quella loro disposizione al rinvio e alla rilettura: è nel giro più ampio e nella «intuizione del rovescio» che il classico prende vita. Analogamente, in epigrafe alle Vite di uomini non illustri Pontiggia colloca un frammento tratto da George Santayana, che potrebbe benissimo condensare in una formula gran parte delle Operette morali: «Tutto, in natura, ha una essenza lirica, un destino tragico, una esistenza comica».
Rileggere Leopardi, soprattutto se lo si fa di fronte a un gruppo di giovani studenti, significa infine essere consapevoli dei rischi derivati da decenni di riduzioni banalizzanti (quelle del poeta dell’infelicità e del dolore) e quelli contrapposti di una riformulazione ironica, buona per ogni contesto (l’unico vero “infinito” di cui avrebbe senso oggi parlare sarebbe allora quello della stupidità umana, come leggiamo in un brano di Il giardino delle Esperidi, ivi, p. 722). Tra questi due orizzonti, Giuseppe Pontiggia, con la sua affabilità e il suo rigore, sceglie la via suggerita dal Parini leopardiano, scettico rispetto alle possibilità che in futuro «le facoltà del cuore, della immaginativa, dell’intelletto siano maggiori che oggi», eppure combattivo e cordiale. La sua attitudine è quella di un «lettore-cercatore di salvezza» (Cfr. G. Ficara, Classici in cammino, p. 148): egli, con il suo stile fatto di ordine e semplicità (la sua è una «classicità senza classicismi», secondo Daniela Marcheschi, o un altissimo esempio dello «stile semplice» codificato da Enrico Testa), è il contrario di un «cieco nel linguaggio» e anzi sa che «il gioco retorico serve non solo a rendere più efficaci le idee, ma a trovarle, come una rete che viene gettata» (Le parole necessarie. Tecniche della scrittura e utopia della lettura, Bologna, Marietti1820, 2018, p. 61.). Così rileggere (fraintendere, anche: come nel caso dell’Epitteto leopardiano) non significa immobilizzare il testo in un iperuranio di eternità ma riconoscerne il momento continuo. Non significa santificarlo in una immagine intangibile, ma individuare le possibili sfumature (proprio oggi che «le tradizioni, come gli antenati, si moltiplicano» e gli ordini si disgregano – in I contemporanei del futuro, in Opere cit., p. 1527): varcare i confini, restituendone una immagine dinamica, aprendoli a nuove prospettive (l’antropologia, la storia della cultura, la psicanalisi…) che ne svelano «prodigiose potenzialità di significazione» (ivi, 1532). Al «classicismo edificante con cui i morti hanno sempre seppellito i loro morti», Pontiggia contrappone anzitutto una più autentica «esperienza dei classici» (ivi, p. 58) che – priva di qualsiasi paternalismo (cfr. M. Bellardi, Uno smisurato equilibrio. La narrativa sperimentale di Giuseppe Pontiggia, Firenze, Franco Cesati, 2014, p. 79) – ponga al centro non tanto la traditio (da loro a noi), quanto il ritrovamento, dal momento che i classici «Non sono nostri contemporanei, siamo noi che lo diventiamo di loro» (I contemporanei del futuro, in Opere cit., pp. 1527 e 1531-1532). È ciò che avviene nel caso della magistrale pagina sul dolore delle piante raccolta in Prima persona, dove ritroviamo un «mondo vegetale percorso da brividi, squarciato dalle ferite, medicato dai lenimenti, impaurito dai temporali» che ribadisce la stupefacente contemporaneità del giardino leopardiano (in Opere cit., pp. 1745-1746). La lezione più attuale del suo Leopardi è proprio questa: rifiutando ogni dolorismo o intimismo, entrambi ci indicano la via di una verità morale che si fa verità estetica.
Leggi anche
Luigi Grazioli, Giuseppe Pontiggia: dieci anni senza
Chiara De Nardi, Giuseppe Pontiggia. Dentro la sera
Giuseppe Mendicino, Giuseppe Pontiggia, uno sconfinato amore per la ragione e la letteratura







