La vita fredda della terra
Si sciolgono. Stiamo perdendo ghiacciai alpini, banchise polari, scudi glaciali. Ma che cosa stiamo perdendo con il ghiaccio? Certamente paesaggi, ecosistemi, specie, ma anche un immaginario complesso, un’ecologia della mente in cui i ghiacci della Terra hanno svolto per gli umani, dal Paleolitico a oggi, una funzione cognitiva e poetica fondamentale. Fondamentale, ma non evidente. Quando si parla, tra estetica e storia delle idee, di invenzione del Monte Bianco, dei Poli, del Nord, non si parla di declinazioni gelate di un qualche lontano ignoto, di un esotismo che ha sostituito palme e cammelli con trichechi e iglù. È qualcosa di più profondo, qualcosa di primario, che ha a che fare con la possibilità stessa di pensare la Terra. Ce lo ricorda Gaston Bachelard, quando dice che «l’immaginario del ghiaccio è poverissimo». Quando parliamo di fuoco, fiamma, incendio il nostro linguaggio è generativo: “infiammarsi”, “fiamma della passione”, “incendio dell’anima”, “fuoco interiore”, “fuoco sacro”. Le nostre rêveries sul fuoco parlano di emozioni, stati d’animo, condizioni mentali. Il fuoco ha accompagnato per decine di migliaia di anni le introspezioni umane, dal focolare paleolitico alla fiamma della candela sul tavolo dello scrittore. Il ghiaccio no. C’è qualcosa nel ghiaccio che resiste all’immaginario, che frena la rêverie.
Pensiamo alle parole più comuni: ghiaccio, ghiacciaio, glaciazione, glaciale, ghiacciato, agghiacciante; neve, nevoso, innevato; gelo, gelato, gelido; brina, brinato. Quante di queste parole vengono usate comunemente in un registro metaforico? Solitamente solo “ghiaccio” e i suoi derivati “glaciale” e “agghiacciante”, e ovviamente “gelido”. Quello che stupisce è che l’uso traslato di queste parole ha un’incredibile monotonia di significato: mentre il fuoco serve a indicare passioni diverse, talora opposte, dall’ira all’amore, il ghiaccio ha una connotazione quasi solo negativa, al limite neutra: il suo valore metaforico non si stacca dalla semantica dell’assenza di sentimenti e passioni, della freddezza interiore, del vuoto. Ma forse è proprio questa sua resistenza alla metaforizzazione, questa monotonia, che ci aiuta a caratterizzarlo meglio. Si tratta insomma di un terreno che resiste, che frena la metafora, che letteralmente raffredda la rêverie. Il ghiaccio, per così dire, fa una doccia fredda al fuoco dell’immaginario, e soffoca nella sua imperturbabilità l’incendio dell’eccesso immaginativo. Ma è davvero così? Se restiamo nei limiti angusti della lingua parlata rischiamo il banale. Dobbiamo invece chiederci: qual è il poetico del ghiaccio? Parlo di poetico perché il poeta, l’esploratore di miti, l’artista, sono in qualche misura i professionisti dell’immaginario, e la chiave per capire molte cose sul ghiaccio è appunto l’immaginazione, che lo avvolge come un liquido amniotico.
In questo senso Le vie del freddo. Storia del ghiaccio e della civiltà (Einaudi 2025) di Max Leonard è qualcosa che si avvicina molto a un’ars poetica “glaciale”, un libro immaginifico che comincia appunto mettendo al centro di tutta la questione il linguaggio e in particolare il problema dell’indicibilità dei ghiacciai. È il 1741, William Windham sale a Chamonix e va a vedere le cosiddette glacières. Ne scrive subito dopo e confessa di non sapere come fare, ci prova con una similitudine, i mari ghiacciati della Groenlandia, ma fallisce. Un limite che non è verbale, stilistico, ma cognitivo, perché Windham non sa che cosa sta guardando e soprattutto non sa come guardarlo, un problema analogo a quello di alcuni pittori tra Settecento e Ottocento che, provetti nel dipingere montagne e geologie, dovendo dipingere i ghiacciai sembravano regredire a un livello infantile. Non sapevano, non vedevano, secondo l’ipotesi Sapir-Whorf non avevano le parole giuste per percepire, dunque rappresentare. Il punto, piuttosto, è che non sapevano come funzionavano, i ghiacciai, non sapevano dare un senso, una direzione, una parabola cronologica alle forme “irreali” e perturbanti che stavano osservando. Con l’arrivo di Louis Agassiz, il padre della glaciologia, i pittori leggono i suoi saggi, cominciano a capire, e finalmente riescono a dipingere ghiacciai in maniera corretta. La storia sembra finire qui, ma Max Leonard ci dice qualcosa di molto spiazzante: noi siamo come loro, ce l’abbiamo sotto gli occhi, il ghiaccio, ma ancora non riusciamo a capirlo.

Il fatto è che la storia dell’umanità è legata al ghiaccio in modi così articolati e sottili o così macroscopici e basici che si potrebbe riscrivere la parabola evolutiva e culturale della nostra specie mettendo al centro un fenomeno elementare e complesso, quello che il Codice Exeter del X secolo, sempre in bilico tra comprensione e mistero, racconta così: «Sul mare accadde una cosa stranissima: l’acqua divenne osso» (p. X). Chi ha pratica diretta di luoghi glaciali sa bene che il gelo arde, ma senza fiamma, asciuga, erode, ma non incenerisce, un po’ come i grandi ghiacciai che asportano parti morbide del terreno e lasciano alle montagne la loro ossatura più solida. C’è differenza se diciamo “ghiaccio” oppure “ghiacci”: il primo è acqua rappresa, i secondi sono tutte le acque ghiacciate in ogni forma, dalle lastre scivolose delle pozzanghere alle placche di fiumi rappresi in scioglimento, dai grandi scudi glaciali del Paleolitico ai Poli delle spedizioni artiche. Se diciamo “ghiacci” diciamo immediatamente spazi, i grandi spazi bianchi, non scritti, dove l’eccesso è eroso, portato via, dove resta solo l’essenza di ciò che si cerca. Perché il ghiaccio può essere pensato come derivato dell’acqua, come sottoprodotto di un archetipo, ma può essere pensato anche come un minerale, riportandolo così alla sua materialità terrestre.
L’acqua che si ghiaccia è tempo che si ferma, invece i grandi ghiacci della terra sono il tempo trasformato in spazio. Forse dovremmo cominciare a pensare tutto il ghiaccio così, anche quello nel nostro gin tonic, perché il rischio, ci ammonisce Max Leonard, è quello di darlo per scontato o, peggio, quello di vedere la sua dissoluzione ai Poli come qualcosa di lontano e irreale. Il suo libro nasce da qui, dalla speranza che «portando il ghiaccio in una sfera più intima, cercando di comprendere la ricchezza e la complessità del nostro rapporto con il ghiaccio e ripristinando il senso di meraviglia, la catastrofe che sta avvenendo in luoghi remoti diventi più tangibile, che tutti possano percepire in modo più forte che cosa stiamo perdendo» (p. XIII). Ma che cosa stiamo perdendo? Preziosissime scorte d’acqua? Paesaggi meravigliosi? Narrazioni fantastiche? Per come la vedo io, spostandomi un po’ dalle tesi del libro, credo che quello che stiamo effettivamente perdendo sia un fascio di possibilità della mente, proprio come la perdita di biodiversità: quando spariscono animali, piante, habitat pensiamo il mondo in un modo molto più povero, ci ritroviamo con una grammatica e un vocabolario immaginifico che, per mancanza, ci fa scivolare sempre di più in un analfabetismo poetico. Al collasso dei ghiacci, insomma, corrisponde un collasso cognitivo, perché senza ghiacci saremo tutti un po’ più stupidi e soli nel guardare la Terra.
Max Leonard dice altro, però, e lo dice in maniera convincente. A lui non interessano i ghiacci lontani, quelli ai Poli o sull’Himalaya, a lui interessa raccontare il rapporto che con il ghiaccio, al singolare, hanno avuto le culture delle terre temperate, dalla Grande Era glaciale, alla Piccola Era glaciale, fino all’età contemporanea. Tutto comincia allora intorno alla Grotta Chauvet, di cui Leonard visita la replica per rispondere a due domande: «che cosa accadde quando Homo sapiens incontrò per la prima volta il ghiaccio?», «potrei forse scoprire un’eco di quell’incanto iniziale?» (p. 4). Oltre a immaginare l’Out of Africa come un meraviglioso viaggio verso il ghiaccio, l’autore scomoda Freud per parlare di questo perturbante first contact: «in un articolo del 1914-15 [Freud] ipotizzò che gli antichi esseri umani avessero vissuto l’avvento dell’Era glaciale come una specie di cacciata dall’Eden, un evento tanto traumatico dal punto di vista psicologico da essere all’origine di tutte le nevrosi moderne» (pp. 11-12), una specie di grumo d’ansia primordiale, e un vero e proprio «mito fondativo» (p. 12) che ha solleticato l’immaginario non solo della psicanalisi ai suoi albori ma anche dell’archeologia e della neuroarcheologia. In questo senso si potrebbe parlare di una specie di «Era glaciale della mente» (p. 6), e della psiche, una grande azione modellante che ha lasciato impronte tanto nei paesaggi quaternari quanto nel cervello dei primi Sapiens.
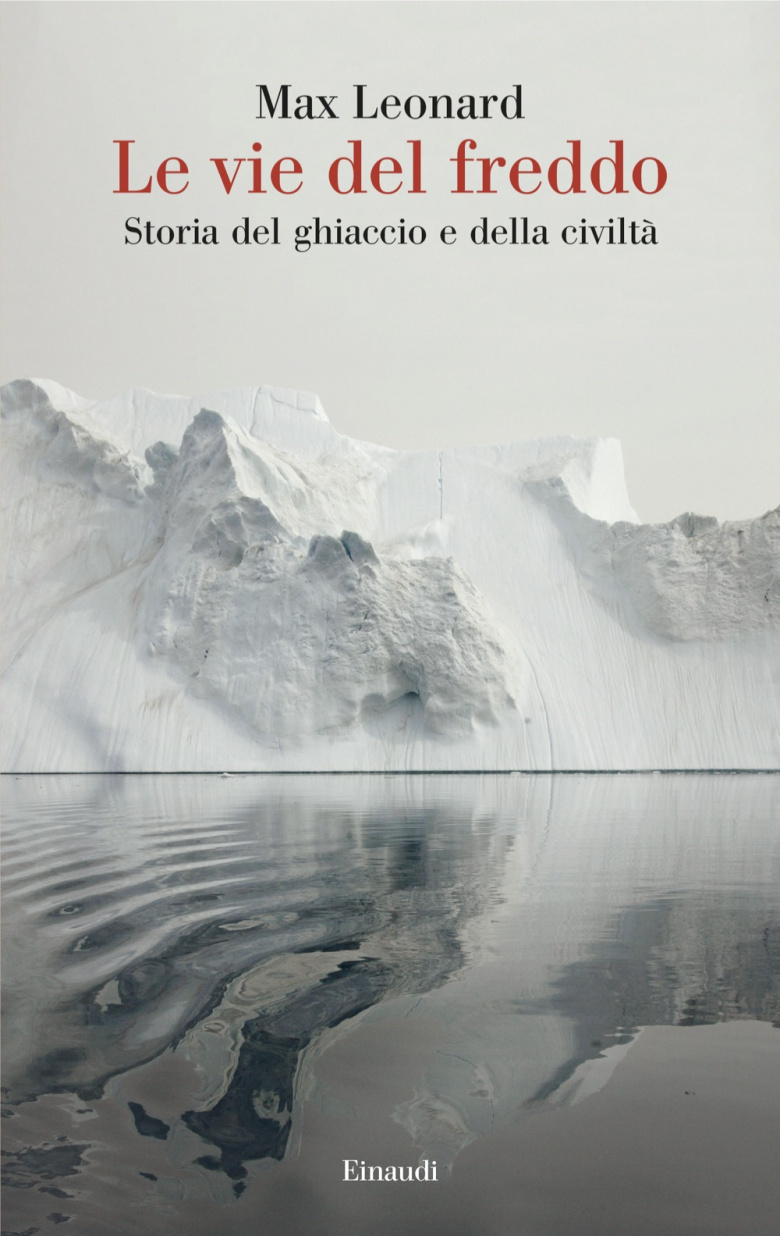
Forse, a questo punto, dovremmo proprio rileggere quello che dice Bachelard. Per lui la brina e la neve sono legate a quella che chiamava la “miniatura intima”, il mondo visto nei dettagli, il microcosmo in cui assopirsi e trovare dimora, forse pace. Ghiacciai e banchise rimandano invece all’immensità, al fuori, all’aperto inabitabile, ma sono anch’essi un rifugio largo che oscilla tra utopia e ucronia. Non più una piccola fuga dal mondo, insomma, ma un’esplorazione condotta da balenieri, alpinisti e cacciatori artici. In La terre et les rêveries de la volonté (1945) Bachelard osserva che «il metallo è la sostanza stessa della freddezza e questa freddezza si presta a tutte le metafore. Se Hermann Keyserling scrive: “La freddezza è il calore specifico del metallo” è per ritrovare la vita fredda della terra, la vita di ogni esistenza a sangue freddo, quella che egli stima essere la vita di base di tutto il continente. L’ostilità del metallo è anche il suo primo valore immaginario. Duro, freddo, pesante, angoloso, ha tutto ciò che serve per ferire, per ferire psicologicamente». Se nella brina, nella neve il passaggio dall’acqua al cristallo si gioca nell’ordine della miniatura e, per così dire, non turba i sentimenti ma li pacifica, il passaggio di scala dal fiocco di neve al ghiacciaio chiede all’emozione un salto, una giustificazione. Solo una grande collera può aver rappreso l’acqua in ghiaccio, una specie di “complesso di Medusa” che mette in guardia la specie da ogni Artico reale e metaforico.
Un capitolo dopo l’altro, un aneddoto dopo l’altro, Leonard esplora allora le molte declinazioni naturali e culturali del ghiaccio: minaccia, spinta evolutiva, calendario, ricettacolo di memoria, gioco, svago, alimentazione, medicina, capitalismo, esplorazione, guerra, conservazione, turismo, alpinismo, Antropocene. E nell’ultimo capitolo, dedicato appunto all’Antropocene e all’arroganza manipolatoria di Homo sapiens sulla Terra, una constatazione agghiacciante prende piede: mentre i ghiacci naturali del pianeta stanno rapidamente diminuendo, in maniera esponenziale sta aumentando la produzione artificiale della criosfera. Aria condizionata, refrigerazione domestica, catena alimentare del freddo, macchine per la neve, data center stanno generando un costosissimo paradosso perché, mentre producono freddo artificiale monodiretto, rilasciano calore da qualche altra parte, distruggendo il freddo naturale. Questa “criopolitica” di rapina e abuso si aggiunge così al novero delle colpe antropoceniche che caratterizzano il collasso sistemico che abbiamo fatto detonare. Ma se vi ho indotto a pensare che Le vie del freddo sia un libro di divulgazione scientifica scritto benissimo, fatto di storie poco note dalle forti implicazioni politiche e culturali, dovete ricredervi. Le vie del freddo è molto di più, perché nel fare quello che fa si riscrive dall’interno, continuando a rispondere alla domanda iniziale di meraviglia e di agnizione mitica. Lo dice l’ultimissima frase del libro parlando di William Scoreby, baleniere, meteorologo, naturalista, che faceva divertire i suoi uomini ricavando lenti ustorie da scaglie polite di iceberg: «Il ghiaccio, che circondava la loro nave in quantità incredibili, che pensavano di conoscere, poteva ancora far gridare di gioia i marinai e farli accorrere. Qualcosa che raffredda una bevanda e accende una pipa. Lo straordinario dell’ordinario. Il fuoco dal ghiaccio» (p. 298).
Cerchiamo allora una conclusione, sempre con Bachelard, e chiediamoci che cosa spinge la mente del poeta, dell’esploratore di miti, dell’artista a cercare il ghiaccio. Siamo di fronte a una rêverie primaria, fondante, o è solo il riflesso, lo speculare, l’antifrasi di una ben più ricca e originaria rêverie del fuoco? Anzitutto possiamo osservare che se la fiamma dilata, il ghiaccio coagula, se la fiamma è volo verticale il ghiaccio è un ritorno alla Terra, e cioè, alla verticalità dell’eccesso, oppone, aprendola, un’orizzontalità dei grandi spazi. Bachelard ha detto che «la fiamma è un mondo per l’uomo solo», qui potremmo definire il ghiaccio una solitudine per l’uomo nel mondo. Se per la lingua ordinaria “ghiaccio”, “glaciale”, “gelido” sono condizioni negative dell’anima, per alcuni cercatori di miti il ghiaccio può farsi spazio, può diventare un altrove non umano in cui raggelare un eccesso di passione, una passione individuale, forse, o la passione condivisa da tutta un’epoca. Solitudine come solitudines, deserto, wilderness, suolo assoluto per raffreddare nello spazio le fiamme del Tempo e dei tempi, per mettere a tacere sotto una coltre di neve la fretta del quotidiano o la distruttività di una Storia che divora gli spiriti come un incendio. Il ghiaccio è morte, certo, inutile girarci attorno, ma morire al secolo, seppellirsi nell’anonimato di terre come l’Islanda, la Groenlandia o la Patagonia, è un sogno che ha sfiorato molti.
Qual è allora l’intimità inconscia nascosta nei sogni del ghiaccio? Mentre la neve si stende morbida sulle ustioni interiori, i grandi ghiacciai in dissoluzione ci ricordano il complesso di Medusa, la volontà di pietrificare, di proiettare ostilità, una rabbia rappresa, bloccata nel suo eccesso, un’istantanea d’ira. La collera del fiume tumultuoso si fossilizza in un’esplosione sorda, glaciale, una tensione permanente, ipnotica. Ecco, bastano due esempi per dire che il ghiaccio ha una doppia anima. Finché è miniatura, candore, l’animo riesce a raccogliersi in esso, fa nido e trova sollievo dall’aperto, dal mondo degli incendi. Quando invece il ghiaccio è immenso e opaco, la sua ostilità preme l’animo nel fuori, e lo costringe a farsi nomade, a seguire le grandi piste della selvaggina artica. È probabilmente un miscuglio di entrambe le cose che ha spinto certi uomini ai Poli: sonno, silenzio, anestesia, ma anche solitudine, esposizione, collera. E ora che si stanno sciogliendo, che cosa mancherà al nostro immaginario? Quali terre mentali avremo perso per sempre? Vorrei chiudere questa piccola escursione glaciale con un testo che sembra stendere un velo di sollievo sugli altoforni della modernità, sulla febbre dell’uomo, un testo che sull’Era del fuoco sembra tessere bende per le bruciature dei viventi e, come un nuovo Eden, forse ci assolve, ci grazia nella nostra condizione di esuli antropocenici. Si tratta di Neiges di Saint-John Perse, composto nel 1944 a New York, dedicato alla madre del poeta, con chiari ipotesti cristiani. La Neve, la Madre, la Vergine, e una città sporca, un mondo contaminato che attende purificazione:
E poi vennero le nevi, le prime nevi dell’assenza, sui grandi teli tessuti del sogno e del reale; e rimessa ogni pena agli uomini memori, ci fu freschezza di lini alle nostre tempie. E fu al mattino, sotto il sole grigio dell’alba, un po’ prima dell’ora sesta, come in un porto di fortuna, un luogo di grazia e pietà in cui licenziare lo sciame delle grandi odi del silenzio.







