Šostakovič: i tormenti di un'anima russa
Nella tarda primavera del 1973, Dmitrij Šostakovič si recò per la terza e ultima volta negli Stati Uniti, dove fu insignito di una laurea honoris causa. Fra gli scopi del viaggio c’era anche un incontro con i medici del National Institute of Health, ma il consulto si rivelò inutile: non c’era più niente da fare contro il cancro ai polmoni che si era aggiunto alle numerose patologie che lo avevano afflitto nell’ultimo quindicennio. La sua salute declinava rapidamente e inesorabilmente, gli restavano da vivere poco più di due anni. Sarebbe morto in un ospedale di Mosca il 9 agosto 1975, all’età di 68 anni.
Come racconta il musicologo americano Alex Ross (Il resto è rumore – Ascoltando il XX secolo, Bompiani 2009 – 2023), prima di ripartire andò ad ascoltare la New York Philharmonic diretta da Pierre Boulez. Dopo il concerto, i due musicisti si incontrarono e il francese – che mai aveva speso una parola di apprezzamento nei suoi confronti e che il russo chiamava ironicamente “arci-apostolo del Modernismo” – fece un gesto che sbalordì e imbarazzò il suo collega: nel salutarlo, si chinò a baciargli la mano. «Sono rimasto talmente sorpreso – scrisse poi a un amico – che non ho neanche fatto in tempo a ritrarla». L’episodio è sintomatico: uno dei più autorevoli ma anche dei più radicali esponenti della Nuova Musica aveva reso omaggio al compositore che all’epoca era il più influente membro della “nomenklatura” sovietica in campo artistico. In questo modo “consacrandolo” come una figura fondamentale nella musica del Novecento.

A cinquant’anni dalla morte, caduto il comunismo e sorto un nuovo imperialismo russo, l’evidenza rimane: Šostakovič è stato uno straordinario protagonista della musica nel XX secolo, prima nella Russia rivoluzionaria e poi nell’Unione Sovietica. Un ruolo pagato in prima persona e a caro prezzo, attraversando difficoltà di ogni genere, subendo umiliazioni, vessazioni professionali e pratiche, intimidazioni. In qualche caso conoscendo il terrore, nel dubbio di riuscire a sopravvivere. Un ruolo, anche, vissuto per molti aspetti in maniera enigmatica, fra incoerenze personali, dubbi e tormenti artistici ed esistenziali. Un atteggiamento di non facile decifrazione, spesso contraddittorio, talvolta sorprendentemente conciliante rispetto all’autoritarismo che il potere totalitario comunista esercitava sugli intellettuali. Quasi un rebus biografico, intorno al quale gli storici faticano ancora oggi a trovare una soluzione che resti lontana dalle opposte annessioni ideologiche. È infatti accaduto che il musicista russo sia stato considerato – a seconda dell’epoca e delle situazioni – un dissidente perseguitato, a rischio di restare vittima delle purghe staliniane o un opportunista troppo fedele alle direttive del partito; un anticomunista viscerale per quanto “nascosto” (come lo dipingono le controverse Memorie pubblicate nel 1979 negli Usa a cura dallo scrittore Solomon Volkov, di autenticità contestata dagli studiosi più accreditati), oppure un convinto ambasciatore in campo artistico del regime di Mosca.
Proprio il compito di propagandista Šostakovič aveva dovuto svolgere la prima volta che aveva raggiunto gli Stati Uniti, nel marzo del 1949, quando Stalin gli aveva imposto di partecipare alla “Conferenza culturale e scientifica per la pace mondiale” tenutasi all’hotel Waldorf-Astoria di New York. In quell’occasione il musicista aveva fatto la figura del grigio burocrate, pienamente allineato, ancorché con cupo nervosismo, all’ortodossia dettata del partito, costretto ad attribuire a sé stesso discorsi scritti da altri e a dichiarare la propria totale approvazione per la linea del partito. Il momento era particolare. Da poco Šostakovič aveva subito il secondo durissimo attacco ideologico della sua vita: nel febbraio del 1948 un decreto del responsabile degli affari culturali, Andrej Ždanov, lo aveva messo nel mirino in quanto esponente più in vista di una musica “in cui si riflette la decadenza della cultura borghese, la negazione totale e il ristagno dell’arte musicale”. E il musicista si era dovuto umiliare con una completa e pubblica autocritica di fronte ai suoi colleghi compositori.
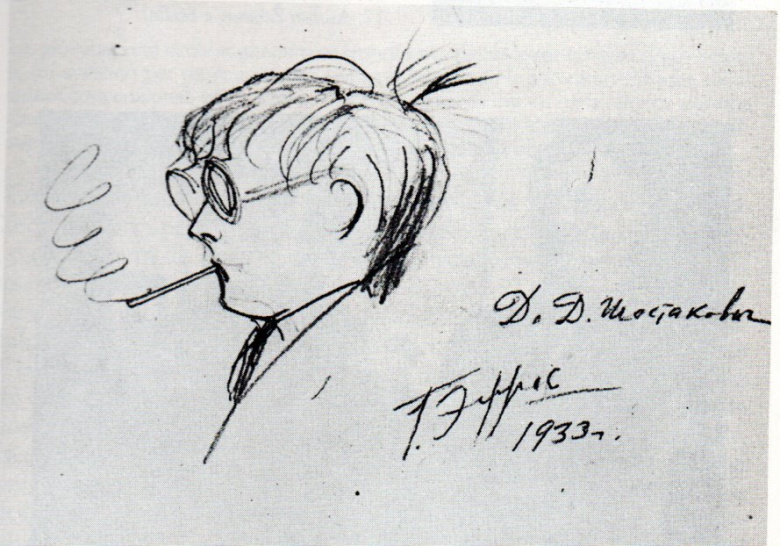
Nel gennaio del 1936 lo scontro con il potere sovietico era stato ancora più aspro e temibile. Un editoriale anonimo sulla Pravda, uscito dopo una rappresentazione moscovita alla quale aveva assistito Stalin, che se n’era andato apparentemente indispettito prima della fine, aveva messo sotto accusa la seconda opera del compositore non ancora trentenne, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Fino a quel momento il lavoro – tratto dall’omonimo racconto ottocentesco di Nikolaj Leskov e portato al debutto due anni prima – aveva riscosso un grande apprezzamento ed era già stato allestito più volte all’estero: un exploit internazionale, forse anche per questo finito nel mirino dell’ideologia sovietica. “Il fracasso al posto della melodia pretende di esprimere le passioni”, si leggeva nel minaccioso articolo, intitolato “Caos invece di musica”. E si lanciava al compositore l’accusa di “formalismo piccolo borghese”, l’antitesi del “realismo socialista”, la dottrina artistica perseguita dal Partito comunista. Quella volta Šostakovič non aveva risposto e si era preparato al peggio. Era l’epoca in cui il terrore staliniano stava arrivando al culmine: gli oppositori e i dissidenti venivano assassinati, quando non morivano di stenti nei gulag siberiani dove venivano segregati. E le famigerate “purghe” non riguardavano solo gli esponenti politici. Negli anni seguenti il musicista avrebbe visto “sparire” anche personaggi della sua cerchia, come il grande regista Vsevolod Mejerchol’d.
Nato a Pietroburgo il 25 settembre 1906, Šostakovič apparteneva a una famiglia borghese di orientamento liberale. Uno zio lo aveva portato con sé alla stazione di Finlandia della capitale russa, il giorno di aprile del 1917 in cui Vladimir Lenin appena tornato in patria aveva incitato con uno storico discorso alla rivoluzione del proletariato. Un episodio rimasto inciso nella sua memoria come i durissimi anni della guerra civile dopo la caduta dei Romanov, durante i quali a Pietrogrado (com’era stata ribattezzata all’inizio della Grande Guerra) scorreva il sangue e si faceva la fame.

Il grande talento musicale del ragazzo era stato intuito dalla madre, che suonava il pianoforte, e riconosciuto al Conservatorio già guidato da Rimskij-Korsakov e ora diretto dal tradizionalista Aleksandr Glazunov, che nel 1928 avrebbe scelto l’espatrio a Parigi. Šostakovič era un eccellente pianista e l’attività concertistica fu parte della sua vita artistica per decenni, fino a quando – sul finire degli Anni Cinquanta – non fu colpito da una paralisi progressiva delle dita della mano destra, causata da un’infezione cronica al midollo spinale. Una delle tante malattie dalle quali fu colpito. Non fu un fanciullo prodigio, ma fin da giovane dimostrò di possedere una mente musicale lucida e di straordinaria ricchezza inventiva. La fama giunse con la sua prima Sinfonia, scritta pubblicata ed eseguita quando non aveva ancora vent’anni. Si tratta di una partitura di fascino notevole, nella quale l’influsso modernista alla Stravinskij dei primi due movimenti è temperato dalla tensione espressiva di origine romantica e tipicamente russa del terzo e quarto movimento, che fanno pensare a Cajkovskij. Già evidente la qualità nel trattamento dell’orchestra, che raggiungerà negli anni della maturità uno straordinario virtuosismo coloristico, peraltro raramente fine a sé stesso.
Il primo decennio dell’attività compositiva di Šostakovič, fino a circa la metà degli Anni Trenta, si svolse nella vivacità culturale e artistica di Leningrado e Mosca agli albori dell’Unione Sovietica. Una vivacità ben presto destinata a spegnersi sotto il giogo staliniano. A contatto con personaggi come lo scrittore Vladimir Majakovskij e il citato regista Mejerchol’d, il compositore si dedicò a generi diversi, dalla musica da film a quella per il balletto (L’età dell’oro, 1930, ha per protagonista una squadra di calcio, sport del quale il musicista fu appassionatissimo per tutta la vita) e a quella di scena (notevole la partitura per La cimice del drammaturgo futurista, 1929). Non mancarono un paio di nuove prove sinfoniche, che seguono un binario parallelo a quello della Prima, nel senso di un’accentuazione programmatica e ideologica che avrebbe sempre accompagnato, almeno sul piano dei dichiarati argomenti extra-musicali di molti lavori, la produzione dell’autore russo.

Il capolavoro di questo periodo è l’opera Il naso, tratta dall’omonimo racconto grottesco-fantastico di Gogol’, portata al debutto a Leningrado il 18 gennaio 1930. La partitura, definita “Sinfonia teatrale”, è caratterizzata da un eclettismo incessante e spiazzante. Il linguaggio è stratificato, complesso: si passa dal contrappunto classico al melodismo della musica di consumo, dal rigore tematico alla libertà ritmica e coloristica del jazz e al patrimonio popolare russo, profano e religioso. Il non ampio gruppo strumentale cui Šostakovič affida la sua creazione è anch’esso antitradizionale: ridotti al minimo gli archi, ben presenti ma con scrittura lontana da quella della tradizione i fiati (spesso in tessiture anomale), sono dominanti le percussioni che comprendono tamburo, castagnette, tom-tom, rattle, piatti, grancassa, gong, campane tubolari, glockenspiel, xilofono e danno all’intera opera la sua tinta inconfondibile e caratteristica.
L’ultima manifestazione di una visione modernista nel linguaggio musicale (ma molto russa nell’argomento e nei modi di svilupparlo) è costituita da Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, opera che racconta una torbida vicenda ottocentesca di sesso, delitti e contrasti di classe, composta fra il 1930 e il 1932 e rappresentata per la prima volta a Leningrado il 22 gennaio 1934. Le drammatiche contestazioni politico-ideologiche e musicali cui si accennava avrebbero fatto sparire dalle scene questo straordinario dramma musicale per quasi un trentennio, fino al recupero avvenuto nel 1963, con qualche modifica soprattutto nel testo e con il titolo Katerina Izmajlova, che è il nome della protagonista principale. Del resto, una simile eclissi era toccata anche a Il naso, virulentemente attaccato nei primi Anni Trenta dall’associazione dei “compositori proletari” e per decenni rimasto senza rappresentazioni.
Dopo il lungo periodo di silenzio seguito all’attacco della Pravda, il compositore scelse la Sinfonia come ambito del suo ritorno sulla scena musicale, che avvenne nel dicembre 1937 con la Quinta, salutata alla sua prima apparizione da un successo formidabile. Non era una palinodia, anche se la pubblicistica sovietica favorì questa visione, riassunta nella formula giornalistica, tipica ma non certo gradita dall’autore, “Risposta pratica di un compositore a una giusta critica”. E non era nemmeno una polemica ma criptica “descrizione musicale” di Stalin, come talora si sostiene anche oggi. Era semmai una messa a punto ormai matura del suo stile sinfonico, che resta lontano dalla dialettica tematica della forma sonata classica e romantica e procede secondo giustapposizioni di espressività fortemente soggettiva, quasi un flusso sonoro di coscienza intorno ai poli della tensione drammatica o francamente tragica e della estroversione grottesca, quasi caricaturale (così rivisitata secondo la lezione dell’ammirato Mahler la categoria antica del “brillante”). Il tutto dentro a un discorso armonicamente solo in apparenza regolare, in realtà spesso votato alla politonalità o all’arcaica modalità.
Nel poderoso corpus delle quindici Sinfonie di Šostakovič, queste scelte attraversano specialmente le composizioni meno connotate descrittivamente (la Quarta, ritirata per prudenza dalla programmata esecuzione nel 1936 e riemersa solo trent’anni dopo; l’Ottava, la Nona, la Decima), ma riguardano anche quelle che fin dal titolo sembrano annunciare un vero e proprio “programma”. È quello che accade ad esempio con la Settima, intitolata “Leningrado”, una delle sue pagine più celebri. Composta in larga parte nel 1941 durante il lungo assedio dell’esercito tedesco (il compositore era rimasto nella città natale e si era arruolato volontario nei Vigili del fuoco), la partitura divenne un potente simbolo planetario dell’eroismo russo nella “Grande Guerra Patriottica” e in generale della lotta senza quartiere al nazismo. Il suo autore fu poi evacuato con un piccolo aereo e poté concludere il lavoro al sicuro. Subito dopo iniziarono le esecuzioni in terra russa, ben presto seguite da quelle in Occidente, con la prima diretta da Arturo Toscanini a New York il 19 luglio 1942. Nell’occasione, il compositore campeggiava sulla copertina di Time, in divisa da vigile del fuoco: un disegno realizzato a partire da una fotografia, scattata mentre sorvegliava il tetto del Conservatorio di Leningrado. Il successo fu clamoroso. E la diffusione della Sinfonia rapidissima. Ma la Settima era quasi dimenticata sette anni più tardi, quando Šostakovič arrivò a New York: gli antichi alleati degli americani erano diventati nemici nella Guerra Fredda. Oggi, a oltre ottant’anni di distanza, meno evidenti le suggestioni descrittive, questa pagina va ascoltata nella sua essenza di straordinario affresco sonoro dalla formidabile intensità. L’articolazione timbrica realizzata dentro a un’orchestra immensa è sontuosa e risulta esaltata dall’impiego della Variazioni nel primo movimento: oltre il mosaico delle citazioni motiviche, proprie e altrui, un monumento del sinfonismo novecentesco.
Il percorso stilistico seguito da Šostakovič nella scrittura orchestrale trova una realizzazione ancora più affascinante in quella cameristica – coltivata intensamente, e non per caso, specialmente dopo la crisi del 1936. Nella musica da camera dell’autore russo la poesia è ancora più tormentata e drammatica, specialmente nella naturale intimità dei dialoghi possibili all’interno dei Quartetti per archi, che alla fine saranno quindici come le Sinfonie. Dopo la morte di Stalin e le denunce dei suoi crimini da parte del suo successore, Nikita Chruščëv, i contrasti di Šostakovič con il sistema sovietico si erano progressivamente smussati, fra sconcertanti cedimenti da parte del musicista (come l’adesione al Partito nel 1960) e “concessioni” artistiche da parte del sistema, mescolate con i privilegi destinati alle élites di Stato. Incessanti le richieste di musica propagandistica, quasi sempre accolte, sia pure con un distacco spesso venato da una enigmatica ironia. Il clima del cosiddetto “disgelo” permise però al musicista la coraggiosa e forte denuncia dell’antisemitismo sovietico nella straordinaria Sinfonia con voce e coro n. 13, “Babij Jar” (1962), su testi poetici del dissidente Evgenij Evtušenko. E gli consentì anche di aprire lo struggente capitolo che oggi consideriamo il suo “tardo stile”, beethovenianamente incarnato nella predilezione ultima proprio per i Quartetti.

A partire dal 1960, in particolare, il compositore attuò con sempre maggiore incisività una “poetica soggettiva”, nella quale suggestioni stilistiche composite si inseriscono in una totale libertà formale. Ci sono Quartetti in cinque movimenti, come il n. 8 – un’autocommemorazione, la definì lo stesso autore – e il n. 9; in sette movimenti, come il n. 11; in sei, tutti lenti, come il n. 15, commiato dal genere di lancinante densità psicologica. Tutti raggiungono un’interiorità che colpisce profondamente per la sua capacità di restituire e amplificare gli enigmi della personalità dell'autore.
Quanto al linguaggio, al di là di un ventaglio citazionistico sempre più ampio eppure mai banale, e all’uso ossessivo del “motto” sonoro legato alle iniziali del suo nome (D.Sch: Re, Mi bemolle, Do, Si), Šostakovič non esitò a servirsi anche della serie dodecafonica, in altra epoca da lui stesso condannata. L’approccio per molti aspetti appare “tematico”, un po’ alla maniera dello stimato Alban Berg, ma in realtà risponde ad una logica ancora una volta essenzialmente espressiva. Una procedura del genere si trova in due lavori fondamentali del 1968, la Sonata per violino e pianoforte op. 134 (dedicata a David Ojstrach) e il Quartetto n. 12, nel quale la “serie” viene continuamente contrapposta ad un tema di stretta osservanza tonale.
Nella musica da camera degli ultimi anni il pensiero della morte – serpeggiante in quasi tutte le opere di questo periodo, compresa la funerea Sinfonia-Cantata n. 14, dedicata all’amico Benjamin Britten – si fa elaborazione intima di straordinario rilievo morale. Senza disperazione ma anche senza rassegnazione. Nell'impressionante sequenza di movimenti lenti del Quartetto n. 15 o in un altro capolavoro assoluto come la Sonata per viola op. 147 (completata all’ospedale dove Šostakovič sarebbe morto) viene comunicata piuttosto una sorta di sublime, astratta contemplazione, che delinea un’atmosfera quasi onirica, nella quale “soggetti” che potrebbero essere da incubo vengono invece trattati in assenza di vera angoscia, con il marchio quindi della consapevolezza e di una superiore comprensione. Diventano protagonisti integrali i paesaggi interiori della psiche, già abbozzati in capolavori della fase di mezzo come il Quintetto con pianoforte op. 57 o il drammatico Trio op. 67 (composti durante la guerra), o come i Concerti per violoncello e per violino del 1966-67. Circola in questa musica un messaggio universale che è parte essenziale della sua coinvolgente, talvolta sconvolgente modernità, oltre gli enigmi e i tormenti di una vita senza sorrisi. È il messaggio che Anna Achmátova aveva colto con commovente immediatezza ancora nel 1958, dedicando a Šostakovič la sua poesia intitolata Musica:
Lei sola con me parla,
Mentre gli altri temono di avvicinarsi.
Dopo che l’ultimo amico ebbe volto lo sguardo,
Essa fu con me nella mia tomba.
E cantava come il primo temporale
O come se tutti i fiori avessero iniziato a parlare.







