Bollas: dall'aggressività alla vitalità
La lettura dei libri di Christopher Bollas trasforma la percezione della realtà e, in alcuni momenti, anche di sé stessi. Sarà forse perché Bollas rivolge la sua attenzione a quella soglia d’esperienza in cui la finestra sul mondo sembra aprirsi per la prima volta e il sentimento del reale inizia ad animare la vita. Anche nel suo nuovo libro, intitolato Solitudine essenziale. Lezioni su Winnicott (Raffaello Cortina Editore, 2025), Bollas concentra la sua attenzione sulle prime esperienze dei bambini mostrando quanto la relazione con l’Altro, che viene incarnato innanzitutto dalla madre, sia fondamentale per costruire le basi per sentirsi liberi di esplorare la vita con creatività. Nel libro Bollas ci accompagna in un viaggio nell’opera di Donald Winnicott, un viaggio che è scandito dalle lezioni che aveva tenuto a cavallo tra il 1986 e il 1987 nell’Istituto di neuropsichiatria infantile dell’Università La Sapienza di Roma. Nel rinomato Istituto di via Sabelli Bollas ha tenuto regolarmente le sue lezioni per tanti anni, guidando e ispirando diverse generazioni di clinici che erano direttamente coinvolte nella cura dei bambini e dei giovani. Nel contesto delle Rome Lectures on Winnicott – è questo il sottotitolo dell’edizione in lingua originale – Bollas ha approfondito il pensiero clinico di Winnicott e allo stesso tempo ne ha fatto l’occasione per giocare con la psicoanalisi, per fare della psicoanalisi un’esperienza di gioco, sia nel momento dell’incontro con il paziente sia nella fase di elaborazione teorica. Negli anni in cui Bollas sviluppava queste lezioni su Winnicott troviamo forse i suoi contributi più creativi: L’ombra dell’oggetto viene pubblicato nel 1987 e da lì a qualche anno sarebbero seguiti Forze del destino (1989) ed Essere un carattere (1992), che considerati nel loro insieme costituiscono una trilogia imperdibile per comprendere la profonda originalità di un autore che ha iniziato il suo cammino psicoanalitico nel gruppo degli “indipendenti” britannici. E questo risuona anche nelle pagine di Solitudine essenziale, dove il pensiero di Winnicott viene presentato innanzitutto attraverso alcune analogie e differenze rispetto alla prospettiva di Melanie Klein (tendenzialmente gli “indipendenti britannici” venivano riconosciuti così perché a livello teorico e clinico non si collocavano, pur essendone influenzati, né nella posizione di Melanie Klein né in quella di Anna Freud, che nel Novecento sono state un po’ come le due “madri” della psicoanalisi inglese).
Bollas raccoglie da Winnicott l’eredità di un pensiero clinico che privilegia l’esperienza della creatività e del gioco come chiave di lettura per comprendere le traiettorie della vita di un essere umano sin dai primissimi balbettii della sua esistenza. È in questo frangente temporale che l’esperienza della solitudine diventa fondamentale per l’esistenza del soggetto: si tratta infatti di una condizione dell’essere che precede la dipendenza dalla relazione con l’Altro e addirittura la sensazione di essere vivi. È una solitudine che viene prima dell’instaurarsi della relazione con l’Altro e riguarda una dimensione primaria in cui la realtà emotiva non ha preso forma.
È molto difficile immaginare questa condizione che sembra preannunciare la vita pur manifestandosi come un “intervallo di non-vita”, però diversi casi clinici molto gravi mostrano la non automaticità dell’accesso dell’essere umano alla sensazione di essere vivi. Attraverso un altro orientamento teorico-clinico, e in tempi più recenti, Massimo Recalcati ha proposto la concettualizzazione delle “neo-melanconie”, che si presentano come delle forme psicopatologiche dove risulta centrale l’assenza del sentimento della vita. Diventa sempre più frequente la difficoltà di molti pazienti a sentirsi soggetti di un’esperienza propriamente umana. Oggi le lezioni di Bollas su Winnicott, sebbene siano datate, divengono ancor di più importanti per approfondire la comprensione di quei fenomeni clinici che interrogano il modo contemporaneo di instaurare la relazione con l’Altro.
Certo, se seguiamo Winnicott e consideriamo gli aspetti su cui Bollas focalizza l’attenzione, allora sembra che gran parte del destino relazionale degli esseri umani dipenda dalle madri. Però a questo proposito possiamo evidenziare che la relazione con l’Altro distingue due livelli, due piani relazionali che Winnicott indica con due modi di concepire la madre: la “madre ambiente” e la “madre oggetto”. Possiamo infatti riprendere le due versioni della madre secondo Winnicott come due funzioni dell’Altro, senza relegare così la figura del padre a quel Terzo che compare solo come un guastafeste per mettere ordine tra madre e figlio rompendo la loro tendenza simbiotica.
La solitudine è una condizione essenziale che precede ogni trama e conflitto edipico, riguarda piuttosto la continuità dell’essere che fa da sfondo al “vero Sé”. Il vero Sé è il potenziale ereditato che connota la dimensione unica che caratterizza la personalità. Il vero Sé di cui parla Winnicott è l’espressione del marchio singolare che differenzia un soggetto, a questo proposito Bollas ha formulato il concetto di “idioma”, che sebbene non coincida del tutto con il vero Sé, tocca comunque la spinta a esistere e a realizzarsi nella propria differenza assoluta. Per esprimere il vero Sé è necessaria però quella continuità dell’essere che si sperimenta nella solitudine essenziale.
Il vero Sé non si riferisce a un’identità stabile e definita una volta per tutte, va concepito piuttosto come un movimento soggettivo di scoperta, un movimento che può realizzarsi solo grazie alla presenza dell’Altro. È qui che la madre diventa quell’Altro imprescindibile che fa nascere il movimento di scoperta del vero Sé.
Questa scoperta avviene in un’area relazionale intermedia, che non è specificatamente né all’interno della psiche né nel mondo esterno. È un’area “transizionale” che consente di esplorare la vita giocando con creatività, anche quando è in gioco l’esplorazione della dimensione più propriamente aggressiva che contraddistingue l’impeto relazionale di un neonato o di un bambino verso la madre.
“L’aggressività traduce l’essere in vitalità ed è vitale per la formazione dell’individuo”, sottolinea Bollas. E affinché questo transito dall’aggressività alla vitalità diventi possibile è necessario che la madre si sdoppi nella funzione di “madre ambiente” e di “madre oggetto”. Secondo Winnicott la “madre sufficientemente buona” costruisce un contesto relazionale e ambientale in cui il bambino può rivolgersi a lei come un oggetto verso cui può esprimere la propria aggressività. Sarà successivamente, grazie alla sopravvivenza della madre oggetto – la madre continua a esistere nonostante la spinta aggressiva del bambino – che il bambino potrà sviluppare una “preoccupazione responsabile” verso l’Altro. Se invece la madre non accoglie la spinta aggressiva del bambino, allora il bambino incontrerà una certa difficoltà nel distinguere ciò che effettivamente definisce la sua spinta aggressiva verso la madre in quanto oggetto della fantasia dalle conseguenze negative che possono ripercuotersi sulla madre in quanto oggetto della realtà. In questa seconda evenienza il bambino si trova costretto a inibire la sua spinta aggressiva senza poterla tradurre in vitalità perché non ha potuto sperimentarla in un ambiente contenitivo capace di segnalare che l’Altro sopravvive e non è turbato dall’eccedenza aggressiva che connota la sua esplorazione del mondo oggettuale. Il contenimento avviene quindi non a causa della limitazione di questa eccedenza aggressiva che sorge spontaneamente nella relazione con la madre oggetto, ma dalla testimonianza che l’Altro materno sopravvive alla tendenza distruttiva del bambino: è in questo modo che il bambino può riconoscere e amare l’alterità radicale dell’Altro, un Altro che continua a esistere al di là dei suoi impeti aggressivi.
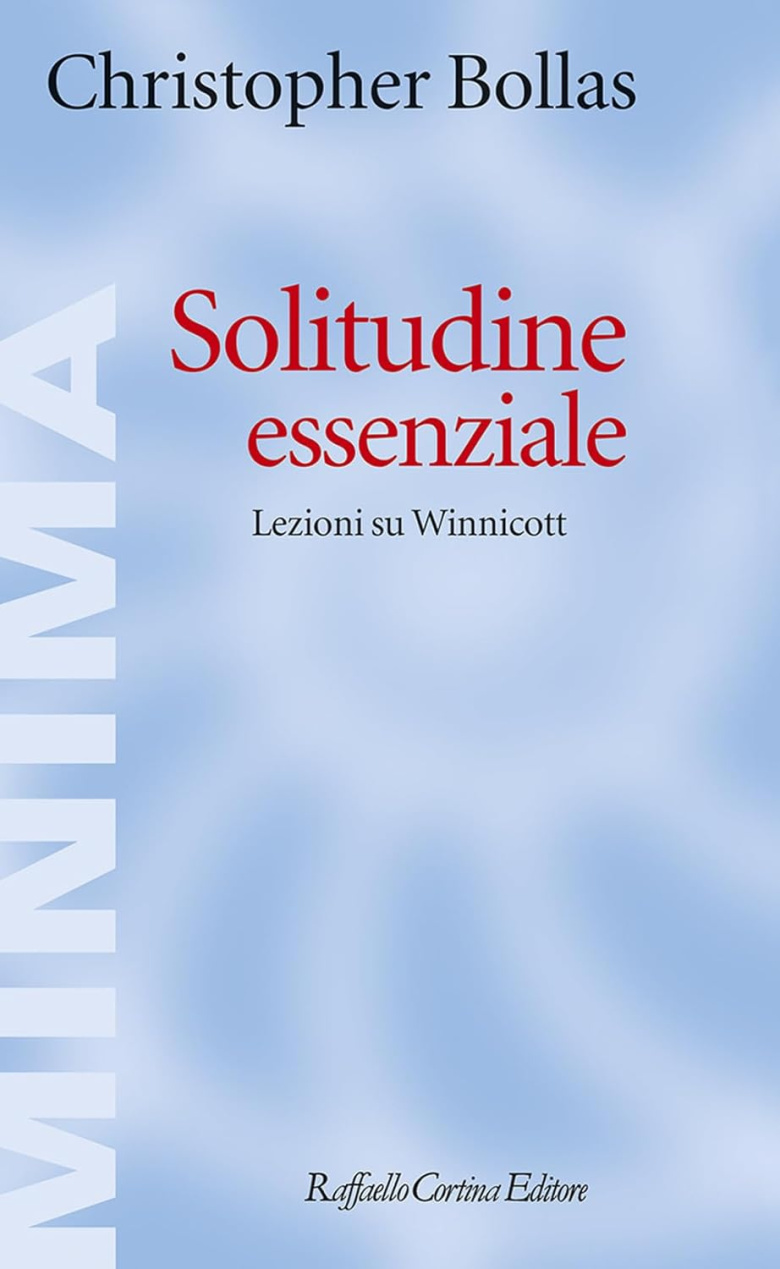
Questo non vuol dire che la madre debba essere un oggetto alla mercé dei capricci del bambino, semmai la questione è quanto la madre riesca a configurarsi come un Altro che permette al bambino di convertire l’aggressività, che distrugge, in una vitalità che riconosce l’Altro in quanto Altro. Un bambino può imparare a non temere la sua spinta aggressiva e a trasformarla come una spinta esploratrice e vitale se nelle primissime esperienze relazionali troverà uno sguardo sorridente e un tocco amorevole che accoglie il suo impeto invece che un Altro che si disorganizza, che non accoglie o respinge l’eccedenza che lo spinge a trascendere sé stesso nell’incontro con il mondo e la vita.
A differenza di Melanie Klein, Winnicott – come fa notare Bollas – pensa che la possibilità di integrare la spinta aggressiva con il riconoscimento dell’Altro scaturisca non dal senso di colpa che il bambino prova accorgendosi dei danni provocati dalle proprie spinte aggressive, ma dal piacere sperimentato nell’esplorazione aggressiva della relazione con la madre oggetto. In questa fase precoce della vita è il piacere, e non il senso di colpa, che produce l’integrazione.
La madre ambiente si configura allora come un campo relazionale in cui il bambino può sperimentare il piacere di “mangiare” la madre oggetto per accorgersi nel corso del tempo che l’Altro esiste al di là di ogni volontà di appropriazione o di ogni fantasia di distruzione. In diverse lezioni Bollas addirittura sottolinea che una delle caratteristiche essenziali della salute di un neonato consiste nella capacità di essere “spietato” nell’uso dell’oggetto, cioè di relazionarsi con la madre, per esempio, quando viene allattato al seno senza pensare a lei, ma dedicandosi al piacere di mangiarla e distruggerla e, poi, ritrovarla.
Secondo Winnicott questi aspetti diventano rilevanti anche nella relazione terapeutica tra paziente e analista: anche l’analista deve dare testimonianza della sua sopravvivenza di fronte alle eventuali dinamiche aggressive che può rivolgergli il paziente. Come viene evidenziato da Bollas – e come è stato ripreso anche da Recalcati nei suoi contributi sull’odio e sul controtransfert – attraverso questa forma di sopravvivenza l’analista fa sorgere quell’area intermedia tra il soggetto e l’Altro che permette al paziente di fare un “uso dell’oggetto” dando forma alla realtà emotiva che contraddistingue la relazione intersoggettiva.
In tale cornice l’Altro compare nell’esistenza del soggetto come ciò che resta, come ciò che sopravvive e sa interagire nonostante e grazie all’aggressività. Il piacere, che può essere sperimentato in quella che Bollas definisce “inter-aggressività”, trasforma le spinte pulsionali in un gioco esplorativo e creativo di nuovi stati del Sé. “Quando il vero Sé è libero di entrare in gioco, il Sé e l’altro sperimentano una combinazione piacevole, quasi sensoriale, di aggressività, intelletto, allerta somatica, vivacità gestuale e divertimento per il fatto di essere insieme”.
Secondo Winnicott la dimensione simbolica scaturisce da questa forma di mutualità tra il gesto del bambino e l’azione della madre: il simbolico emerge dalla creatività intersoggettiva e, in fondo, anche la stessa psiche sorge come un’elaborazione immaginativa di questi primi momenti in cui avviene il balbettio dell’essere con l’Altro. La psiche compare come quella parte del soggetto che si occupa della relazione con il corpo e con il mondo esterno, ed è nella psiche che, utilizzando la terminologia di Bollas, viene registrato l’idioma di un essere umano.
Lo sviluppo del vero Sé è fortemente condizionato dalla funzione contenitiva (e creativa) della madre, una funzione che – ci ricorda Bollas – persiste per sempre nella psiche come un’impronta, come la porta di ingresso in quell’area intermedia dove gioco e creatività diventano possibili. È sulle soglie di quest’area transizionale che Bollas vuole riportarci, attraverso l’opera di Winnicott illumina quei frangenti e quelle zone della psiche plasmate dall’idioma delle cure materne, lì dove – per ciascuno di noi – riecheggia quel battito temporale che trasforma la solitudine essenziale nel punto di insorgenza del sentimento della vita.
Leggi anche:
Ivan Paterlini | I tre caratteri di Christopher Bollas
Moreno Montanari | Bollas: essere un carattere
Moreno Montanari | Bollas: Forze del destino







