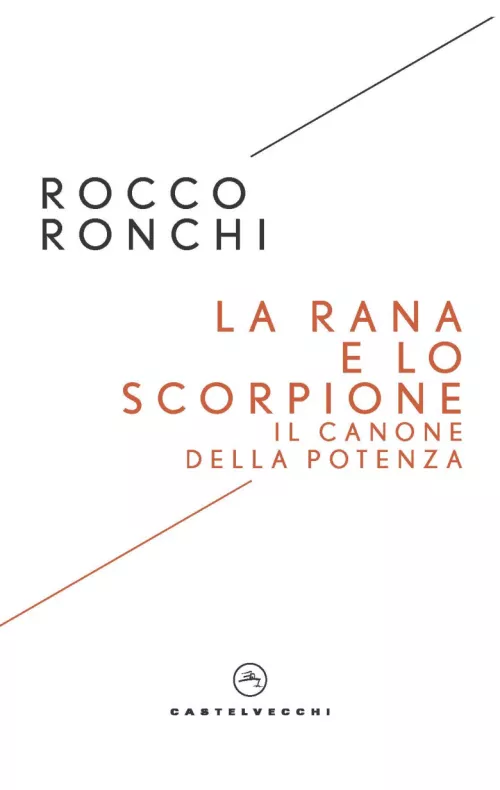Rocco Ronchi e lo scorpione
Molte filosofie si accompagnano a una specie di animale guida. Penso al cane, per Platone, che vuol dire un lupo addomesticato, capace di frequentare la res publica senza sbranarla come farebbe un lupo. Dunque, per l'esattezza, l'animale platonico non è il cane e basta, è il cane anziché il lupo. È in questa differenza che si capisce che cos'è il cane platonico, che posto occupa in quella filosofia. Penso alle anatre meccaniche di Descartes, ai porcospini di Schopenhauer, quelli che come tutti sanno devono stare lontani l'uno dall'altro per non pungersi, ma vicini abbastanza per scaldarsi almeno un po'.
Penso alla colomba di Kant, che vola nonostante la resistenza dell'aria, salvo che il buon Kant le spiega che no, è proprio grazie alla resistenza dell'aria, non nonostante, che lei vola. Insomma, le spiega che noi conosciamo grazie alla necessaria resistenza dei nostri modi di conoscere, e che conoscere è deformare, non conformare. Penso a Heidegger, con le sue inaspettatissime api, a cui dedica pagine meravigliose in un corso universitario intitolato I concetti fondamentali della metafisica. Chi l’avrebbe mai detto, Heidegger apicultore? E penso a Bergson con le sue vespe, che nell'Evoluzione creatrice sono le luogotenenti di quella facoltà quasi mistica che altrove lui definisce, anzi celebra come intuizione.
Che coincidenza, si dirà, queste api heideggeriane, queste vespe bergsoniane. Ma no, in filosofia non ci sono coincidenze. Il fatto è che Heidegger, gran lettore di Bergson, benché poco incline a dichiarare i suoi debiti, oltretutto verso un francese, fa fare alle sue api le stessissime cose che Bergson faceva fare vent’anni prima alle sue vespe (1929, 1907). Intuire il mondo anziché oggettivarlo. Incontrare le cose in una specie di parentela fondamentale anziché in una specie di obiezione fondamentale, come potrei chiamare l’atteggiamento, lo stile d’esperienza, di chi va incontro al mondo come oggetto o come insieme di oggetti, o detto meglio, di chi, proprio con questo atteggiamento, con questo stile d’esperienza, fa diventare il mondo un oggetto, un insieme di oggetti. Che problema stanno ponendo, questi due entomologi della filosofia? Perché le api, perché le vespe sulla soglia della metafisica del ventesimo secolo?
Intanto, mi accorgo che anche in questo caso vale la regola del doppio animale. Così come per Platone bisogna dire che l'animale guida è il cane anziché il lupo, allo stesso modo per Bergson bisogna dire che l'animale guida è la vespa e non l'uomo, e allo stesso modo per Heidegger bisogna dire che l'animale guida è l’ape anziché il dasein, questo strano animale che Heidegger battezza con un neologismo tedesco. Il neologismo gli serve a mettere al posto di quello che la tradizione aveva chiamato l’uomo, quest’altro animale chiamato dasein e dotato, anziché di ali e fiori e alveari, disposti in una specie di immediata prossimità sognante, di un linguaggio che nomina le cose scontornandole dal mondo, e di quella specie di conseguente condanna che è la visione del nulla, che fa la stessa cosa del linguaggio spostandola ovunque e moltiplicandola ovunque. Orla le cose del mondo facendone degli oggetti scontornati, scontorna lui stesso, il povero dasein, inchiodandolo al suo qui, separandolo in un luogo tutto suo, segregandolo dalla cosmologia.
Esce in libreria un nuovo libro di Rocco Ronchi, anzi, per non farci mancare niente, escono due suoi libri contemporaneamente, ed ecco servito su un piatto d'argento un nuovo animale guida. È lo scorpione. Lo troviamo nel titolo del primo dei due libri, La rana e lo scorpione. E così, guarda combinazione, troviamo subito confermata la regola del doppio animale. L'animale ronchiano non è lo scorpione e basta. È lo scorpione anziché la rana, lo scorpione a differenza della rana. Faccio questo pensiero e subito mi dico quest'altra cosa. Sono davvero due animali diversi, sono davvero due? A ben vedere, anche il doppio animale platonico dovrebbe suggerire che non sono diversi, non sono due. Il lupo e il cane sono, semmai, due varianti dello stesso animale, sono lo stesso animale diviso in due modi. Di più, il lupo e il cane sono, in un caso il lupo allo stato puro, nell’altro il lupo allo stato impuro, lupo dimezzato, lupo disturbato dal sapere, lupo che si è specchiato nel linguaggio. Lupo che riflettendosi ha iniziato a vedersi come un se stesso. Lupo che siccome si è dimezzato, anche si è impadronito di sé. Padrone di sé in quanto castrato. Vai a sapere, che strani giri prendono le cose.
E la rana e lo scorpione? Ronchi ci ricorda intanto da dove vengono. Vengono da un film di Orson Welles, Mister Arkadin (1955), il cui protagonista, in vena di ammaestramenti morali, racconta ai suoi commensali questo apologo. Ci sono una rana, uno scorpione, un fiume. La rana sa nuotare, naturalmente, e lo scorpione, naturalmente, non sa nuotare. Lo scorpione vuole attraversare il fiume e cerca di convincere la rana a portarlo sull'altra riva. La rana, che è intelligente, e questa è la sua disgrazia, gli risponde di no. Tu mi pungerai, gli obietta, perché mai dovrei fidarmi di te? Lo scorpione, che non è intelligente affatto, ma che nella sua stupida testardaggine sa essere ancor più intelligente della rana, le replica in un modo che l'intelligenza della rana trova convincente. Perché mai dovrei pungerti, se quando saremo in mezzo al fiume la mia vita dipenderà da te?
Abbiamo già capito come va a finire. La rana, ascoltando non tanto lo scorpione quanto il logos, come diceva un antico, gli crede e se lo carica in groppa. Comincia a nuotare, raggiunge la metà del fiume, e a quel punto un dolore atroce le trafigge la schiena. L’intelligenza della rana è stupefatta. Perché mai l’hai fatto, chiede allo scorpione? È la mia natura, le replica lo scorpione annegando con lei. Ronchi è molto sottile, e dice che a quel punto della storia dobbiamo immaginare che la voce dello scorpione diventi rauca, un verso inintelligibile, spaventoso, almeno per noi, almeno per l’intelligenza, per quelle rane che tutti siamo. È così, aggiungerei, che Kafka fa parlare Odradek, in quel racconto strepitoso che si intitola Il cruccio del padre di famiglia. Odradek che forse è un essere umano, forse un animale, e forse una cosa, nella fattispecie un rocchetto di filo. Ora parla, ora sibila, ora la sua voce sembra un crepitio di foglie secche sospinte dal vento d’autunno.
Se c'è una linea specificamente italiana della filosofia, quella linea ha la sua parola chiave nella parola “atto”. Giambattista Vico radicava negli atti dei corpi, come li chiamava, la sua straordinaria genealogia della ragione umana. La ragione pesca nei bassifondi della nostra gestualità quotidiana, della nostra espressività corporea, pragmatica, animalesca, spiegava nella Scienza nuova. Non si può fondare o rifondare qualcosa sulla ragione, come tutto il razionalismo seicentesco sperava di fare, senza aver visto, senza aver fatto i conti, con questa fondazione allotria della ragione negli atti dei corpi. È la risposta napoletana a Descartes, la risposta che l’umanità dei gesti spedisce oltralpe all’umanità del cogito. Viene anche da lì, e da prima ancora, questa linea attualista della filosofia italiana.
Non stupisce, se guardiamo le cose in questa prospettiva, che per esempio il marxismo italiano abbia un’originalità così specifica, nel panorama dei marxismi novecenteschi internazionali. Un’originalità che muove dagli studi su Marx del giovane Giovanni Gentile, il campione dell’attualismo italiano in senso classico, l’ideatore e promotore del termine al rango di parola chiave della filosofia e di un intero programma culturale, di cui di solito stupisce scoprire questo giovanile esordio marxiano o marxista. Un’originalità che si spinge in avanti, fino ad avventure più recenti ma fedeli alla linea. Pensiamo a Toni Negri, a Mario Tronti. Pensiamo a Cacciari, che venendo da una linea anche lei a suo modo attualista, quella di Gustavo Bontadini, e poi di Emanuele Severino, si realizza nel suo marxismo giovanile, e forse eterno. Materialismo dei gesti più che della materia, o della praxis e delle pratiche, come direbbe Carlo Sini, che proviene a sua volta dall’attualismo, quello di quell’anti-gentiliano originalissimo che fu Emanuele Barié, e che via Sini arriva fino a Ronchi e oltre.
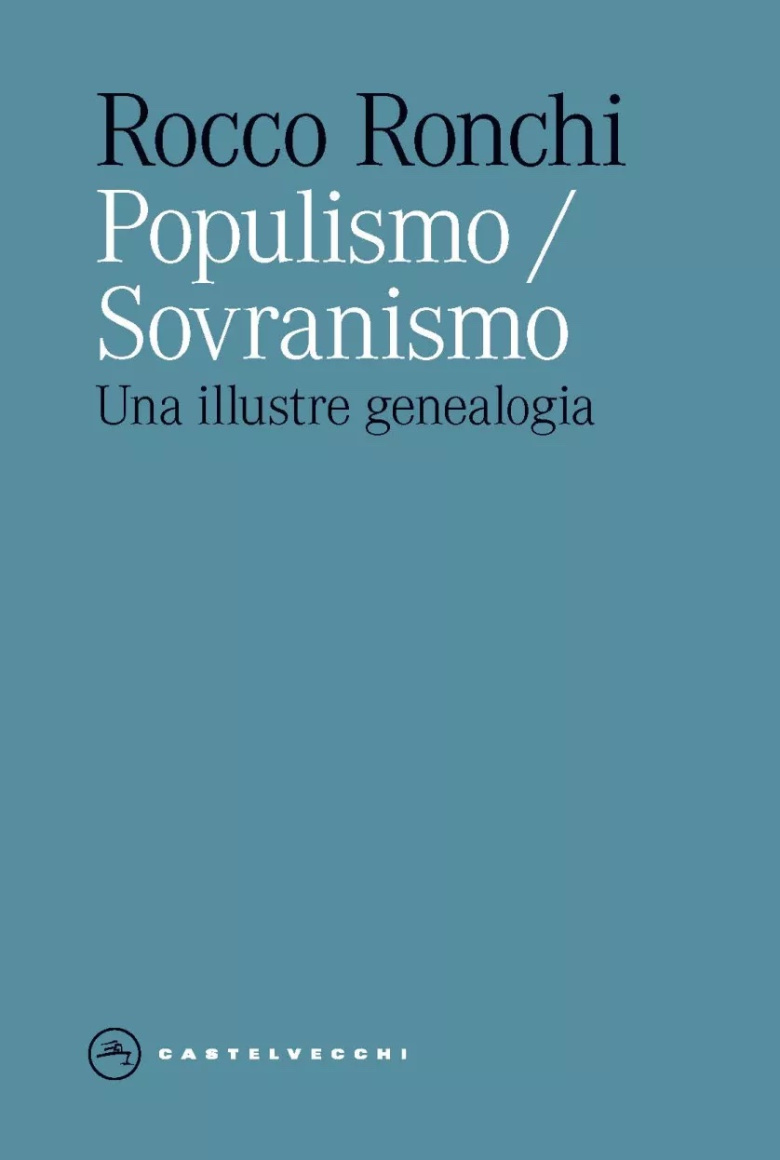
Si dirà che quella che tratteggio è una genealogia pericolosa. Gentile è insieme e non per caso il filosofo dell'attualismo e il filosofo del fascismo, ministro eminente del regime, e fino all’ultimo zelante collaboratore della feroce repubblichina di Salò. Vero. Per questo la faccenda dell'atto offre un vertice di osservazione straordinariamente penetrante su quel sanguinoso laboratorio filosofico e politico della contemporaneità che è stata l'Italia filosofica e politica di un secolo fa. Per questo La rana e lo scorpione esce insieme a un secondo libro intitolato Populismo/Sovranismo. La coppia dei due libri è preziosa proprio in quanto coppia, proprio in quanto dittico filosofico-politico. È come se nei cento anni, grosso modo, che ci dividono dalla Marcia su Roma, dovessimo leggere, mi pare dicano questi due libri letti insieme, un’ininterrotta battaglia per la definizione della natura dell'atto della nostra esperienza, della nostra esperienza in quanto in atto, se guardiamo la vicenda sul piano filosofico. O per la costruzione di un’esperienza collettiva di quell’atto, per la costruzione di un’esperienza nella quale realizzare quell’atto come atto che è sempre comune, comunitario, comunista, se guardiamo la vicenda sul piano politico.
Anche per questo, soprattutto per questo, il secolo che abbiamo alle spalle è un secolo di incessante oscillazione tra fascismo e marxismo, o se si preferisce tra tanti rinascenti neofascismi e altrettanti rinascenti neomarxismi, questi ultimi ormai impalliditi e da decenni latitanti dal dibattito intellettuale e dalle pratiche condivise, ma proprio per questo sempre più necessari. Mi spingerei anzi a dire che anche qui vale la regola dell’animale doppio di cui dicevamo. Si tratta cioè di una stessa cosa che si presenta in due modi, più che di due cose, o di una stessa questione che si declina sempre in due varianti. Certo, ciascuna delle due pensa che l’altra sia catastrofica. E hanno ragione entrambe, ognuna è la catastrofe dell’altra. Che il grande proto-attualista Fichte, il grande filosofo dell’atto come Wille und Leidenschaft, come volontà e come passionalità, stia loro alle spalle in uguale misura, e spieghi questa così scomoda e oscillante vicinanza dei nemici? Spesso in effetti Marx mi sembra più un fichtiano che un hegeliano.
Che c'entra tutto questo con La rana e lo scorpione? C’entra eccome. L'animale guida di Ronchi è lo scorpione perché lo scorpione è l’animale attualista. È l’animale che “non può non”, secondo la ricorrente formula che troviamo in queste pagine. Non può non pungere la rana, a costo di affogare con lei. Non può non dare corso alla sua natura che è una natura tutta processuale, tutta di cose da fare o di cose che si fanno spontaneamente in lui. È una potenza che non può non passare all'atto. In questo, non è dissimile dalle api di Heidegger o dalle vespe di Bergson. L’ininterrotto è la cifra comune a tutti questi animali, compreso, ma è troppo lontano per dirne qualcosa, il lupo platonico. Con una differenza, mi pare. Heidegger delle api, come Bergson delle vespe, vuole mettere in evidenza la familiarità con il mondo, la prossimità coi fiori nel caso delle api, con i bruchi di cui le vespe si cibano nel caso di Bergson. Ininterrotta continuità del vivente e delle cose che definiscono il suo ambiente, dell'insetto e del suo mondo.
Ronchi vuole mette in evidenza un’altra cosa. Direi, l’ininterrotta continuità dell'insetto con se stesso, l'inerenza di ogni atto a un nocciolo profondo, l’ininterrotto riversarsi di una potenza specifica in un atto votato alla sua specificità imperiosa. Se l'ape è una figura dell’aperto, dell'appartenenza allo spazio dischiuso del mondo, se la vespa è una figura della lotta, della coappartenenza dei nemici e del loro coincidere come il diritto e il rovescio di un guanto, lo scorpione è una figura del destino. È una figura dell'andare a fondo nel proprio pozzo. È un emblema dell'incendio in cui la benzina che noi siamo va a fuoco in ogni istante, interamente, luminosamente, implacabilmente. Lo scorpione è l'atto puro, come lo chiamava Gentile, l’atto in quanto è in atto, come lui diceva con un’insistenza, un raddoppio caratteristico. Ma soprattutto, lo scorpione è il messaggero di una tradizione antica e frammentaria, carsica ma coerentissima, alla cui ricostruzione Ronchi dedica alcune tra le pagine più rigorose e più ispirate della sua produzione.
Se l'immagine che mi è appena venuta in mente, quella della fiammata luminosa e inevitabile, ha qualcosa di mistico, qualcosa dell’universo di Georges Bataille, a cui Ronchi aveva dedicato quarant’anni fa il suo primo libro (Un sapere passionale. Bataille Levinas Blanchot, 1985), quello che ora ci presenta Ronchi con La rana e lo scorpione è un vero tour de force logico e metafisico. Un tour de force il cui grande antagonista è Aristotele, e il cui eroe è un filosofo minore, massimamente minore, tale Diodoro Crono, un filosofo di cui non resta quasi nulla, nato a Megara e fondatore di una scuola che prendeva il nome dalla città. La sua scuola venne sconfitta da Aristotele e dagli aristotelici, ma Ronchi suggerisce che essa sopravvisse, come un pensiero che non si può non pensare, a proposito, un’ipotesi che anche non volendo dobbiamo ritrovare di continuo. Nello stesso Aristotele. Contro i suoi stessi interessi, come dicono i venditori di auto usate.
Pensiamo a una cascata. Se una cascata si riversa dall'alto della montagna, direbbe Aristotele, l’antagonista del filosofo megarico, è perché ha una qualche potenza di cadere, che poi si attua nella caduta. Ecco, il filosofo megarico, l’antagonista di Aristotele, è quel filosofo che obietta che in realtà quella potenza si sta sempre esercitando, anche quanto la massa d’acqua non cade. Obietta che la potenza non può essere distinta dal suo atto, che una potenza è potenza se si realizza, se no è impotenza. La cascata sta precipitando anche quando una diga la tiene in sospeso. Dunque non esiste potenza sospesa. Dynamis non è che energheia. Nel greco pre-aristotelico, del resto, dynamis significa proprio questo. Significa forza, non potenza che potrebbe, ma potrebbe anche non, tradursi in atto. La potenza è anancastica, in Omero. La grande dea Ananke, la grande dea Necessità presiede alle vicende dell’Iliade. Achille non può non fare Achille, Ettore non può non fare Ettore. Il loro atto è più grande di loro. Ne sono sopraffatti. Loro quasi non ci sono. Sono il luogo del loro atto, sono attraversati dal loro atto. Non ne sono gli autori, non ne sono i soggetti. E infatti non sembrano più di tanto umani. Sembrano piuttosto scorpioni. Ogni volta è tutto il cosmo a precipitare nel loro atto.
Ecco, tutto l’interesse di Ronchi è rivolto a mettere a fuoco questo atto anancastico, questo atto che non può non dare corso a se stesso, questo atto inumano e inintelligente, sovrumano e ipnoticamente cosmologico. Un atto tutto diverso dall'atto di quell’animale-ranocchia che noi siamo, dall’atto di quell’animale dubitante che noi siamo. Noi non siamo tutt'uno con il nostro atto, non siamo attraversati dal nostro atto come da una necessità. Siamo in rapporto con esso, grosso modo come io sono in rapporto col mio ombrello. Lo tengo tra le mani chiedendomi se valga la pena portarlo con me oppure no, se questa pioggerella meriti che io lo apra o non ancora. Lo scorpione è la sua dynamis, mentre io, piccola rana, piccolo Amleto, eroe moderno e non antico, ho la mia potenza come un oggetto. Posso disporne perché ne sono separato, ho la mia potenza come mia proprietà appunto perché non è mia, e ne sono esiliato. O almeno, così credo, così crede quella cosa che chiamo io. I miei tic, i miei sogni, i miei lapsus dicono altro.
Questo insomma è il punto teoretico di La rana e lo scorpione, e questo è il passaggio verso l’altro libro, verso la questione politica di Populismo/sovranismo, che è una specie di resa dei conti con il fascismo non solo filosofico, ma storico, e anche contemporaneo, del belpaese. Dicevo prima che se c'è una linea specifica della filosofia italiana degli ultimi tre o quattro secoli è la linea della filosofia come filosofia dell'atto, e se c'è una posizione specifica della filosofia di Ronchi all'interno di questa linea, la posizione specifica di Ronchi sta nell'esigenza di definire l'atto come atto megarico, come atto che non può non dare corso a se stesso, come destino. L'atto che interessa a Ronchi è questo atto passionale. Lo scorpione quasi lo subisce, questa sua azione di fatto è una passione. Faccio di nuovo opera di storico, ricordo di nuovo il primo libro di Ronchi. Un sapere passionale. A conferma, come diceva qualcuno, che ogni pensatore pensa una cosa sola, Ronchi direbbe quella che non può non pensare.
Che cosa ha a che fare questo atto passionale con l'atto dell'attualismo fascista, con l'atto smodato del leader populista, con l'atto inconsulto che il popolo festeggia nel suo capo affacciato al balcone di palazzo Venezia, o sproloquiante sui suoi stessi social media? Pochissimo. Moltissimo, in un certo modo. Quanta filosofia, lo dico a margine, si scrive con questa formula. In un certo modo, in un altro modo. Tutta una filosofia dei modi, della modalizzazione. Un’unica sostanza in molti modi, un unico evento che si modalizza. Anche Spinoza è megarico, secondo Ronchi. Anche Agamben, che pure a Ronchi non sta simpatico, in un certo modo è l’antimegarico per eccellenza, e in un certo altro modo è megarico. L’atto passionale e l’atto fascista sono modi della stessa cosa. O forse uno è la sostanza, e l’altro è un modo catastrofico di quella sostanza?
Sintetizzo brutalmente. Il fascista è qualcuno che vuol compiere un atto anancastico come se fosse suo, è una rana che vuol diventare scorpione ma non smette mai davvero di essere rana. È l’immaginario dell’atto passionale, ma manovrato da qualcuno che ci vuol scrivere sopra a lettere d’oro: io, l’ho fatto io, questo atto puro sono io. È questa firma, a far transitare l’atto cosmologico in un atto egologico. È la cancellazione di questa firma a far transitare l’atto fascista dalle parti di un atto cosmologico. Tutto sta a entrare in questo intrico, tutto sta a imparare a maneggiare questo labirinto di specchi, che somiglia, per citare ancora il gigante Orson Welles, a quello del finale della Signora di Shanghai. Tutto sta a maneggiare questo sistema di somiglianze, di scambi, di passaggi, di parodie reciproche, come mi è già capitato di dire. Ecco, non vorrei sovrapporre le mie ossessioni alle ossessioni di un altro. Ma mi pare questo, il punto, all'orizzonte di questi discorsi si vede una cosmologia, si vede la necessità di ripensare tutto ciò che da qualche secolo a questa parte abbiamo pensato in chiave egologica, in chiave cosmologica, in chiave cosmopolitica.
Leggi anche
Alessandro Carrera, Trump e Musk: in principio è l'azione