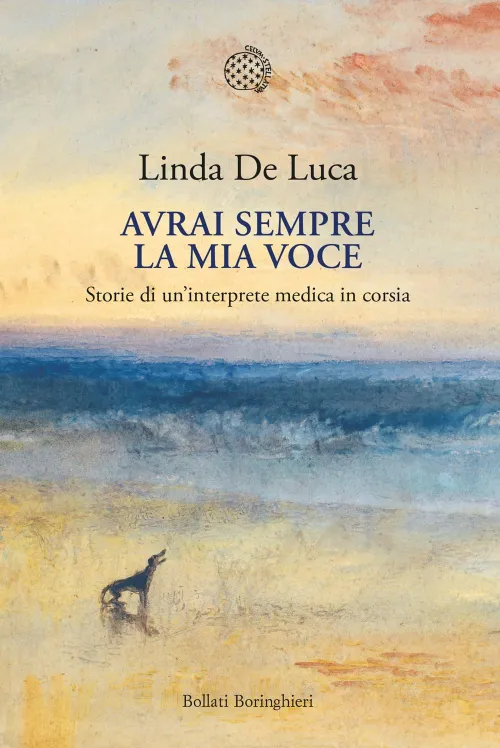Tradurre il dolore in parole
Avrai sempre la mia voce, (Bollati Boringhieri) di Linda De Luca, racconta storie di una interprete medica in ospedale che, fin dalla premessa, evitando inutili circonvoluzioni, ci ricorda che il tema di fondo è il dolore. Il dolore fisico causato da un trauma inaspettato e imprevedibile, il dolore cronico provocato da una malattia che coinvolge più parti del nostro corpo, quel dolore che non ti abbandona quasi mai e ti può rovinare la vita. Esiste anche il dolore che arriva dritto al cuore, quello causato da azioni o parole che ti feriscono in profondità, quel dolore che quasi mai sappiamo gestire razionalmente; poi esiste il dolore di riflesso, il dolore di cui siamo testimoni, quello che aumenta in proporzione al grado di empatia di cui siamo dotati; quello che fa versare lacrime davanti alla scena straziante di un film o spegnere un sorriso di fronte a una persona sofferente. E di questo dolore sono custodi coloro che lavorano negli ospedali. Quale altro luogo contiene tra le sue mura più dolore di un ospedale?
Il libro è diviso in capitoli che toccano, partendo una breve citazione letteraria, tutti gli aspetti delle relazioni umane, rese molto più complicate dalla mancanza di comprensione per una barriera linguistica. A maggior ragione se tutto questo accade in ambito ospedaliero: per venire a conoscenza di una malattia, per sapere e interpretare le possibili cause e saper decidere sulle eventuali opzioni terapeutiche, per accettare gli effetti della comunicazione di notizie tragiche o della reazione del nostro corpo a terapie coraggiose, per trovare la forza di reagire di fronte a tutto questo. L'autrice parte citando un verbo in inglese “Advocate” la cui etimologia ha origine dal latino “advocatus” cioè participio passato di “avocare”, chiamare a sé. Ma nella nostra lingua significa assumersi la responsabilità di esprimere un giudizio su una questione e consigliare le azioni da intraprendere nel momento in cui notiamo che la sicurezza e la salute, ma anche la dignità umana di una persona sono a rischio per mancata comprensione del senso di un discorso che ci viene rivolto in una lingua che non conosciamo o che conosciamo in modo imperfetto.
Nella lingua inglese “to advocate” richiama “to add a voice” cioè aggiungere una voce; una voce di supporto che non riguarda noi stessi ma in cui ci sentiamo tanto coinvolti emotivamente da non poter fare a meno di intervenire. La parola ”advocacy” ha dunque sempre suscitato contrasti perché, praticamente, l'intervento di un interprete non dovrebbe modificare il significato delle parole: idealmente la padronanza delle lingue si accompagna alla conoscenza delle relative culture e quindi, oltre a essere in grado di tradurre una conversazione e riportare le informazioni comunicate, il linguista-umanista sa anche cogliere qualsiasi potenziale sottinteso o malinteso derivante da un’espressione idiomatica come una gestualità o da un semplice sguardo.
In particolare la lingua italiana è spesso accompagnata da gesti o movimenti corporei che veicolano il messaggio, chiaro per un italiano, ma di difficile lettura per un inglese, per esempio.
Linda De Luca entra a piedi pari in questo mondo, deve considerare le linee guida che prevedono una posizione neutra nella transazione culturale, una traduzione fedele, possibilmente quasi asettica, però dopo un breve periodo di assestamento, sebbene le linee guida sottolineino che l'abbandono del ruolo di traduttore puro comporti il rischio di interferire nella comunicazione, l'advocacy è comunque accettata, anzi raccomandata quando diventa moralmente inaccettabile non intervenire. Nel momento in cui cioè sia semplicemente disumano stare a guardare, mentre la salute del paziente viene messa seriamente a rischio. Racconta Linda "capita molto spesso che un paziente in sala d'attesa racconti all'interprete la propria storia confidando particolari della malattia o dettagli personali che poi non vengono richiesti o non emergono nel colloquio con il medico: è chiaro che se il paziente confidasse la sua allergia ad alcuni farmaci all'interprete e il medico somministrasse un farmaco contenente una delle sostanze senza saperlo l'advocacy diventerebbe, non solo necessaria, ma anche moralmente doverosa. Molti altri dettagli personali non rilevanti possono non essere rivelati e il confine diventa spesso molto labile e dipende dal giudizio personale del professionista intervenire o meno. La sua sensibilità e capacità di valutazione vengono costantemente messe alla prova.”
Nella stesura del libro l'autrice dichiara di aver avuto, come intento iniziale, quello di creare una sorta di diario in cui raccontare le storie incredibili dei pazienti che aveva conosciuto, facendo emergere l'empatia e l'umanità che viveva quotidianamente nelle corsie d'ospedale e nelle sale d'attesa.
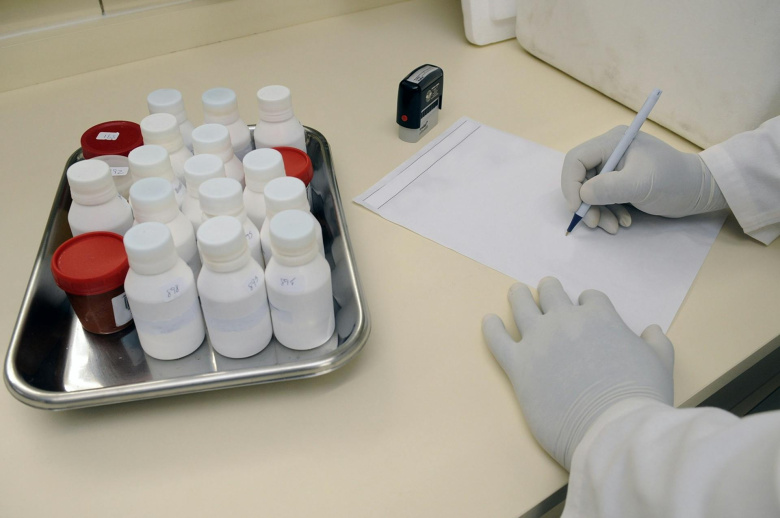
Linda ha una storia molto particolare: nasce a Milano, comincia ad occuparsi di traduzioni, si trasferisce negli Stati Uniti dove si specializza come interprete medico. Svolge cioè la funzione di interprete di corsia in grandi ospedali di New York, insegna italiano alle Nazioni Unite e ha creato una scuola che sostiene la necessità di un interprete specializzato per lavorare all’interno di un ospedale. Sì, perché questa è la sede del dolore, questa è la sede dove anche un piccolo errore può avere conseguenze molto negative sulla vita di un paziente. I personaggi che si incontrano nel libro sono molto singolari; sembrano usciti da una scena del recente film di Salvatores Napoli- New York: emigrati calabresi che parlano malamente l’inglese anche se vivono negli Stati Uniti da molti anni, perché spesso hanno trovato il modo di interagire all'interno di una comunità dove la lingua parlata è molto differente dall'americano classico, immigrati abruzzesi, personaggi che da sempre si muovono nella Brooklyn dei quartieri, dove le minoranze hanno trovato una loro posizione e una loro modalità di sopravvivenza anche senza una perfetta conoscenza della lingua ufficiale. Quando queste persone, normalmente anziani, si trovano a dovere prendere decisioni relative alla loro salute, non possono non avere bisogno di un interprete specializzato. La specializzazione consiste nell’acquisizione di terminologia e conoscenze che riguardano il mondo medico e tecnico e le possibili applicazioni tecnologiche per singole malattie. Un lavoro quindi molto difficile e molto specializzato che purtroppo ancora oggi non esiste nel nostro paese. Linda parla di competenza e sensibilità, sicurezza e umanità, tutte combinazioni di elementi strettamente complementari tra loro, ancor più nelle professioni mediche e linguistiche e cita il poeta W.B. Yeats “Nothing can be sole or whole, that not been rent” cioè nulla può essere unico e intero che non sia stato lacerato. Va da sé dunque che le persone che sono state maggiormente “strappate” in termini metaforici o fisici con un taglio chirurgico con suture o qualsiasi altra manovra medica, e cioè i pazienti di un ospedale, siano anche le persone che meritano più cura. Perché se si può tradurre il dolore significa che c'è una lingua di partenza e una di arrivo e, per tradurre la lingua del dolore in tutte le sue forme ed eccezioni, occorre conoscerla e comprenderla.
Uno dei capitoli più importanti del libro si intitola “L’arte dell'ascolto” e parte con una citazione di Seneca. Racconta De Luca "ho sempre trovato affascinante ascoltare le persone non solo nel significato primario di prestare attenzione ai discorsi altrui ma nella più profonda azione di annullare le proprie opinioni e frenare le proprie parole per permettere all'interlocutore di svuotare completamente il suo cuore e la sua testa”. I buoni ascoltatori non interrompono per raccontare la propria esperienza personale o per commentare o peggio ancora per criticare. È evidente che nel mestiere dell'interprete l'ascolto è il primo passaggio fondamentale, dopodiché arrivano anche la comprensione a livello linguistico, la rielaborazione mentale del concetto, la ricerca dei termini della lingua in oggetto, la selezione di quelli più corretti adatti al contesto, infine l'espressione verbale e tutto questo deve avvenire in pochi secondi.
Linda racconta di una macchina negli ospedali newyorkesi che si chiama Martty, un monitor, un lungo tubo verticale con ruote che viene trascinato dal personale sanitario nelle varie stanze dove serve assistenza linguistica: si digita la lingua desiderata e sul monitor compare il volto di un interprete professionista che traduce tutto quello che viene detto al paziente e quello che il paziente deve comunicare. Questa macchina è di grande aiuto quando si devono tradurre frasi brevi come "disinfetti la ferita tre volte al giorno e se si arrossa ci avvisi subito” oppure “per favore dica al dottore che sono allergico alla Amoxicillina!”. Ma Martti è un utilissimo assistente virtuale che non racconta gesti ed emozioni.
Dice la De Luca: “Spesso, quando mi chiedono spiegazioni per l'assenza di questo servizio in Italia, rispondo qualcosa tipo purtroppo non ci sono i fondi”.
La nostra sanità pubblica offre spesso un ottimo servizio ma per le lingue non c'è spazio: è evidente che in una vera società multietnica, multiculturale, quindi multilinguistica, come quella americana, la percezione della necessità di un'assistenza linguistica strutturata aumenti notevolmente. Racconta De Luca: “sono però anche convinta che nel nostro paese non ci sia consapevolezza di tale necessità e non so dove affondano le radici di questa inconsapevolezza, cosa sfugge dell'importanza del comunicare nella stessa lingua. Possiamo davvero considerarci un paese così insensibile al tema da non comprendere che il servizio di interpretariato medico può trasformare il processo di guarigione di un paziente o arginare gli effetti collaterali o evitare stress e frustrazione che non mancano mai tra le mura di un ospedale grazie al migliore standard di cura?” In Italia ci si limita a chiamare un interprete qualsiasi, molto spesso un familiare che così può tradurre a suo piacimento tutto quello che viene detto. Dice sempre Linda: “da molto tempo ormai ho smesso di credere che il fattore emotivo non influenzi la risposta del nostro corpo; una risposta sul piano fisiologico, psicologico, chimico che può generare, se trascurata, un reale disturbo o peggio una patologia”. Tradurre deriva dal latino traducere da trans (attraverso) e ducere (condurre) e significa portare oltre, far passare attraverso il confine invisibile che porta al superamento di un ostacolo che impedisce l’accesso, costruire il famoso ponte che collega due rive lontane: non si può prescindere dal significato della parola quando si traduce una lingua. Non quando si traduce il dolore.