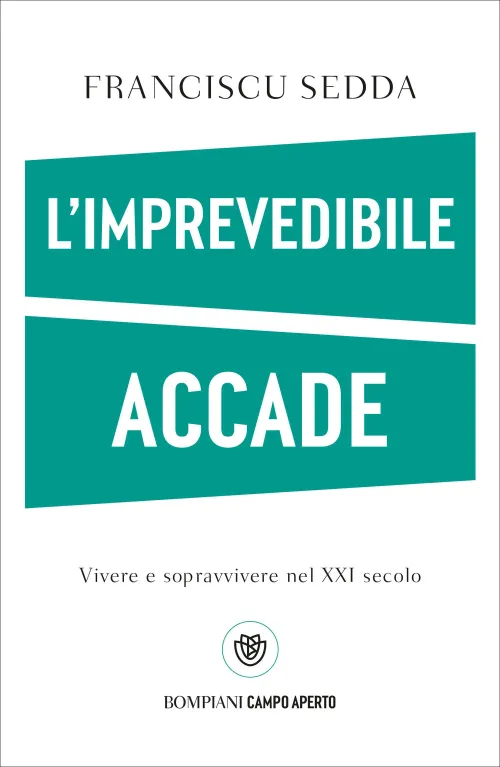Viaggio vertiginoso nell'imprevedibile
Vivo qui, ma l’imprevedibile potrebbe da un momento all’altro mandarmi altrove verso luoghi e destini per me ora assolutamente imponderabili. Come diceva quello “È la vita, bellezza!”. La stabile instabilità del nostro tempo non fa che ribadirlo, con una angosciosa drammaticità. Proprio in questi giorni (agosto 2025) i potenti della terra si stanno confrontando sui destini di popoli e terre alla ricerca di nuovi assetti economico-militari che muteranno radicalmente la vita di milioni di individui e l’imprevedibile sembra quanto mai essere il marchio della Storia. Tutti abbiamo contezza di che cosa sia l’imprevedibile. Altro è capirne le (non) ragioni.
E sembra impossibile che un concetto evanescente come l’imprevedibile possa persino diventare chiave d’accesso per la comprensione di un’epoca, la nostra, che dell’intorcinarsi ha fatto la sua cifra. A fronte di un tutto che si va scomponendo, parlare di imprevedibile sarebbe ovvio e superfluo se non fosse che abbiamo la necessità di recuperare l’energia per tenere insieme un mondo che, per esempio, della inquieta “surrealtà” tecnologica dell’AI e dei computer quantistici sta facendo un cardine. Quindi lo sforzo della riflessione sull’imprevedibile significa mantenere la tensione all’esistere. Ed è questo il compito che, con energia encomiabile, si è assunto il semiologo Franciscu Sedda con il suo L’imprevedibile accade. Vivere e sopravvivere nel XXI secolo (Bompiani 2025, pp. 334), un viaggio bellissimo (il termine non è scelto a caso) nell'imprevedibile, cioè in una – forse la – dimensione fondante della nostra vita. Che, quando il vento è a favore, è proprio come dice l’autore: “E poi invece, magari dove e quando meno ce lo aspettavamo, l’imprevedibile accade. Mentre eravamo impegnati in altro, l’imprevedibile arriva e ci strappa via dalla monotonia del quotidiano aprendoci a una sinfonia dei sensi. E quando accade sembra essere pura vita, sembra essere la vita stessa, tutta intera, l’unica che valga la pena di essere vissuta.”
Perché l’imprevedibile? Perché oggi? Scrive Sedda: “è che l’imprevedibilità è entrata a far parte del nostro orizzonte esistenziale sospinta da crisi ecologiche, sanitarie, economiche, umanitarie, geopolitiche, così come da inusitate innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche” (p. 24) e “focalizzare un po’ della nostra attenzione sull’imprevedibilità – sui suoi molteplici modi di presentarsi, dispiegarsi, intrecciarsi alle nostre vite – può aiutarci a ritrovare segni, linguaggi, narrazioni, discorsi, sensibilità per dirla, pensarla, gestirla, conviverci, con questa imprevedibilità”. Nell’odierno mondo del controllo e della programmazione rivolto a ogni aspetto della organizzazione umana si vorrebbe che anche l’imprevedibile fosse sottoposto e sottomesso alla riproducibilità, ma è proprio per questo che esso riemerge “potente come ultimo fortino dell’umano”. Ecco il nodo. “Perché non scordiamoci che l’imprevedibilità sta al cuore della creazione e della (migliore) creatività. Anche a questo serve immergersi nelle sue dinamiche: a opporre un’imprevedibilità creativa a una distruttiva. O quantomeno a massimizzare la quota di creazione dentro un’imprevedibilità che è sempre, anche e necessariamente distruzione, crisi, caos. Traduzione del senso in nuovo senso” (pp. 30-31).
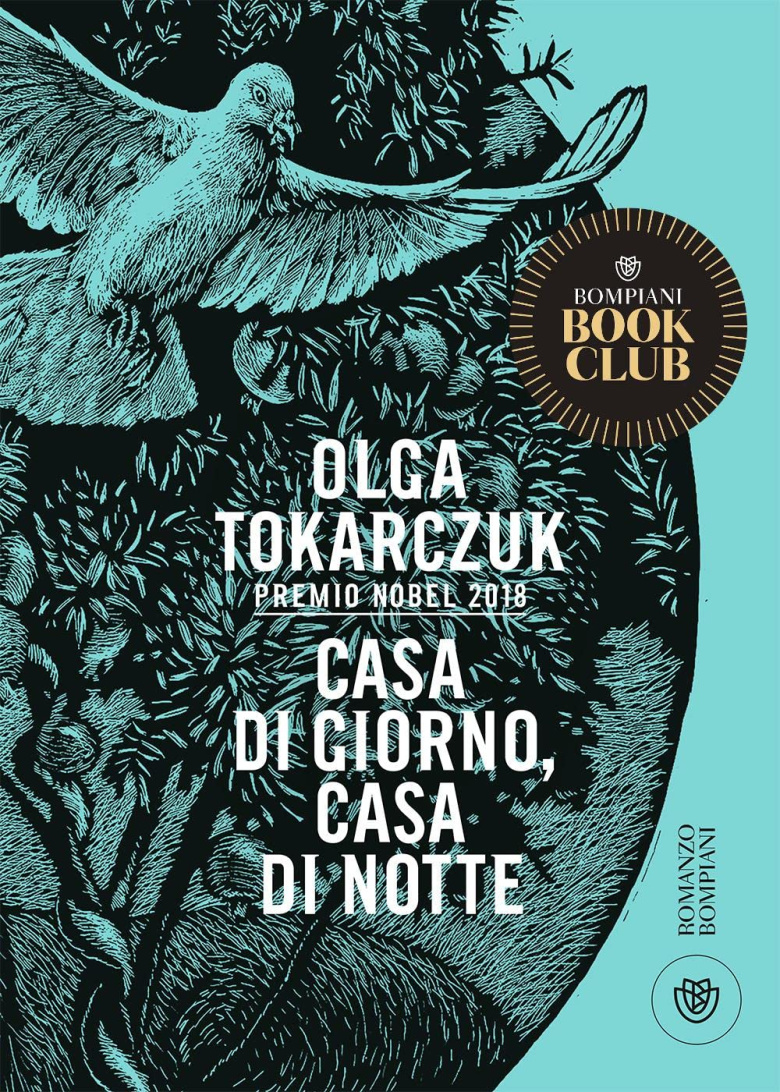
L’analisi dei diversi contesti in cui l’imprevedibile accade, gli alvei in cui avviene, è una sorta di introspezione del “sistema” umano: vita, morte, creazione, errore, nuovo, crisi, cambiamento, incertezza, apertura, azzardo, scoperta, fluidità, rivoluzione, stranezza, eccezionalità, incidente, miracolo, caso/caos (leggendo il libro ho costantemente pensato anche alla malavita come il “sistema di sistemi” di una delle “attitudini” dell'imprevedibile). Il fatto è che, scrive Sedda, “Pensare l’imprevedibilità è compito al contempo impossibile e inevitabile. Inevitabile perché l’imprevedibilità è parte decisiva dei nostri vissuti. E chiede dunque di essere pensata. Impossibile perché, come abbiamo visto e come vedremo meglio, non appena si prova ad analizzarla per definirne il preciso contorno questa sfugge e si ricrea un po’ più in là, fuori dalla nostra portata analitica” (p. 175).
Non si può non pensare alla Molteplicità di Italo Calvino, l’ultima delle Lezioni americane, dove si dimostra quanto la “disarmonia prestabilita” (celebre titolo dello studio su Gadda di Gian Carlo Roscioni, Einaudi, 1969) sia stata uno dei massimi terreni di coltura in cui la (grande) letteratura ha affrontato l’imprevedibilità nella vita dell’essere umano. Dice Calvino: “chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili” (Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, 1988, p. 120).
Il destino imprevedibile ha voluto che io leggessi, qualche settimana prima de L’imprevedibile accade, il romanzo Casa di giorno, casa di notte di Olga Tokarczuk, un libro che ora mi appare come l’imprevedibile embodied. “Una miscela di miti e sogni, temi profondi e scene di vita quotidiana, ricette e aneddoti” come dice la quarta di copertina. Storie di personaggi veri-e-improbabili, come tutti noi. La stessa motivazione del Premio Nobel per la letteratura ricevuto dalla scrittrice nel 2018, peraltro, ci mette su questa strada: “per un'immaginazione narrativa che, con passione enciclopedica, rappresenta l'attraversamento dei confini come forma di vita”. Si veda, inoltre, l’articolo particolarmente pregnante di Pietro Pascarelli Dalla psicoanalisi alla letteratura. Olga Tokarczuk, in cui sul romanzo Casa di giorno, casa di notte l’autore nota: “Esso mostra una mescolanza di arcano e solare, mistero e conoscenza, incantesimo e spiritualità che lo pervade e prescinde da ogni logica ordinaria”. La potenza dell’artista è la potenza umana, capace di costruire opere estraendole dal molteplice del mondo.
Insomma: siamo nei territori della contemporaneità più stringente. E la realtà in cui siamo è fatta soprattutto di complessità, una dimensione senza tener conto della quale le dinamiche di controllo e fallimento del controllo non possono essere intese. Come dice Mauro Ceruti, che della complessità continua a studiare le profondità, bisogna indossare “occhiali diversi” perché “La complessità dell’attuale condizione umana ci sfida a prendere consapevolezza di una più profonda crisi che è alla radice di tutte le crisi. È una crisi cognitiva, che concerne proprio la difficoltà di pensare la complessità, di pensare insieme l’unità e la molteplicità. Viviamo un paradosso. Più aumenta la complessità del nostro mondo, più aumenta la tentazione della semplificazione: questa si manifesta nella frammentazione dei problemi, nella frammentazione dei saperi volti ad affrontarli, che si perpetua a tutti i livelli nelle istituzioni educative” (Il Sole 24 ore, 17.8.2025).
La ricognizione di Franciscu Sedda conduce alla vertigine, è “bellissima”, è come stare seduti davanti a un panorama infinito di azioni e reazioni che l’essere umano produce instancabilmente, mettendosi in gioco con tutte le energie possibili per difendersi e affermarsi, comunque. “Se il nostro mondo – scrive Sedda – è oltre il controllo, se è pieno di imprevisti che accadano, è anche perché né il nostro agire, né il mondo nel suo divenire, rispondono a un unico regime. Anzi, ogni fenomeno – in qualche grado, a qualche livello, dentro una qualche prospettiva o processualità – contiene tracce di tutti i regimi, di tutti i tipi di interazione. Imparare a cogliere questo gioco consente di aumentare il grado di consapevolezza e libertà che ci è utile, forse persino vitale, per giocarlo in modo produttivo. O quantomeno a ravvivare la sensibilità per interagire con il mondo grande e imprevedibile in cui siamo gettati, ritrovando il gusto (più gusto) nel farlo (creativamente) nostro” (p. 233).
P.S.: L’osteopata a cui ho dovuto rivolgermi recentemente, alla domanda su che cosa dovrei fare per rimettere in sesto la mia colonna vertebrale mi ha risposto: “Non deve stare seduto, non deve stare in piedi, non deve stare sdraiato”. Beh, per nuotare nel fondale di molteplicità, complessità, imprevedibilità, più che indicazione terapeutica io l’ho recepita come insegnamento di vita.