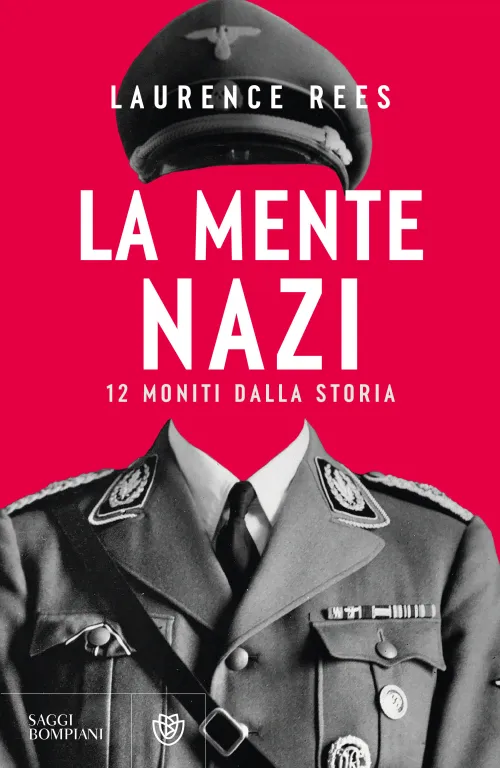Nella mente di un nazista
In Argentina, tra il 1976 e il 1983, nel tempo della dittatura di Jorge Rafael Videla (1925-2013) tutti quelli che erano identificati come oppositori scomparivano senza lasciare traccia. Trenta mila persine sono scomparse in quel tempo. Che effetto ha prodotto da allora la parola «scomparso» nel linguaggio collettivo in Argentina? «Scomparso» è un termine che in quel tempo era molto usato, e che legittimava varie immagini, che non sempre rinviavano alla morte o alla soppressione. È importante scavare in quell’uso vago o multiplo del termine, perché uno dei punti di forza del negazionismo sta esattamente nell’indeterminatezza delle parole. Usare espressioni eufemistiche produce effetti prolungati nella costruzione del senso comune e soprattutto condiziona l’interpretazione dei fatti storici. Così non nominare il crimine aiuta a semplificare la sua negazione posteriore.
L’indeterminatezza del vocabolario è la conseguenza della nona delle regole che Laurence Ress individua nel suo La mente nazi (Bompiani): quella che ha come tema “soffocare la resistenza”. Una tecnica quella del linguaggio ambiguo che si preoccupa di come contenere le domande, come prevenirle e fornire sicurezza. Il fine è comunicare “tranquillità”. I destinati ai campi di concentramento erano lì inviati per un «atto di rieducazione»; l’arrivo ad Auschwitz destinazione camera a gas o in uno dei qualsiasi punti di sterminio era denominato «reinsediamento». L’eufemismo è una delle condizioni che rendono possibile lo sterminio di massa perché contemporaneamente si preoccupa di contenere le reazioni emozionali di un’opinione pubblica, e allo stesso tempo mira a fornire una spiegazione volta a tranquillizzare e dunque a non sollecitare domande ulteriori.
Ovviamente non è una caratteristica specifica di un regime totalitario o autoritario (capita anche nelle nostre democrazie), ma è una delle tecniche che fanno sì che un regime possa dormire «sonni tranquilli».
Rees, analizzando la storia politica, culturale, emozionale del nazismo – da movimento ultra minoritario di «arrabbiati» all’indomani della sconfitta della Prima guerra mondiale a regime totalitario, fino al suo tracollo nella prima settimana di maggio 1945 – individua dodici mosse che rendono il movimento che aspira a costruire totalitarismo capace di realizzare il proprio sogno e poi di mantenerlo il più a lungo possibile.
“Soffocare la resistenza” si colloca nel percorso quasi alla fine, ovvero dopo la presa del potere e quando si tratta di realizzare il compimento del processo (un tempo politico in cui anche solo il fatto che qualcosa non possa funzionare, rischia di mandare per aria tutto ciò che fino a quel momento è stato possibile fare).
Nelle otto mosse precedenti il percorso è volto prima a rendere diffusa e radicata una convinzione e poi a far sì che essa favorisca una profonda trasformazione. All’origine sta l’amarezza della sconfitta e la convinzione che quella condizione sia conseguenza di qualcuno che si è sottratto o che «lavorava» per la parte avversa. La sconfitta era figlia di una speranza tradita, ma anche di una guerra che aveva accantonato la dimensione del duello tra singoli e ridotto gli individui a “appendice di macchine” La guerra era stata perduta perché quei padroni delle macchine avevano mirato ai propri interessi e non al benessere della nazione. I loro interessi coincidevano con il rifiuto del sacrificio. La prima forma della teoria del complotto è dunque una rivolta contro il “perbene”, la società ricca che non accetta il sacrificio, e dunque contro quella parte di Germania che si era sottratta ad esso. La prima regola del complotto già allude alla seconda: una visione del mondo rigidamente diviso in due: «noi» contro «loro».
Una visione che solo apparentemente è esaltazione della massa che subisce, perché il passaggio immediatamente successivo è dato dall’affidare il proprio destino a quei vertici che hanno chiamato alla riscossa. In questo senso la contrapposizione noi/loro (la seconda regola) si sviluppa e si definisce come costruzione di una rigida gerarchia. Che si autorappresenta come “eroica” e che comanda perché trasforma i propri seguaci in “gregari”.
Meccanismo che si costruisce un futuro se quei “gregari” a cui vuole garantire futuro sono identificati con una generazione che può avere domani solo liberandosi dai padroni attuali. Torna la prima regola – la teoria del complotto – ma ora applicata a una generazione che la sconfitta militare ha reso senza futuro e alla quale si tratta di garantire un domani. Una generazione che non ha fatto la guerra, ma che ha sofferto nella propria infanzia e adolescenza le conseguenze della sconfitta e che dunque merita riscatto. Quel riscatto glielo può garantire solo chi non ha responsabilità di quella sconfitta e che può (qui si innesta la quinta regola) andare al confronto con quelle élite che la guerra l’hanno perduta, le quali non possono altro che affidarsi a coloro che hanno subito la sconfitta senza meritarla.

Quel confronto si costruisce su un doppio registro: da una parte accordo, dall’altra affidamento. Un meccanismo che ha come obiettivo costruire un patto senza differenze o in cui i diversi siano neutralizzati, poi marginalizzati e, infine, espulsi. È il sesto passaggio: quello dell’accantonamento dei diritti umani, ovvero della «messa in soffitta» dell’uguaglianza. Ora conta e fa prova l’appartenenza. È la macchina della propaganda, della costruzione del rito collettivo, a consentire questa nuova condizione che costituisce il settimo stadio di questo sviluppo. Nel tempo del nazismo è contemporaneamente sia la definizione dei grandi scenari di massa (per esempio le adunate) ma anche la scenografia che sottostà alle Olimpiadi di Berlino del 1936, come la cinematografia della propaganda realizzata da Leni Riefenstahl (su di lei sono da rileggere le pagine che Susan Sontag gli dedica nel suo Sotto il segno di Saturno, Nottetempo).
Una sceneggiatura che va di concerto con la costruzione dell’immagine del nemico non come sconfitto o impotente, ma come ostacolo da superare. Il nemico non si batte perché debole, ma perché la forza dell’unione, l’eliminazione delle incertezze e del dubbio, comunque l’eliminazione delle perplessità e dunque la costruzione e di una società compatta e la partecipazione al successo della compattezza sono il meccanismo che rende quella vittoria possibile.
È l’ottavo passaggio. Qui si colloca quella politica della lingua in cui le cose si fanno, ma non si dicono. Il nono livello del processo. La compattezza non può essere messa a rischio, ma soprattutto questa politica la cui possibilità di attuarsi si tiene sul consenso produce un effetto esaltante. Possedere la vita del nemico non riguarda più il suo destino, ma la propria potenza. Nell’immaginario collettivo di chi sta nelle retrovie e non sa cosa accade al fronte o nei campi finalizzati allo sterminio e che della guerra percepisce insieme alle difficoltà economiche, la propria condizione di oggetto della potenza dei bombardamenti dei nemici sulle proprie città (un meccanismo che ha una sua storia naturale in cui hanno cessato di valere le categorie di libertà e scelta e che Sebald ci ha descritto con rara efficacia nel suo Storia naturale della distruzione, Adelphi) e che ravvisa quella azione come una risposta punitiva alla propria collettività. L’effetto è l’esatto opposto del fine a cui aspirano i bombardamenti: il senso di appartenenza non si abbassa e l’identificazione con il destino del proprio governo aumenta. Risultato: il tasso di razzismo cresce.
Il nemico non è più umano e per questo si può decidere della sua vita (e ovviamente anche della sua morte) senza farsi molte domande. Ancora meglio se questo avviene senza avere un contatto diretto, anche fisico, con il suo corpo.
È il penultimo passaggio, quello destinato a rimanere nel profondo e a esprimere il proprio atto di potenza. Un tratto su cui Bauman (nel suo Modernità e Olocausto, il Mulino) ha richiamato l’attenzione anni fa sottolineando come lo sterminio nazista non fosse la punta massima della storia, ma l’inizio di una nuova epoca con cui con difficoltà si trattava di fare i conti. Una condizione di potenza che stava appunto nel possesso del corpo degli altri e nella possibilità di disporre della loro vita o di decidere della loro morte. Ancora meglio se questo era possibile senza toccarli, ovvero senza contaminarsi.
E tuttavia quella condizione di potenza coabitava con la paura. Paura di ciò che sarebbe potuto avvenire dopo, se per caso quella macchina si fosse fermata, o, peggio, fosse stata sconfitta. Il che contemporaneamente, induceva a perseverare fino al raggiungimento dell’obiettivo finale.
Si può ritenere che questo lungo percorso in dodici tappe sia eccentrico, tuttavia ha un vantaggio: rende comprensibile un processo che altrimenti risulta specifico e, soprattutto unico. Nella storia non c’è in sé l’unicità, c’è la costituzione di meccanismi che non si ripetono uguali ma che hanno somiglianze. Soprattutto le dinamiche di passaggio verso i totalitarismi non vivono di pezzi che cadono ma di meccanismi mentali e culturali che si sommano e si combinano.
Non accadeva solo allora (circa cento anni fa) e tutto si muove insieme come un efferato e inarrestabile meccanismo.
È stata Ece Temelkuran nel 2019 con il suo Come sfasciare un paese in sette mosse (Bollati Boringhieri) a dare il profilo e il codice di una procedura di indagine. Il tema era come si trasforma un paese. Non era un ragionamento astratto, riguardava un paese con un nome preciso – la Turchia – e il menù del percorso di successo verso la dittatura proponeva sette passaggi. Li ricordo: 1. Crea un movimento (si badi bene, non un «partito», ma un «movimento», al limite una «lega»); 2. Disgrega la logica, spargi il terrore nella comunicazione; 3. Abolisci la vergogna: essere immorali è «figo» nel mondo della post-verità; 4. Smantella i meccanismi giudiziari e politici; 5. Progetta i tuoi cittadini e le tue cittadine ideali; 6. Lascia che ridano dell’orrore; 7. Costruisci il tuo paese.
Quel codice è utile tenerlo a mente prendendo in mano il saggio Laurence Rees, soprattutto per non pensare che quella dinamica in scala non ci riguardi, ora, o sia tutta alle nostre spalle.