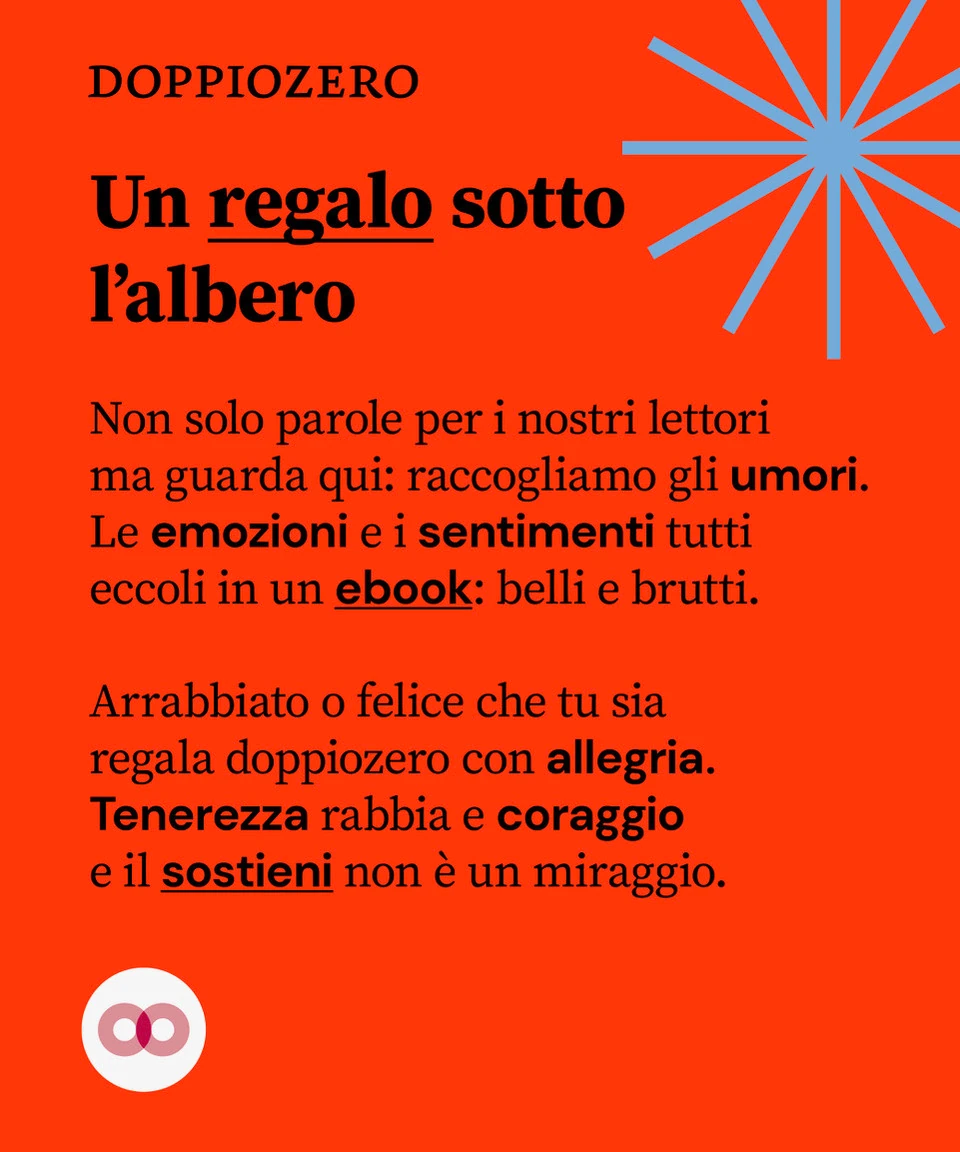Speciale
Speciale Fellini / Cabiria, please, stop crying!
Ogni volta che riguardo Le notti di Cabiria (1957) vedo di più. Così ho aspettato, ho rimandato a lungo prima di scrivere, ma alla fine ho capito che l’incertezza non sarebbe passata mai, perché con Fellini lo smarrimento non è un ostacolo bensì condizione e circostanza creativa della sua opera. Ciò che è reale diventa meno importante di ciò che invece è immaginato o percepito come illusione. Proprio questo disorientamento visionario, che corrisponde alla qualità più speciale delle storie, dello sguardo, dello stile di Fellini, agisce anche da dispositivo spettatoriale costante dei suoi film.
All’inizio, per esempio, sembra tutto facile, come nel disegno fatto da un bambino, o in uno schizzo di regia:

Cabiria in un disegno di Fellini.
Andando avanti, però, il mondo vissuto e sognato da una prostituta/folletto, a Roma, alla fine degli anni Cinquanta, diventa una specie di passaggio magico per un bosco incantato. Prima luce, tanta, e poi buio, come succede all’inizio e alla fine di Le notti di Cabiria. Somigliando ai suoi personaggi, anche chi guarda i film di Fellini, allora, dovrà lasciarsi smarrire, camminare tra le ombre, in mezzo allo scintillìo dei lustrini, alla musica, alle voci. Non si dà, perché non può esistere, la possibilità di chiudere la visione in una stanza conchiusa della mente e delle emozioni. Si tratta, semmai, di fermare alcune esperienze di sguardo, costruendo una trama riluttante all’intero e fatta di brani diversi e ricombinati.
Rispetto a questo modo di operare e di far sentire il cinema come sconfinamento e smarginatura tra visibile e invisibile, Le notti di Cabiria è il film che ha raggiunto alcuni dei risultati più alti; nel senso che è un’opera non solo stilisticamente nuova, ma contemporanea: capace di parlarci, oggi, forse persino di più. Soprattutto quel film, che è uno dei più belli, sembra contenere molto dell’opera di Fellini. La visionarietà non è solo un tema, una condizione formale, un destino della protagonista, ma si sporge sulla stessa filmografia dell’autore, comprendendola e in qualche maniera anticipandola interamente, perché è come se Le notti di Cabiria (1957) avesse già “visto” lo sguardo di Paola, nel finale di La dolce vita (1960), o anche 8½ (1963), Giulietta degli spiriti (1965), I clowns (1970), La voce della luna (1990):

Paola (Valeria Ciangottini) in “La dolce vita”.

Cabiria (Giulietta Masina).
È come se questo film così troppo poco ricordato (uno dei pochi, finora, non disponibili in streaming), trascurato a dispetto dell’Oscar vinto nel 1958, ci consegnasse attraverso la sua protagonista la vera controfigura dell’autore, anche più importante dei personaggi maschili resi leggendari da Mastroianni. È quella “mignottella” buffona la maschera nuda più sincera del cinema di Fellini. E non perché a impersonarla sia Giulietta Masina in quanto “moglie di” Federico, ma proprio perché “Fellini” è lei: “Cabiria”.
Il fatto è che Cabiria “è” il cinema. Prima di tutto perché ha il medesimo nome del kolossal (1914) diretto da Giovanni Pastrone e considerato il più grande film muto italiano: il tipo di cinema che – non si ricorda mai abbastanza – fu quello scoperto e sognato dal bambino Fellini. E poi Cabiria è il cinema anche perché Le notti di Cabiria riprende una figurina chiamata così (già interpretata da Masina) che si trovava in altro precedente film di Fellini, Lo Sceicco bianco (1952), dedicato al potere che i racconti pieni di immagini possono avere sui nostri desideri e sulla nostra capacità di sognare e trasfigurare la realtà. Lo Sceicco bianco (Alberto Sordi) è infatti il famoso protagonista di un fotoromanzo che Wanda, una giovane in viaggio di nozze a Roma, cerca di incontrare, abbandonando in albergo il marito Ivan. Lo sposo, disperato e alla ricerca della moglie, dopo aver provato ovunque, di notte, si ferma a una fontana, e lì, proprio dal buio, ecco spuntare Cabiria, una prostituta romana in compagnia di una sua collega veneta:

La Cabiria di “Lo sceicco bianco”.
Ma c’è di più: in Lo sceicco bianco Cabiria appare, inizia a esistere, per così dire, cinematograficamente, perché di notte, a quell’ora, è letteralmente “uscita dal cinema”: è una spettatrice, e questa è la situazione fondamentale da mettere a fuoco per vedere tutto quello che accadrà dopo. Cabiria, nello Sceicco, comincia a vivere, nello sguardo dello spettatore, mentre parla con entusiasmo del film che ha appena visto. È un sistema di riflessi che l’oscurità dell’ora tarda rende ancora più simile a un incantesimo. Del resto, la condizione di spettatrice è la radice più antica di Cabiria, perché Fellini stesso, nella prefazione del 1976 alla sceneggiatura delle Notti pubblicata da Garzanti, racconta (pp. 5-7) che all’inizio (già intorno alla fine degli anni Quaranta) c’era soltanto un episodio sviluppato da «un’ideuzza» e sceneggiato con Pinelli per Anna Magnani:
imbastimmo rapidamente una storiella che ci sembrava buona. Era la storia di una mignottella aggressiva, ma molto sentimentale, che una sera passeggiando per via Veneto vede uscire impetuosamente da un night-club una donna stupenda in pelliccia di visone inseguita da un uomo in smoking, alto, aitante, un divo allora popolarissimo. L’uomo stava litigando violentemente con la donna – la sua amante – e alla fine la schiaffeggiava. Poi, mentre ancora furioso stava montando sulla sua immensa Cadillac, sorprendeva lo sguardo trasognato, sbalordito della puttanella che aveva assistito all’alterco come se fosse la scena culminante di un film…
Il clic visuale che dà il via al racconto originario è lo sguardo della «puttanella» Cabiria: la storia, il cinema, ha inizio da ciò che lei vede, come se assistesse alla «scena culminante» di un film. Poi, continua a raccontare Fellini:
Per un estro improvviso di provocatoria esibizione, il divo faceva salire in macchina la puttanella e se la portava a casa sua, una lussuosa fantastica villa, dove ordinava un pranzo a base di aragosta e champagne. Ma quando i due stavano per mettersi a tavola, ecco rispuntare l’amante decisa a proseguire il litigio. L’uomo si precipitava a chiudere a chiave nel bagno la puttanella e lei da lì, affascinata e curiosa continuava golosamente ad assistere allo scontro. Ma già i due non litigano più, le voci sono scese di tono, ci sono dei lunghi silenzi. Inginocchiata sul pavimento di marmo della toilette, l’occhio incollato al buco della serratura che incornicia la scena come una inquadratura di un film, la nostra puttanella vede i due amanti gettarsi nelle braccia l’uno dell’altro, baciarsi appassionatamente e fare all’amore tutta la notte. Il mattino dopo, il divo liquidava quella spettatrice sfortunata mettendole in mano alcuni biglietti da mille.
Cabiria è una «spettatrice sfortunata»: questo è il suo identikit, il suo sangue cinematografico, e qui vive la potenza poetica del suo personaggio. Potremo parlare di molti altri aspetti che lavorano nel film, ma non dovremo mai spostarci da questo epicentro creativo e simbolico. Come mostra bene anche il raffronto con un fotogramma che torna in mente guardando Cabiria chiusa nel bagno della casa del divo:


“Psycho” (Alfred Hitchcock, 1960).
Le Notti di Cabiria non costruisce la visione, in soggettiva, dell’azione di qualcuno che spia, come Norman Bates (Anthony Perkins). Lo sguardo messo in scena non deve schiuderci una psiche (e la sua patologia), ma lo spettacolo di un’immaginazione al lavoro. Fellini non ci fa guardare quello che vede un voyeur: non è questa l’esperienza cinematografica che stiamo facendo in quel momento. Fellini ci fa vivere il sentimento di una «spettatrice» che assiste alla realtà, anche fuori dalle sale, consumandola e trasfigurandola come se fosse al cinema. Cabiria è colei che per un miracolo che la vita fa capitare e il cinema reinventa, a un certo punto si trova a vivere la sua attitudine all’illusione proprio nel posto più cinematografico di tutti, vale a dire prima via Veneto, a Roma, e poi la casa di un divo:

Amedeo Nazzari.
«A Federì – avrebbe risposto Magnani sempre secondo il racconto di Fellini –, ma ti pare che una come me si fa chiudere nel cesso da uno stronzo d’attore?». È una battuta straordinaria, anzi è un manifesto di stile, perché chi volesse riflettere sulle diverse personalità attoriali di Magnani e Masina potrebbe effettivamente partire proprio da qui, e dall’unicità di Cabiria, così come lo inventano e lo fanno agire (in senso fisico, drammatico, visuale) lo sguardo dell’attrice Giulietta Masina e lo sguardo della macchina da presa. Tra l’altro, proprio la lettura della sceneggiatura chiarisce uno snodo narrativo reso invisibile dalla realizzazione ma che vale la pena di riconsiderare, recuperando anche la storia. La puttanella Cabiria, che di solito “batte il marciapiede” nella zona della Passeggiata Archeologica, arriva in via Veneto, dopo esser scesa di macchina precipitosamente per un litigio con le amiche e il loro “magnaccia”, per ragioni che il film abbrevia e lascia oscure (forse per lavorare, facendo concorrenza alle “fanatiche” elegantone della zona?), ma che invece il copione chiarisce. Cabiria arriva in via Veneto e si porta «davanti al cinema Rivoli»: per andarvi, evidentemente. Di nuovo il cinema allora, il cinema proprio come spettacolo, e più avanti, nel corso del film, il cabaret o il Gran Varietà, per stare da un’altra parte, per abitare un’oscurità che vale anche in senso onirico e illusionistico.

Il titolo, infatti, oltre che essere il referente spaziotemporale del mestiere di Cabiria, ci proietta addosso il nero come atmosfera dominante di tutto il film. Le notti di Cabiria è una peripezia di buio e di luce – la fotografia è di Aldo Tonti e Otello Martelli. Al punto che potremmo definirlo anche come una specie di grande trattato sull’ombra. Siamo in un mondo notturno: nel senso metaforico di buio, nascosto, pieno di doppi di sé “accantonati”, non visti (come lo spazio appartato dove sta la trans attaccabrighe, o quello delle voragini in cui è rintanata la vecchia prostituta caduta in disgrazia). E notturno, ancora, è il mondo oscuro dei miserabili, sempre sull’Appia Antica, dove solo un miracolo potrebbe far arrivare la luce. Ma, con un’eco che potrebbe provenire anche dalle Notti bianche di Dostoevskij, il titolo mantiene come schermo simbolico costante la solitudine piena di sogni oltre la rete di cui vive Cabiria e assieme a lei tutto il film.
L’episodio dell’incontro in via Veneto con il famoso divo è la matrice narrativa e cinematografica di una storia dalla trama ricorsiva, vale a dire fatta di situazioni e suggestioni visuali che ritornano, chiudendosi e dilatandosi a fisarmonica, come a favorire un senso complessivo di circolarità e ripetizione, ma pure di danza (il Mambo composto dallo straordinario Nino Rota, è eseguito più volte e con strumenti diversi, funzionando da ritornello). Le soglie stesse di Le Notti di Cabiria formano una rima irregolare, un sistema di simmetrie. Sia all’inizio sia alla fine siamo lontani dal centro di Roma e nei pressi di un corso d’acqua (simbolo che evoca la corrente della vita):

La protagonista è tutte e due le volte in compagnia di un uomo con il quale sogna un’esistenza diversa, ma in realtà, in ambedue i casi, si tratta di tipi malintenzionati a ucciderla per portarsi via i soldi. Il film comincia e si conclude con Cabiria che si allontana dalla scena del delitto – nel primo caso perché dei ragazzini la salvano dall’annegamento; nel secondo perché l’uomo non ha avuto il coraggio di ammazzarla ed è fuggito. Tra queste due situazioni che si rispecchiano l’una nell’altra il film ci fa vedere Cabiria che “fa la vita”, nel senso di farcela osservare come esistenza di tutti i giorni, alla maniera neorealista. D’altra parte, Le notti di Cabiria forma un eroismo narrativo e cinematografico tutto già “felliniano” perché il suo elemento sostanziale, diversamente dai protagonisti neorealisti, non è più il pathos e la disillusione disperata (ancora, il raffronto con Magnani è eloquente). Cabiria piange, grida, protesta, ma subito reagisce, senza darci il tempo di soffermarci. Reagisce sempre: quando stava per soffocare, quando capisce che Giorgio ha cercato di ucciderla (e allora subito brucia le sue immagini, le foto), reagisce quando inciampa, contro il sorvegliante del locale notturno che vorrebbe farla smammare, quando sbatte la faccia contro un vetro, andando oltre. A prevalere, dunque, spesso con un’atmosfera surreale, è il tono da folletto con cui gli occhi sgranati e meravigliati di Cabiria affermano il suo speciale talento vitale, che consiste nella capacità di non smettere mai di credere all’invisibile, vale a dire al miracolo di una vita diversa, nell’incontro con un uomo che le voglia bene e la sposi.
In questo senso, anche in questo senso, Cabiria è cinema all’opera. Il suo slancio a un mondo immaginario è compiuto con la disperata vitalità di una specie di saltimbanco, come sembrano suggerirci la fantasia bianca e nera di strisce o quadretti degli abiti:

Henri Rousseau (Il doganiere), Giocatori di football (1908), Solomon R. Guggenheim Museum, New York.

Nella scena iniziale in cui Cabiria, salvata dai bambini, proprio come in una fiaba, viene messa a capo all’ingiù per far uscire l’acqua dal suo corpo, quella figura, così impersonata e inventata dalla macchina da presa, potrebbe essere Pinocchio, un clown (per riferirsi a un altro motivo costante di tutto il cinema di Fellini, e di cui scrive anche Carpiceci su Film Cronache 1/20). È una sorta di buffoneria, di primitivismo d’antan, ma è una buffoneria ricomposta a tempo di mambo quella che abita e attraversa le varie sequenze e situazioni che compongono il film, che non va avanti come a costruire una progressione, ma sembra assecondare l’effetto di una danza fatta di movimenti in avanti, giravolte, intanto che vediamo Cabiria dentro il piccolo cubo di cemento della sua casa (al diciannovesimo kilometro sulla strada per Ostia), nelle zone notturne in cui lavora, a casa dell’attore, di nuovo sul marciapiede e poi dietro all’ ”uomo col sacco” che di notte porta aiuto e conforto ai miserabili (si tratta del famoso episodio inizialmente censurato). E ancora in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore e, dopo la scoperta deludente dell’incompiuto miracolo di cambiar vita, ancora la reazione e la relativa ricerca del luogo in cui la magia si compie sempre, vale a dire il Teatro Varietà dove la scena del mago/diavolo che ipnotizza Cabiria facendole credere di aver incontrato un uomo immaginario che finalmente le vuole bene è una sorta di mise en abyme, che svela e rende esplicito lo scambio tra realtà e artificio, tra visibile e invisibile di cui respira tutto l’eroismo cinematografico di Cabiria, fino all’incontro, fuori dal cinema, con l’uomo dei sogni: un falso innamorato per il quale venderà tutto, pronta a sposarlo, verso l’estremo disinganno.
Raccogliendo uno spunto di Paolo Fabbri («Perché non raccontare le straordinarie avventure del cappello al cinema come si proponeva Ejzenštejn per il Cappotto di Gogol?»: Sotto il segno di Federico Fellini, Sossella 2019, p. 35), si potrebbe effettivamente ripensare a Le notti di Cabiria anche attraverso questo segnale. Guardate:

Il cappello, che slancia la narrativa del corpo facendo volare lo sguardo al di sopra della testa, è significante e icona di un’appartenenza sociale, di uno stile; dentro una finzione, diventa anche cifra immaginosa del desiderio. In questo senso, allora, i cappelli felliniani sono l’emblema perfetto di quell’impasto tra realismo e visione di cui scrive anche Oscar Iarussi nel suo libro (Amarcord Fellini. L’alfabeto di Federico, Il Mulino, 2020). Perché il punto è che l’invenzione di un mondo magico e surreale come quello da cui spunta fuori e a cui tende Cabiria non equivale mai a un azzeramento della realtà – anche qui abita lo stile di Fellini. Il realismo esiste – negli interni della casa di Cabiria, nei miserabili visitati da “l’uomo col sacco” (la parte più “cristiana” del film, molto più di quella sul pellegrinaggio), nel carro dei poveracci che attendono che lei esca di casa, nella parte finale; il realismo è nell’involto grosso di banconote brandito a tavola dalla donna; o nei dialoghi, con l’alternanza espressiva tra italiano e romanesco – furono scritti assieme a Pasolini, che aveva appena finito Ragazzi di vita: «Ma chi è lei?! A sentillo parla' pare uno dei Parioli… un tipo fino!».
D’altra parte, i dettagli di realtà non funzionano mai da didascalia di un “messaggio”, o da scenario dimostrativo di una “storia vera”. Non è alla realtà immediatamente davanti che si deve credere, in questo film così totalmente fondato su una domanda che, variamente modulata, lo percorre dall’inizio alla fine e che, essenzialmente, è: «a cosa credere?» (all’amore? Alle amiche? Alla Madonna? Ai miracoli? Al cinema? Ai maghi?). La soluzione che ci dà il film è circolare: assomiglia a uno specchio rotondo o a uno schermo pieno di ombre, più che a una strada lineare, perché sembra portarci a non credere alla realtà evidente, bensì all’effetto di illusione dell’esistente. «Quella è mica una storia vera, quelle so’ storie che fanno al cinema» dice Cabiria alle amiche. Ecco il punto: Fellini inventa un cinema che sa parlarci delle vite vere usando però le storie che si fanno solo al cinema. Realismo e visionarietà diventano una cosa sola.
Per capire, in un rapidissimo passaggio, cosa abbia inventato Fellini col cinema e come a maggior ragione Le notti di Cabiria sia già traguardo e presagio futuro di questa poetica, si può trovare un esempio ulteriore ripensando a cosa faccia quel film con il corpo cinematografico di Franca Marzi, che interpreta Wanda, l’amica/collega di Cabiria:

Franca Marzi.
Franca Marzi fino ad allora era la “bellissima”, la “maggiorata” degli anni Cinquanta. Invece per Fellini si trasforma in un corpo attoriale attaccato alla realtà dei dettagli (degli abiti, degli sguardi, dei dialoghi, degli spazi), figura di un’umanità disperata mai patetica e che la trasfigura, rendendola l’amica più sincera della protagonista.
Tra l’altro, è interessante osservare che tanto Cabiria, con il suo habitus da buffona malinconica quanto Wanda, con quella grossezza che silenziosamente ci parla di cosa sia davvero il corpo della prostituzione, vale a dire pesantezza, fatica, sofferenza silenziata, aggiungono un ulteriore motivo per cui Le notti di Cabiria è un capolavoro che ha molte cose da dire ancora alla contemporaneità, anzitutto sullo sguardo che possiamo avere degli anni Cinquanta (a pensarci, Le notti di Cabiria è anche il film sulle ombre del cosiddetto “miracolo italiano”, per usare un’espressione usata e svolta in maniera così diversa dal film); ma Cabiria ci parla anche nel senso di farci vivere sguardi diversi da prototipi anche violenti con cui la nostra contemporaneità guarda sé stessa. Il film difatti non racconta, non vede, non mette in scena la prostituzione come fantasia maschile voyeuristica sul corpo femminile, ma rende visibili persone che fanno la vita nel senso di un’esistenza piena di relazioni brutali e di solitudine, “amore che si paga”, come suggeriva il titolo ambiguo di un bel cortometraggio di Lizzani.
«Se tu m’avessi visto quando avevo quindici anni, avevo certi capelli neri lunghi fino a qui...» sospira felice Cabiria rivolgendosi all’uomo immaginario nell’ipnosi, e più tardi al suo promesso sposo Oscar. È proprio la fiducia incrollabile nel cinema come illusione perpetua di contemplazione di fantasmi e di sogni, e dunque come forma di relazione con il mondo, a fare di Cabiria una spettatrice eterna e l’alter ego di Fellini. La scena finale, quando, quasi fosse resuscitata ancora dalla morte, Cabiria si alza da terra, attraversa la selva oscura e si trova in mezzo a una brigata di giovani in tenuta da festa, è un’epifania. Di nuovo la protagonista sceglie di lasciarsi andar via, nel flusso vitale delle illusioni e delle storie. La lacrima fatta di trucco che le cola sul viso disegna il volto di un pagliaccio triste che finalmente, però, sa di indossare il cerone, inchinandosi al pubblico e guardando in macchina. Sincerità e finzione sono inseparabili: lì sta la verità e la magia del cinema. Ed è a quella lacrima che sembra rivolgersi anche Fellini, quando, ritirando l’Oscar alla carriera, nel 1993, grida e ci grida: «Giulietta, please, stop crying!».