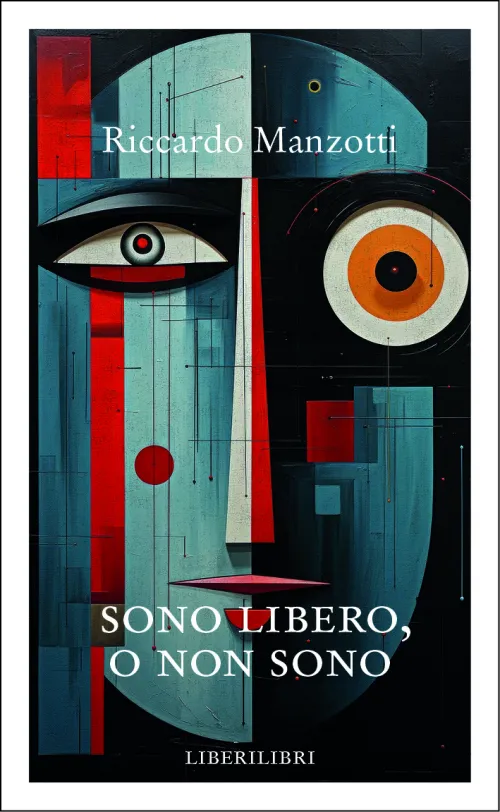Riccardo Manzotti: Mind-Object-Identity
Con un felice acronimo, Riccardo Manzotti ha battezzato MOI la sua soluzione al classico problema del rapporto mente-corpo. MOI significa Mind-Object-Identity. L’identità della mente e dell’oggetto è la sua grande tesi. Proponendola in ogni occasione, Manzotti ha messo a soqquadro il paradigma dominante in ambito neuroscientifico e le certezze del senso comune (si veda, tra i tanti suoi saggi dedicati all’argomento, La mente allargata, il Saggiatore, Milano 2019), attirando su di sé il sospetto dei conservatori, ma guadagnando la simpatia e il favore dei liberi pensatori.
Provo a sintetizzarla in poche battute. Per Manzotti l’esperienza non è un ponte gettato tra un soggetto (io) ed un oggetto (mondo), tra loro separati e incomunicanti per principio, l’esperienza non è rappresentazione, cognizione, immagine, l’esperienza non è neurocentrica, non implica, cioè, che la realtà sia un’opera della rete neurale. L’esperienza, infine, per Manzotti, non è nemmeno “esperienza” se con tale espressione si intende “relazione”, che, scrive nel suo ultimo libro, “è il grande feticcio della filosofia contemporanea” (Sono libero, o non sono, Liberilibri, Macerata 2025, p. 115), dimenticando, però, che anche l’identità è una forma della relazione... Manzotti propone una integrale riduzione della cosiddetta “esperienza” alla dimensione della sola “esistenza”, senza residui di sorta. Un’incessante propaganda, alimentata non solo da presunte evidenze scientifiche ma anche da film, da serie televisive e da luoghi comuni, ci ha addestrato a credere che l’esperienza sia fatta combinando un misterioso “fuori”, che ha i tratti del noumeno kantiano, con un Io-cervello, il quale dall’interno del suo sacco-pelle proietterebbe i suoi raggi intenzionali costruendo in tal modo un mondo di “cose” che non si può a priori distinguere dall’effetto di una allucinazione controllata (è il famoso esperimento mentale del cervello in una vasca collegato ad un supercomputer su cui discettano i filosofi della mente e che il primo Matrix ha illustrato).
In realtà, l’esperienza, secondo Manzotti, non è altro che l’oggetto stesso – qualsiasi oggetto, una mela come un elettrone – nella misura in cui esso è “in atto”, in quanto produce effetti sensibili. La MOI si rivela così: 1) un attualismo, e questo proprio nel senso gentiliano del termine, sebbene Manzotti faticherebbe a riconoscere la sua posizione in quel diluvio di retorica idealistica che è la filosofia di Giovanni Gentile; 2) un esistenzialismo sui generis, perché afferma l’equazione esperienza = esistenza; 3) un neo-megarismo di stampo spinoziano, perché, come facevano quegli antichi filosofi bistrattati da Aristotele e come ripete Spinoza quasi duemila anni dopo, identifica la cosa con la sua potenza di produrre effetti; 4) e, infine, un relativismo integrale perché, a differenza di quanto reputa la scienza galileiana, non si danno mai oggetti assoluti, sciolti cioè dai loro contesti di mondo, localizzati una volta per tutte nello spazio e nel tempo, ma solo oggetti relativi ad altri oggetti, oggetti contestuali. Procedendo in questo modo, la MOI taglia il nodo gordiano del Mind-Body Problem. Sulla scena filosofica contemporanea, Manzotti è così il bambino della fiaba che ride della nudità del re. Il re in questo caso sono le neuroscienze e, più in generale, tutte le concezioni riduzioniste che vorrebbero spiegare la coscienza come la risultante degli impulsi elettrici del cervello, fatto per altro mai empiricamente verificato.
Nello sterminato e, ammettiamolo!, noiosissimo dibattitto sul Mind-Body Problem, la posizione manzottiana è rubricata nell’“esternalismo radicale”, ma di fatto, smantellando il pregiudizio dell’interiorità – l’idea, cioè, di un soggetto-fantasma avulso dal mondo – , Manzotti ci esonera al contempo anche dalla fede in una “esteriorità radicale”. Non c’è più nessun fuori, dove non c’è più nessun dentro, un po’ come diceva Nietzsche nel Crepuscolo degli idoli: se ci si sbarazza “a colpi di martello” della presunzione di un “mondo vero”, bisogna congedare anche il “mondo apparente”. L’apparenza senza verità sottesa, tradita o manifestata che sia, cessa di essere tale. Così come svanisce l’esteriorità quando viene meno l’interiorità di un Io-cervello simulatore di mondi “esterni” percepiti. Che cosa residua allora a questa doppia catastrofe? Manzotti, risponde esattamente come aveva risposto Nietzsche: resta solo il “mondo”, un mondo né vero né falso, resta il “mondeggiare” del mondo (verbo che prendo a prestito da Heidegger), vale a dire il suo accadere, il suo aver luogo “tutto”, senza residui, “qui e ora”, in un presente eterno che ricomincia da capo ogni volta. Una volta che l’esperienza è stata purificata dalle complementari superstizioni metafisiche dell’Io-cervello e del “fuori” noumenico, sulla prima persona che siamo e non possiamo non essere grava allora una nuova inaudita responsabilità perché, se le cose stanno così, portiamo sulle nostre spalle il peso del “mondo” tutto. In ogni momento della nostra esistenza, “ne va” del mondo, di tutto il mondo, presente, passato e futuro. Il mondo ce lo giochiamo ogni volta, in ogni nostra azione, ad ogni lancio di dadi. Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, metaforizzava questo “attimo immenso” con il morso del pastore sulla testa del serpente. Era il momento supremo della decisione grazie alla quale il tempo lineare in cui tutto fugge e tutto si perde incrociava la stabilità dell’eterno. Per questo il semplice fatto di esistere come individui implica, secondo Manzotti, una responsabilità assoluta nei confronti della vita che stiamo vivendo: “L’unico fallimento – scrive Manzotti nel suo ultimo libro – non è morire, ma non vivere e giungere alla fine come Firs, il maggiordomo del Giardino dei ciliegi di Čechov, constatando che «la vita è passata, e io… è come se non l’avessi vissuta”» (p. 131).
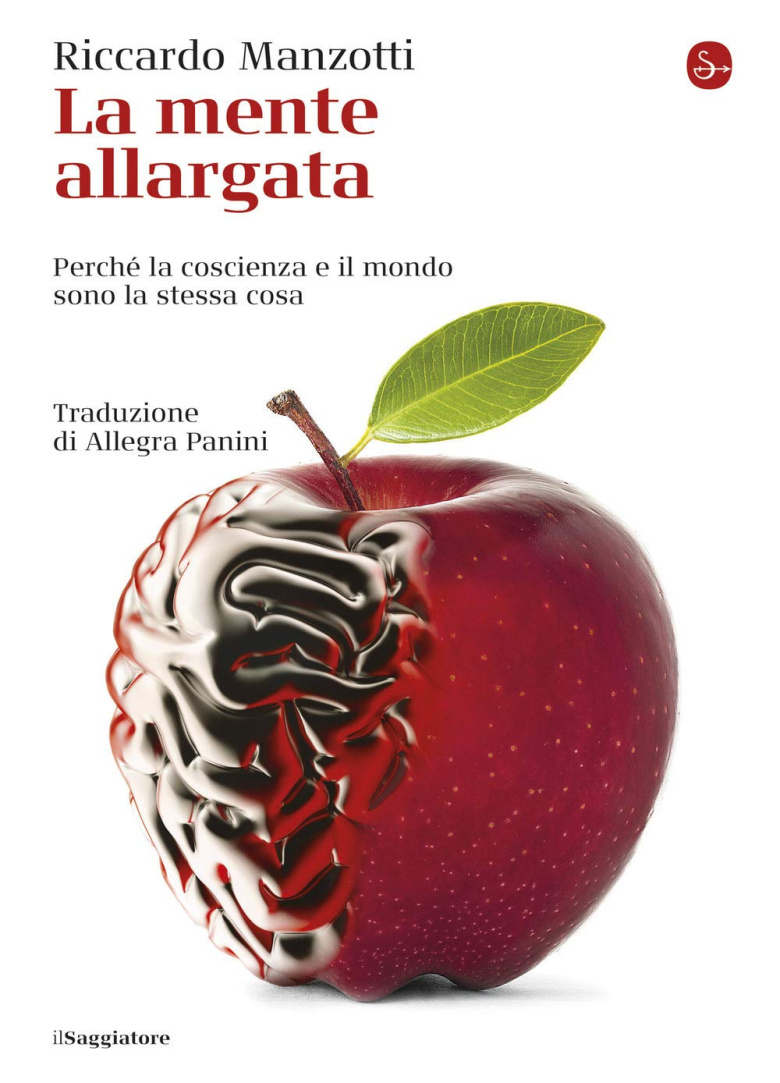
Ecco perché dicevamo “felice” l’acronimo MOI. MOI, in francese, significa infatti me, è il pronome personale tonico che si riferisce all’Io, alla prima persona singolare. Per Manzotti la teoria cosmologica MOI comporta, non come appendice, ma come conseguenza diretta una “rinascita della persona”. MOI significa identità dell’oggetto e della mente e MOI significa me come luogo, qui e ora, di quella “relazione”. Con il suo ultimo libro, dalle tinte fortemente politiche, Manzotti presenta la MOI proprio come un personalismo di nuovo genere. La domanda cruciale che Manzotti pone concerne la natura della persona, irriducibile tanto alla dimensione del solo corpo quanto all’astrazione complementare dell’anima disincarnata. La persona è infatti un terzo rispetto al dualismo asfittico anima-corpo, al quale, tutto sommato, continuano ad attenersi i filosofi del Mind-Body Problem. La persona, che è sempre una prima persona, è quella che si costituisce nell’attimo immenso in cui il pastore nietzscheano morde la testa del serpente, quando la vita è bevuta fino alla feccia, senza differimenti, senza procrastinazioni.
Manzotti chiama “libertà” questo momento capitale dell’esistenza individuale e con una felicissima intuizione fa di questo atto libero il principio di una “gloria” che trasfigura l’esistente (per Nietzsche la “gloria” era l’intuizione dell’Eterno Ritorno). In quell’istante “io sono libero”, ma, se consideriamo attentamente la cosa, la libertà non si aggiunge come predicato ad un essere già dato, ma dell’essere di quell’io è la scaturigine e la condizione di possibilità. Insomma, o sono libero, o non sono, come recita il titolo del libro. Prima di lui lo aveva affermato Henri Bergson nella sua celebre tesi di dottorato del 1889, dove diceva che la libertà è rara, che la maggioranza degli umani passa la vita senza averla conosciuta, di fatto non vivendo, non esistendo, perché, appunto, o si è liberi o non si è. Va notato come anche Bergson, al pari di Manzotti, si rivolgesse polemicamente ad una pletora di “neuroscienziati” del suo tempo e di vecchi spiritualisti, i quali pensavano o che la coscienza fosse riducibile al corpo-cervello o che fosse una sostanza immateriale infusa da Dio.
Ma un equivoco si genera quando questa libertà, che costituisce l’essenza della persona, è interpretata a partire dalla dimensione della “scelta”. Manzotti insiste su questo punto, soprattutto nella prima parte del suo libro, con il risultato di ridurre l’esistenzialismo sui generis della MOI a un esistenzialismo di stampo umanistico molto tradizionale. Il primo capitolo riformula il cogito ergo sum cartesiano con l’equazione: “scelgo dunque sono”. Credo che tale insistenza sull’equazione essere = scegliere si spieghi retoricamente. Manzotti appartiene alla razza dei veri filosofi: se scrive è perché ha qualcosa di urgente da dire, se scrive è perché vuole essere compreso. Per questo non esita a semplificare, parlando una lingua il più possibile accessibile. Bisogna rendergliene merito in tempi in cui l’assenza di pensiero reale si nasconde spesso dietro l’erudizione esibita, ma non va dimenticato che la semplificazione comporta anche dei rischi. Far coincidere la libertà con “scelta” può essere infatti utile a fini polemici per contestare il totalitarismo tecno-scientifico che pretende di scegliere ciò che è bene per noi, trasformandoci in corpi amministrati. È però fuorviante sul piano metafisico, che è poi quello che interessa veramente al filosofo teoretico Manzotti. Perché la scelta possa diventare il criterio della persona e la prova della sua libertà trascendentale (così si esprime Manzotti) bisogna postulare infatti proprio quell’io-soggetto-proprietario, quel foro interiore, che la MOI, come teoria cosmologica, non ha cessato di contestare. C’è “scelta” dove ci sono dei possibili tra i quali poter optare a disposizione di qualcuno. C’è “scelta” dove c’è un soggetto-sovrano avulso dal mondo, che non ne fa parte e che lo può contemplare e dominare dal di fuori (ma da dove?) come un grande oggetto a disposizione del suo libero volere (del suo arbitrio irrazionale). Non è un caso se i sostenitori attuali dell’anarco-capitalismo, i cosiddetti cyberlibertarians, possono illudersi di trovare un conforto teorico in queste formulazioni manzottiane.
È tuttavia lo stesso Manzotti a dover rettificare questa posizione ambigua negli ultimi due capitoli del suo libro, senz’altro quelli filosoficamente decisivi. L’atto libero, dice, è un atto glorioso. La gloria che aureola l’esistenza rendendola degna di essere vissuta comincia proprio quando la “scelta” viene meno. Un esempio, a me caro: gli “eroi” non scelgono, il loro atto libero non discende da una attenta valutazione delle possibilità date, non c’è calcolo e deliberazione, gli eroi agiscono guidati da qualcosa che assomiglia più alla necessità che alla contingenza del libero arbitrio. Fanno quello che devono, più simili a una macchina che funziona, più simili a “servi”, dunque, che a un soggetto libero e sovrano, a un “signore” che dispone del suo potere. L’atto libero è un atto glorioso in questo senso quasi meccanico e servile. Si risolve in una deposizione del potere del possibile per divenire medium di una potenza che non può non esercitarsi e alla quale si corrisponde con un “Eccomi!” (Genesi 22, 1). E se il richiamo ad Abramo può apparire troppo viziato teologicamente, si rammenti che quando il giovane Bergson dovette fornire alla commissione esaminatrice un esempio di atto libero e glorioso propose l’immagine di un frutto troppo maturo che cade dal ramo.
Il filosofo Manzotti non può non riconoscerlo. Dopo aver elevato la scelta, per ragioni di critica politica, a standard della libertà, deve poi ammettere che “la libertà è necessità di un soggetto che esercita questa sua necessità” (p. 127) e che “se è vero che la scelta fa essere ciò che siamo, è anche vero che ciò che siamo rende possibile la nostra scelta” (p. 128). Queste sono proposizioni veramente MOI, cioè attualistiche, (neo)esistenzialiste, megariche e relativistiche. Esse introducono a una nuova concezione della persona di cui abbiamo più che mai bisogno in un tempo in cui la persona viene sistematicamente rimossa e sostituita – e qui di nuovo mi discosto dall’analisi che Manzotti fa del presente – non con la macchina che funziona ma con il soggetto astrattamente libero che può optare tra gli infiniti mondi possibili messigli a disposizione dall’immaginario tecnologico.