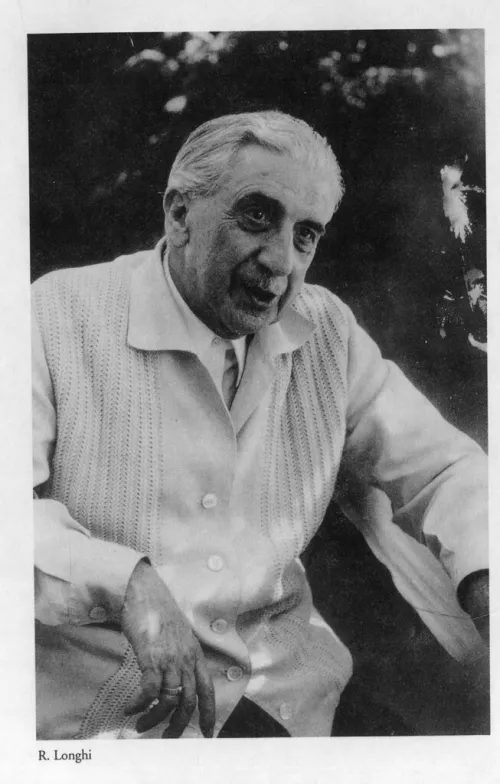Fortissimamente Longhi
Ho passato anni a inseguire, acquistare, leggere, raccogliere i 16 volumi (uno in due tomi) delle Opere complete di Roberto Longhi nella meravigliosa edizione Sansoni. Sono riuscito a ricomporre l’intero corpus, che è fra i più belli e importanti della nostra tradizione saggistica, non solo nel campo della storia dell’arte. Ho divorato la prosa longhiana avvolgendomi nelle sue pieghe, studiando questo “caso” di stile culturale di straordinaria eccezionalità, che Aldo Rossi ha definito «una dialettica di immedesimazione e distacco, cioè un’attitudine scientifica». Quando poi, nel 1996, Alberto Asor Rosa e Roberto Antonelli decisero di aprire il II volume della Letteratura italiana Einaudi dedicato alle grandi opere del Novecento con un saggio su Officina Ferrarese e mi proposero di occuparmene, accolsi la sfida con grande passione. Avevo a disposizione tutti i materiali necessari per riflettere sul Longhi “scrittore”, su quella sua prosa mai prima pensata, incommensurabile con qualsiasi altra espressione della ricerca storico-artistica (Berenson compreso), degnissima di essere goduta e valutata proprio in quanto scrittura. In particolare allo stile di Longhi mi applicai, dunque: ovvero alla continua tensione (che lui stesso ammise, nei Momenti della pittura bolognese con cui aprì l’insegnamento a Bologna nell’anno academico 1934-35), fra «il lavoro sul cammino della verità» e il «freno alle divinazioni qualche volta precipitevoli dell’attribuzionismo».
Nel 1973 era apparso un compatto volume dei Meridiani di Mondadori, subito divenuto a sua volta un classico alla seconda potenza: Roberto Longhi, Da Cimabue a Morandi. Saggi di storia della pittura italiana scelti e ordinati da Gianfranco Contini. La “seconda potenza” consisteva nell’associazione, in un solo libro, di una scelta idiosincratica ma pertinentissima compiuta dal nostro più grande filologo e critico letterario nell’opera completa di Longhi lungo una scalinata di sette secoli d’arte, e di una breve quanto intensa Antologia critica su Longhi scrittore, che connotava ulteriormente la lettura nella dimensione della creatività linguistica e stilistica, con studi di Emilio Cecchi, dello stesso Contini, di Giuseppe de Robertis e di Pier Vincenzo Mengaldo. Il volume si dichiarava esplicitamente dedicato al ruolo occupato da Longhi nel panorama della letteratura italiana: Longhi «scrittore», appunto.
Soprattutto Cecchi, già nel 1928, sulla «Fiera Letteraria» riconosceva che all’«arte […] dello scrittore» non era stato «concesso, in sede critica, sufficiente risalto», e abbozzava un’immagine mirabile per figurare quello stile contenente «qualche cosa sempre di scabro, di elementare e pungente»: «ricorderei le incrostazioni della salsedine e degli acidi marini che irritano e macchiano il cristallo della conchiglia più gentile di tinte». Quasi un trentennio più tardi (1955), divenuto ormai Longhi maestro riconosciuto, in un altro saggio nella stessa rivista (anch’esso antologizzato da Contini), Cecchi suggeriva «l’analisi chimica di tale stile, audace e sprezzante nel movimento, quanto laborioso e composito nella materia verbale», e riconosceva il nucleo più intimo della scrittura longhiana, quello che nei termini di Leo Spitzer avrebbe definito il suo «centro affettivo»: «A mio vedere, la sua forza più cruda e più specifica e rivelatrice, è dove egli s’impegna insieme al lettore in una sorta d’interna mimesi dell’opera d’arte; realizzando l’opera nell’organismo delle sensazioni liriche e dei segni che la costituiscono; vivendola, per dir così, nell’“interno della partitura”».
Nelle Note sul linguaggio critico di Roberto Longhi, del 1970, un linguista del valore di Pier Vincenzo Mengaldo invitava a ritrovare «legami piuttosto stretti e fecondi, sopra le spalle della critica accademica o attitrée, con la maniera ben più mossa, sprezzata e stilisticamente accesa di critici-letterati “dilettanti” (nel senso più alto) della tradizione ottocentesca, inglese (Ruskin, Pater ecc.), e soprattutto francese, da Baudelaire e Fromentin in giù»; e poi offriva, chiedendo cautela, specimina persuasivi circa la «relazione con D’Annunzio», e chiamava in causa Soffici e Cecchi «in un’esplorazione della genesi storica della prosa longhiana» (con Cecchi anche Contini sottolineava una «connivenza […] copiosa», una «partita stilistica di dare ed avere […] serrata», specie negli anni del Kipling e del Pascoli di Cecchi). Su una questione fondamentale gettava un fascio di luce Mengaldo, revocando in causa l’attributo generico di «vociano», e connotandolo storicamente attraverso il ricorso alla categoria di «espressionismo» (cioè la stessa con cui qualche anno prima, parlando di «espressività» e di «espressivismo», Contini aveva accompagnato l’apparizione in volume della Cognizione del dolore, spingendo Gadda all’autodifesa di auto-annessione al «barocco»).
La raccolta di saggi del 1973, che Contini aveva cesellato da solo come un orefice, dalla Prefazione alla scelta di Antologia critica su Longhi scrittore, alla Tavola ragionata dei capitoli e alla Nota bibliografica generale, propose in sostanza un omaggio personale del Grande Critico allo Scrittore capace di «equivalenze», o «trascrizioni», o «traduzioni», o «trasferimenti verbali» delle opere d’arte: «adempimento storico dell’esperienza figurativa pura, una sorta, si dirà più tardi in critica letteraria, e ad altro effetto, di correlativo oggettivo». Indimenticabile il sottilissimo riconoscimento di «una particolare morbidezza formale» («Tiziano, ape cromatica…»), da non «prendersi per sentimentale-immediata», bensì «in chiave letteraria (ungarettiana)». Ricorrendo all’antico lessico alchimistico, si coglie il desiderio di trasmutare la «materia pittorica» in «materia testuale», giungendo a «costituire linguisticamente il quadro» mediante una «necessaria pittoricità verbale» (le definizioni, perfette, sono di Ezio Raimondi). Insomma, a dirla con Longhi stesso, la scrittura è per lui la «risposta parlata alle opere d’arte».
Quanto all’arazzo Gadda-Longhi, i fili e i nodi colorati, insomma le liste dei debiti e dei crediti, attendono ancora d’essere ripercorsi al microscopio. Ad esempio, un sicuro, esplicito contatto con «l’insigne critico», e con le sue «magistrali note e pagine» di Officina Ferrarese, è ammesso da Gadda stesso, nelle note di Al parco, in una sera di maggio poi confluito nell’Adalgisa: «Era un cavallo araldico, uscito di mano a Cosmé Tura sullo sfondo della sua luce fulgente: lussuriante nei toni della porpora, del dorato arancio»; e nella direzione opposta, ancora nel saggio sul Caravaggio del 1952, sviluppato a partire dalla tesi di laurea discussa con Toesca nel 1911, Longhi ricorreva letteralmente alla descrizione che dei bravi offriva Gadda nell’Apologia manzoniana, del 1924-27: «Michelangiolo Amerighi veste da bravi i compagni di gioco di San Matteo». E le «incidenze lombarde della luce» impregnano sia le prime ricerche di Longhi, sia le pagine fondative della scrittura romanzesca di Gadda.
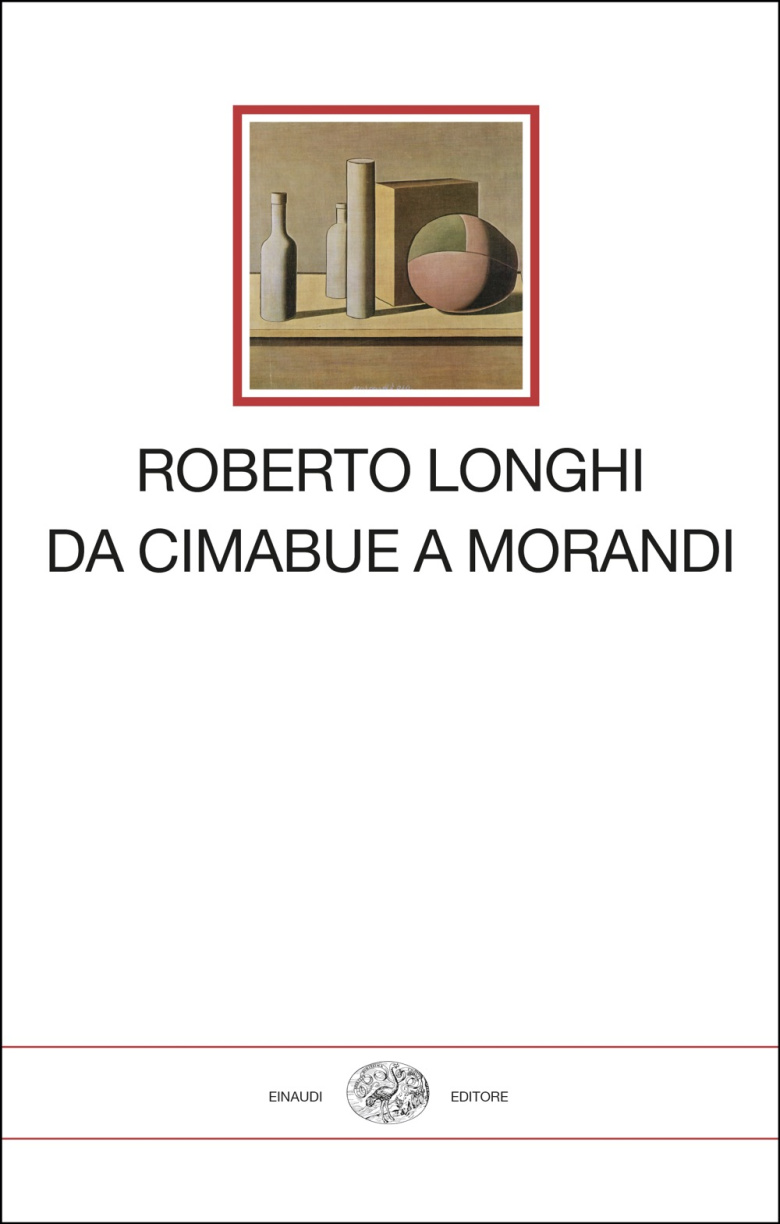
Il problema-chiave, posto da Longhi medesimo, consisteva nella sperimentazione di una prosa critico-artistica capace di dar corpo alla trasfigurazione verbale dell’opera d’arte; Longhi steso inventò la formula efficacissima «scriver pittore». «È un fissaggio, questa volta studiosamente operato nel laboratorio, dell’apprensione conoscitiva», scriveva Contini, insistendo sulla «portata gnoseologica dell’atto espressivo» nella critica longhiana. Il graffio della sua posizione lasciò una traccia profonda nella raccolta Da Cimabue a Morandi del 1973; l’ultima pagina che Contini scelse di allegare, fra le sue, nell’Antologia critica, traccia il profilo di un perfetto rispecchiamento fra Longhi e Gadda: «…il rivo metaforico sembra fluire più omogeneo e coerente, introduce il suo lirico stridore una dissonanza inopinata…».
Nell’antologia continiana del 1973 imparammo a conoscere il Longhi scrittore come compagno di viaggio dell’«espressivista» Gadda e dei «vociani» Cecchi e Bacchelli, e lo cogliemmo mentre “scropriva” Mattia Preti e Carlo Carrà, e il “suo” Caravaggio, e «Giotto spazioso» e Stefano fiorentino e Giusto di Padova, e per tutti loro trovava una «trascrizione» stilistico-verbale in grado di accamparsi nella memoria come un trionfo metaforico-visuale, quasi tattile, sensuale. Il lettore veniva sfidato, senza pause, a ripercorrere fulmineamente i labirinti associativi: «qui ancora si bizantineggia con aliossi di un sentimento numerato in un’indifferenza quasi fachirica» (Giudizio sul Duecento); «il senso dell’inquadratura “prospettica” che profondamente infenestra la serie francescana di Assisi» (Giotto spazioso); «e che ne è dei ciottoli sibilanti, scagliati dalla fionda di Giotto a Padova, in questi bozzoli dolenti degli angeli di Stefano impigliati come piume nella basa del vento?» (Stefano fiorentino)
Non si può, purtroppo, insistere nella scrematura. Al di là dell’effetto stilistico-visionario, tuttavia, si rivela come per Longhi ogni atto conoscitivo sia sempre un ri-conoscimento, e rappresenti la fulminea costituzione di un luogo mentale, nella specie di un reticolo di rapporti mnemonici fra le innumerevoli altre opere già viste e ri-vitalizzate nel confronto dialettico, volta per volta, quadro per quadro. Ogni punto, ogni luogo, viene ricondotto a tutti gli altri, entro un sistema fatto di scarti e di rapporti fondati sulla prossimità, fino a prendere il debito posto nella casella opportuna, risultata alla fine del “percorso” funzionale all’intera struttura di rapporti necessari: e non a caso, né solo secondo un principio casualmente associativo.
L’antologia continiana del 1973, quindi, aveva messo a disposizione, nella rigorosa calettatura cronologica dei pezzi, quest’immagine di un theatrum memoriae in cui non solo (secondo una bella formula di Garboli in Longhi lettore, del 1982) la «competitività ottica», che «lasciava traccia perfino nello sguardo di Longhi», è legata alla «facoltà di vedere più cose al presente», quasi in una «percezione multipla», peculiare del «filologo e conoscitore»: e «se era dotato di un’infallibile memoria di conoscitore, era perché sottraeva al tempo ciò che intanto andava iscrivendo nella storia».
Lascia stupefatti e ad un tempo conforta ritrovare, oggi, quell’ormai canonizzato Da Cimabue a Morandi splendidamente riedito da Einaudi fra I Millenni (pp. 1160, € 100), con gli stessi 45 saggi selezionati quarant’anni fa da Gianfranco Contini, ma in una transmutazione editoriale davvero alchemica, che ne fa un oggetto radicalmente nuovo, per le finalità e gli strumenti scientifici integrati. Scompaiono le pagine-viatico di Contini, di Cecchi, di De Robertis, di Mengaldo. Si salva invece la successione dei testi che Contini dislocò non nella cronologia della loro elaborazione, ma nella successione dei momenti artistici. E soprattutto, ogni saggio viene per così dire scorporato, e accompagnato da un paio di pagine firmate da uno specialista, in cui il testo di Longhi è storicizzato e proiettato verso il futuro per cogliere l’influenza che esercitò nella storia dell’arte, infine arricchito da una Nota bibliografica. Hanno preso la responsabilità complessiva di questa metamorfosi Cristina Acidini e Maria Cristina Bandera, e Lina Bolzoni ha scritto un elegante saggio introduttivo, sottilmente intitolato Longhi o il teatro della scrittura.
L’intrinseca energia teatrale rilevata già da Contini nella scrittura longhiana, su cui ho insistito fin qui, non solo non viene qui disattesa, ma anzi si rafforza nell’esibizione di ciò che davvero conta: questo libro è costruito come un Teatro della Memoria, proprio nel senso che alla formula si diede fra Cinque e Seicento, quando Giulio Camillo, amico di pittori e di letterati, ideò una geniale Casa della Sapienza (Lina Bolzoni ne è fra i più autorevoli conoscitori), che chiamò mens fenestrata e animus fabrefactus. Le operazioni mentali, fondate sul rapporto fra immagini e testi, erano intese in quel Teatro a «costruire un ordine totalizzante e “visibile”», dove attraverso le «finestre» mentali e la mutazione del proprio «animo» lo spettatore, al centro del palcoscenico, dispone intorno a sé i luoghi e le immagini, trasformando in spettacolo la propria mente in tutta la sua ricchezza: la mente umana capace di contenere / ricordare / ricreare l’intera realtà. Sulle gradinate del Teatro lo spettatore proietta dunque se stesso» (L. Bolzoni, nell’introduzione a L’Idea del theatro, Adelphi 2015).
Quella che Contini definiva «animazione antropomorfica impressa da Longhi alla realtà studiata» è riconosciuta dalla Bolzoni «nel cuore del modo in cui Longhi riscrive, narra, mette in scena le immagini e ce le vuole far vedere, così come le sente, le capisce, le rivive lui. L’efficacia di questo metodo in cui l’immaginazione produce il dialogo teatrale è rivendicata nei Fatti di Masolino e di Masaccio». L’ars memoriae di Longhi, proverbiale memorioso, come i teatri della memoria rinascimentali-barocchi diviene così una possente macchina ermeneutica capace di cogliere affinità, nessi, relazioni. Ed è formidabile riconoscere come le intuizioni di fondo di Contini, la larga arcata della sua selezione, anche se della sua operazione culturale resta lo scheletro, siano ora validate anche sul piano della vicenda storico-artistica a cui Longhi diede fondamento con la sua autorevolezza. Dopo il Longhi scrittore ci viene restituito un Longhi teatrale, ma soprattutto il mirabile profilo caleidoscopico del Longhi critico d’arte. Come ben sintetizza Cristina Acidini, Da Cimabue a Morandi si conferma un solido monumento in cui svettano «costruzioni incrollabili, attribuzioni definitivamente accolte, sistemazioni imprescindibili, intuizioni critiche destinate a radicarsi e a dar frutti copiosi e duraturi, compreso il motivo carsico e tuttavia vitale del dialogo tra l’antico e il contemporaneo».
Svanisce il Longhi di Contini, ma trasmutato per sempre nel Longhi nostro contemporaneo.
Leggi anche:
Simonetta Nicolini | Roberto Longhi creatore del proprio mito
Alessandra Sarchi | Roberto Longhi e Giuliano Briganti: l'importanza dei maestri
Alessandra sarchi | Con gli occhi di Artemisia