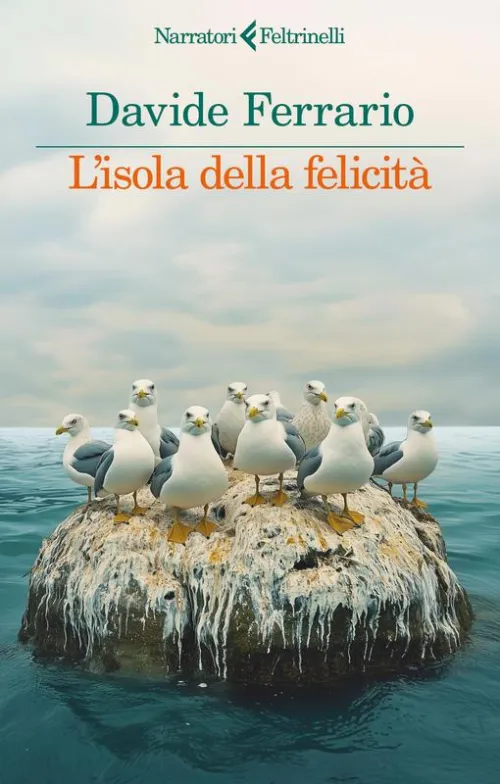Ferrario e il guano del demonio
Un’isola in mezzo all’oceano, lontana da tutto e da tutti, dove la vita scorre placida e naturale. Gli abitanti vanno a pesca, allevano un po’ di pollame, qualche maiale, coltivano la terra, ma tutto con parsimonia, entro i limiti dello stretto necessario, senza preoccupazioni di accumulo. L’esistenza scorre eguale e tranquilla; del resto, poiché siamo vicini all’Equatore, le stagioni si assomigliano. Non vi sono conflitti, né tabù; le consuetudini prevedono ampi margini di libertà e tolleranza. Esistono le famiglie, ma non i cognomi: le persone vengono chiamate con una perifrasi desunta da una loro caratteristica, come «Lui-che-si-gratta-spesso» (il padre del narratore) «Lei-che-parla-molto» (la madre), «Lui-che-sbadiglia» (uno zio menzionato a più riprese per le sue frequenti passeggiate nella foresta, dove con discrezione si consumano tutti gli incontri clandestini ed extra-coniugali). Poi arrivano gli stranieri, Quelli del Continente, e tutto cambia. In poco tempo gli isolani diventano ricchi: si abituano alle comodità, smettono di lavorare, si appassionano ai consumi, ingrassano. Il prezzo da pagare, nell’immediato, è la devastazione dell’ambiente. Nel medio termine, la catastrofe economica: quando lo sfruttamento delle risorse naturali cessa, Quelli del Continente se ne vanno, lasciando al proprio destino una comunità di obesi inetti nullafacenti, che per sopravvivere non arretreranno di fronte ai meno dignitosi compromessi. Nel lungo termine, l’esito sarà il totale dissolvimento di una comunità e delle sue memorie.
Questa, in sintesi, la storia narrata da Davide Ferrario in L’isola della felicità (Feltrinelli, 2025): un racconto-apologo di sapore swiftiano (da Swift è tratta la definizione della satira posta in epigrafe) che, al netto delle forzature grottesche, ripercorre una vicenda storicamente documentata: l’ascesa e la rovina di Nauru, minuscolo Stato della Micronesia, poco più di 21 kmq, circa 12000 abitanti (ne parla anche, in termini strettamente saggistici, il recente volume di Marco Lupis Ai confini del mondo. Storie di isole lontane, Il Mulino). All’origine di tutto c’è la scoperta, all’inizio del Novecento, di grandi giacimenti di fosfati (fondamentali per la produzione di fertilizzanti), creati da millenari depositi di guano, successivamente ricoperti da foreste. Lo sfruttamento di questa inopinata ricchezza mineraria comporta la distruzione del manto boschivo, una serie di effetti ambientali collaterali (dalla diffusione di sgradevoli miasmi alla cementificazione della costa), e lo sconvolgimento del modo tradizionale di vivere degli indigeni. I pochi abitanti, ora percettori di rendite che appaiono favolose (la loro quota è parte della somma forfettaria che il piccolo territorio incassa dalle società esterne), dimentichi del proprio passato, assimilano rapidamente lo stile di vita del mondo moderno, ma nelle sue forme più degradate. E quando i fosfati si esauriscono, si trovano d’improvviso senza risorse e senza prospettive: minati dall’assuefazione all’inerzia, dalla diffusa pinguedine, dal diabete. Qualche ingegnoso espediente, come la disinvolta trasformazione in paradiso fiscale o la vendita della cittadinanza – cioè la concessione indiscriminata di passaporti, dietro congruo pagamento, a stranieri desiderosi di camuffare la propria identità – dà qualche sollievo. Ma il dato di fondo è che l’irruzione nel microcosmo isolano di un’economia predatoria ha prodotto due perdite irreversibili, cioè la distruzione di una cultura e di un ecosistema.
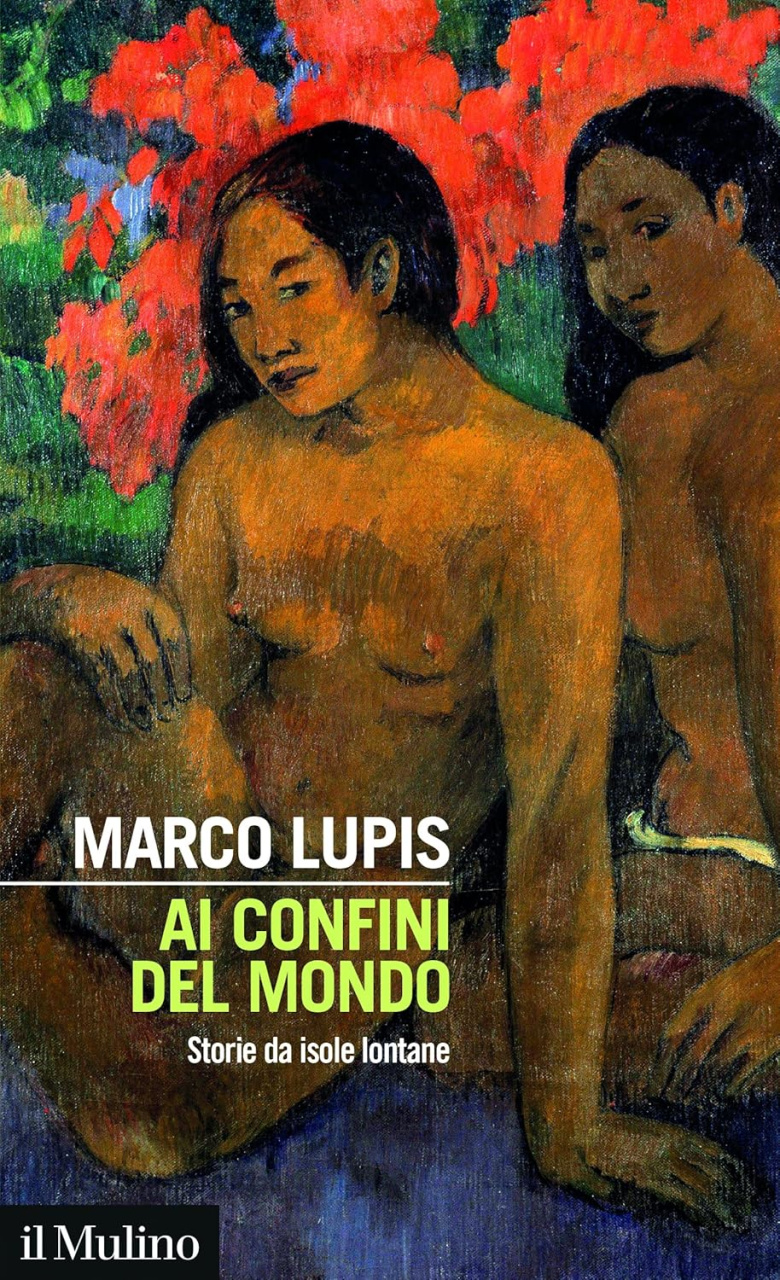
Davide Ferrario, regista e sceneggiatore, è noto fra gli appassionati di letteratura quanto tra i cinefili: a lui si deve infatti una serie di film-documentari dedicati a scrittori, quali La strada di Levi del 2007 e il recente Italo Calvino nelle città del 2024 (entrambi in collaborazione con Marco Belpoliti), senza dimenticare Mondonuovo (2003), dedicato a Gianni Celati, e Umberto Eco – La biblioteca del mondo (2022). A lui si devono però anche alcune sporadiche incursioni nella letteratura creativa, a partire dal romanzo dedicato a Orson Welles Dissolvenza al nero (Longanesi, 1994). L’isola della felicità è senza dubbio una prova convincente. Dopo una sorta di premessa in corsivo, titolata Guano (che forse non sarebbe stato improprio collocare alla fine del libro, anziché all’inizio), a prendere la parola è un nativo, chiamato «Lui-col-sorriso-stanco», che ha avuto modo di conoscere bene il Tempo di Prima. La sua testimonianza, come si può intuire dall’indole descritta dal nome, è lucida e pacata, amara ma immune da invettive o da impennate polemiche. Rende conto della reazione passiva e imbelle, e sostanzialmente fatalistica, che i suoi compatrioti hanno avuto di fronte a eventi inattesi, dei quali nessuno sembra mai in grado di misurare le conseguenze. Un popolo intero – modesto quanto a dimensioni, ma in origine coeso e omogeneo quanto pochi altri, anche in virtù dell’isolamento geografico – scivola gradualmente e inesorabilmente verso la rovina. Nessuno si oppone, non ci sono eroi; l’unica a mostrare un po’ di lucidità è la figlia del protagonista-narratore, che fin da bambina si pone domande sull’avvenire («E dopo?»).
Va sottolineato che, a dispetto del quadro idilliaco del Tempo di Prima, non troviamo molte concessioni al mito del buon selvaggio. Fra gli abitanti, non pochi sono coloro che cercano di trarre vantaggi personali dalle contingenze, a cominciare dai presidenti che si avvicendano alla guida dello Stato (uno Stato sovrano più piccolo di qualunque capoluogo di provincia). Per il resto, a frenare le spinte egoistiche non sono tanto qualità morali, quanto difetti, nuovi o atavici: l’inerzia, la pigrizia, la mancanza di fantasia e di spirito d’iniziativa, e a un certo punto anche l’eccesso di peso. A far funzionare l’economia – finché funziona – sono i Diversi (i cinesi). Ma quando tutto crolla, se ne andranno anche loro.
La storia dell’Isola della felicità, come sopra si diceva, è ispirata a eventi reali. Ma l’intonazione del racconto rimane opportunamente lontana dal realismo documentario. A prevalere è il suo carattere di parabola: anche se molti dettagli corrispondono alle vicende di Nauru – come la diffusione del diabete o la creazione d’una compagnia di bandiera che vola con gli apparecchi vuoti – va letta soprattutto come una favola esemplare, come un exemplum. Flagrante è il valore simbolico della (effimera) fonte di ricchezza: gli escrementi degli uccelli marini, inveramento letterale della celebre definizione del denaro come sterco del demonio (pecunia, stercus diaboli) attribuita a uno dei padri cappadoci, San Basilio Magno. Ma forse l’aspetto più inquietante di questa caustica parabola è la rapida perdita della memoria collettiva, tanto radicale quanto inavvertita. Dopo che la rovina – loro, e della loro isola – si è consumata, gli abitanti si rendono conto di non aver conservato ricordi del Tempo di Prima: né oggetti allora in uso, né storie, miti o leggende. Il passato non è in alcun modo recuperabile: il miraggio della ricchezza non ha solo danneggiato lo spazio, deturpando l’ambiente naturale, ha anche prodotto una frattura temporale, scavando una voragine alle spalle di un insulso, avvilito presente.
Non a caso, la conclusione – in corsivo, come l’introduzione – è affidata alla voce di Ibobo, l’unico dio un tempo riconosciuto dalla popolazione dell’isola, prima d’una superficialissima cristianizzazione. Secondo la tradizione, Ibobo era ritenuto responsabile di tutte le disgrazie, piccole o grandi, che potevano accadere: il suo ruolo era quello di fungere da ricettacolo di ingiurie, proteste, imprecazioni, recriminazioni. Nella favola, anch’egli è destinato a scomparire: sopravvivrà giusto fino a che l’ultimo uomo o l’ultima donna pronuncerà il suo nome, come un inutile e mal inteso insulto, prima del silenzio definitivo.