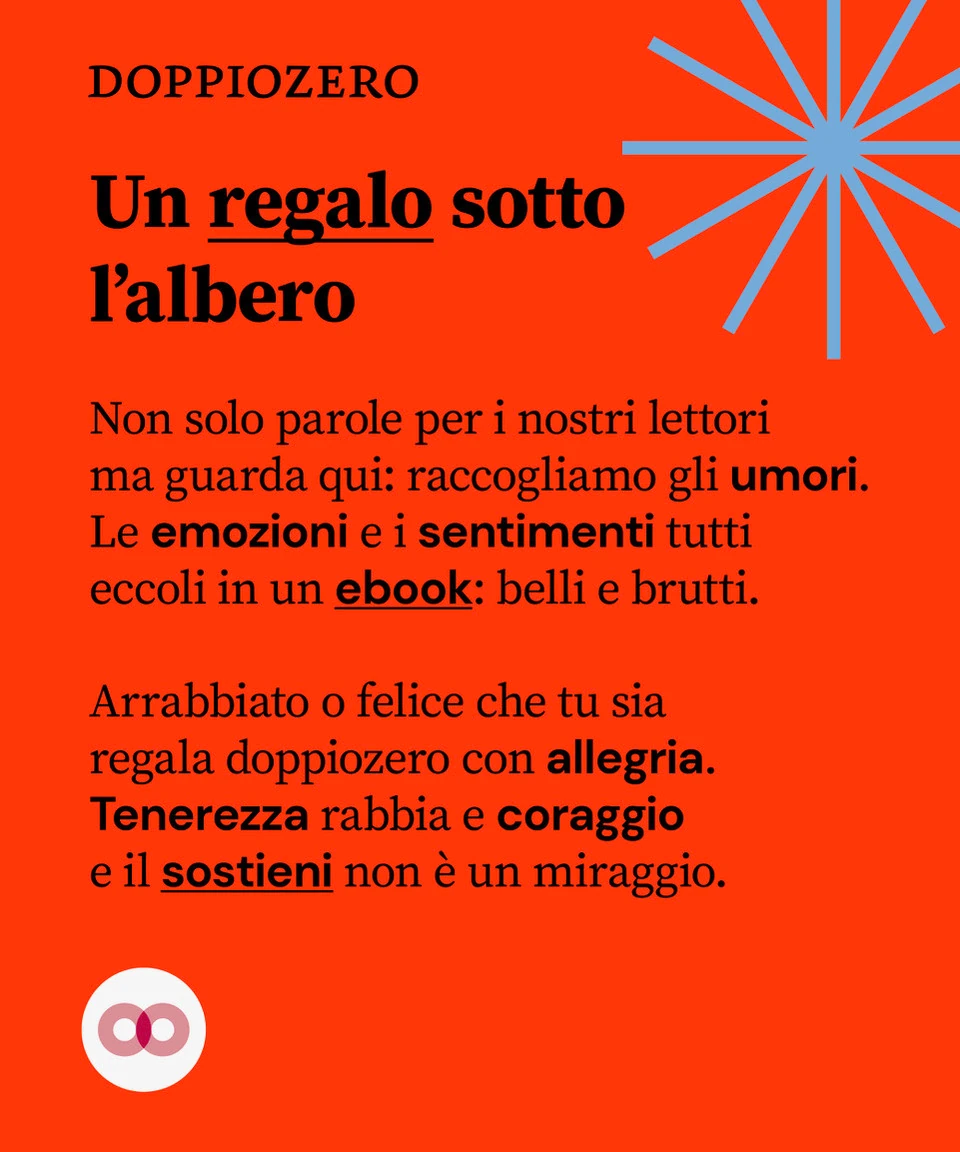Claudio Magris: l’Europa dei diritti
A pochi giorni dalle elezioni francesi che hanno visto l’avanzata del Front National di Marine Le Pen, abbiamo incontrato Claudio Magris. Le elezioni europee sono alle porte e l’ondata populista sta attraversando il continente. Una vittoria dei populismi potrebbe aprire inedite politiche conservatrici di matrice antieuropea. Abbiamo chiesto a Claudio Magris quali sono i segni su cui deve poggiare un’idea d’Europa aperta e condivisa.
Europa sembra sempre più un termine generico,capace solo di evocare restrizioni economiche e burocrazia. Qual è per lei il senso più profondo di questa parola? Cosa le evoca e cosa dovrebbe a suo parere rappresentare?
Con l’Europa, succede quello che succedeva a S. Agostino col tempo: quando non si chiede cosa sia, si sa cos’è, ma quando lo si domanda, non lo si sa più. Se per Europa s’intende non solo un’espressione geografica o un progetto politico, bensì una civiltà, un modo di essere, un’appartenenza culturale, un’affinità tra i suoi abitanti aldilà delle frontiere, è difficile e forse pure retorico e inutile discuterne. Si può vivere questo senso di appartenenza, di sentirsi a casa – almeno parzialmente – anche al di fuori del proprio Stato o della propria lingua, così come si vive l’amore per un paesaggio o per una persona, oppure lo si può raccontare, farlo sentire, ma in modo indiretto, come fa la letteratura.
Si può – si deve – parlare dei problemi concreti che ha oggi l’Europa, di ciò che favorisce oppure ostacola il processo di una sua reale unificazione, delle possibilità o difficoltà di arrivare un giorno, come io spero – malgrado l’attuale gravissima crisi – a un vero e proprio Stato europeo. Si può – si deve – parlare dell’euro, della disoccupazione, dell’immigrazione e della necessità di leggi comuni a tutti i Paesi.
Particolarmente in queste settimane, nel crescendo di disagi, pericolosi movimenti di rifiuto, allarmi ora più ora meno documentati sulla crisi economica, denunce di elefantiasi burocratiche, l’unico discorso serio sarebbe un’analisi precisa delle strutture, degli organismi, delle leggi e delle regole che tengono insieme l’Unione Europea e che sembrano traballare, cercando di capire cosa va eliminato senza paura, cosa va difeso e così via.
L’identità europea può nascere dalla fusione o dal riconoscimento delle innumerevoli identità locali che la compongono?
Occorre certo riconoscere la molteplicità delle identità che compongono l’Europa, senza fonderle in un’amalgama che le cancelli, ma vedendole come elementi organici di una stessa realtà superiore che le costituisce e che esse costituiscono, come diversi rami dello stesso albero.
Quale è a suo parere la radice culturale più profonda e unificante dell’Europa?
È arduo e rischioso, spesso arbitrario, voler definire la cultura europea. Forse se ne possono tracciare alcune linee fondanti. A differenza di altre grandi civiltà, altrettanto fondamentali per la storia dell’umanità, l’Europa, sin dalle sue origini, ha posto l’accento non sulla totalità (statale, politica, filosofica, religiosa) bensì sull’individuo e sul valore universale di alcuni suoi diritti inalienabili. Dalla democrazia della Polis greca al pensiero stoico e cristiano col suo concetto di persona, dal diritto romano con la sua tutela concreta dell’individuo all’umanesimo che ne fa la misura delle cose, dal liberalismo che proclama le intoccabili libertà al socialismo che si preoccupa del loro esercizio concreto e delle possibilità di vivere una vita dignitosa, il protagonista della civiltà europea è l’individuo, che la letteratura e l’arte raffigurano nella sua irripetibile e inesauribile complessità, che Kant proclama essere un fine e mai un mezzo.
La civiltà europea contiene un grande potenziale antitotalitario ed è stata la “culla dei diritti umani” universalmente validi per tutti gli uomini, di princìpi universali che trascendono ogni orizzonte storicamente limitato e dunque pure l’orizzonte europeo e gli interessi dell’Europa. Antigone afferma le “leggi non scritte degli dèi” che nessuna legge positiva dello Stato può violare; di qui si arriverà, in un lungo e contorto processo, agli inalienabili diritti di tutti gli uomini, proclamati dalla costituzione americana del 1776 e da quella francese del 1792, sino ai diritti civili che comprendono pure la “disobbedienza civile” , formulata da Thoreau, nei riguardi dello Stato quando esso violi quei diritti la cui estensione è tuttora in corso, anche se contraddetta da tante situazioni di barbarie.

Questa universalità è il contributo fondamentale della civiltà europea, anche se gli Stati europei sono stati i primi a violare questi principi da loro stessi proclamati; si pensi – ma sono solo pochi esempi fra i molti – al colonialismo, alla depredazione e distruzione di tante altre civiltà e culture, a quell’”olocausto degli olocausti “ come è stata chiamata la tratta degli schiavi, alle innominabili condizioni di lavoro e di miseria imposte a milioni di uomini privati di ogni dignità, ai genocidi compiuti in nome di ideologie, prodotto squisitamente europeo; alla Shoah, culmine insuperato dell’atrocità. Non c’è Stato europeo che non abbia i suoi scheletri nell’armadio, ora più ora meno numerosi, ma la condanna morale dei crimini dell’Europa nasce da quei principi universali – e da quelle regole politiche e giuridiche che li tutelano – elaborati non solo, ma in misura eminente dalla civiltà europea.
C’è inoltre un modo squisitamente europeo di concepire il rapporto fra l’individuo e la società, ossia gli altri. Sin da Aristotele, l’individuo è concepito come “zoon politikon”, animale politico; cittadino della Polis, della comunità, che esiste in rapporto con gli altri, diversamente dalla concezione anarco-capitalista-ultrà, così enfatizzata negli ultimi anni dal pensiero anglosassone e oggi in crisi. Essere animale politico significa rifiutare ogni livellamento collettivo, ma sentire di vivere nel rapporto con gli altri; significa sapere che la qualità della nostra vita comprende quella di chi vive intorno a noi, del mondo in cui viviamo; significa sentirsi partecipi di un comune destino. Non si tratta di buoni sentimenti caritatevoli, ma del senso concreto del proprio benessere, che si estende aldilà della nostra immediata persona.
Anni fa, un vecchio imprenditore triestino, partito poverissimo e divenuto imperatore del caffè, uno dei maggiori contribuenti italiani, si dichiarava soddisfatto di pagare molte tasse perché, per il suo stesso interesse e benessere, voleva vivere in un Paese civile, in cui la sanità, i servizi sociali, le autostrade, la scuola, la sicurezza funzionino. In questo senso il welfare state è un’istituzione profondamente europea, che va corretta nei suoi abusi e nei suoi sprechi ma salvata nella sua essenza, quel senso del legame tra gli uomini e le generazioni che è l’autentico umanesimo.
Lei stesso ha più volte detto che ha in un certo senso ha riscoperto Trieste dopo esserci tornato dopo gli anni trascorsi a Torino. Cosa è per lei il concetto di distanza, oggi in cui l’immediatezza è quasi un valore assoluto?
Proprio per questo la capacità di prendere distanza è più che mai necessaria per capire il mondo e noi stessi. Distanza non significa freddezza, anzi, al contrario, è il modo necessario per poter amare veramente e non visceralmente, per comprendere le realtà e noi stessi.
I territori mutano in continuazione e sempre più velocemente, è ancora possibile raccontare luoghi che sempre più sembrano sfuggire ad un’identità definita?
La vita consiste proprio nella sua trasformazione; è questa la sua creatività, non la mortale e mummificata mobilità. Questo riguarda i luoghi, le persone, le storie.
Nel suo ultimo libro pubblicato da Bompiani, Segreti e no, lei ricorda come non possa esistere un uomo di potere senza segreti. Oggi anche il cosiddetto uomo della strada è spesso anche uomo pubblico attraverso i social network e la rete. Il segreto si sta trasformando in una forma di finzione? Il segreto è sostituito dalla menzogna?
Il problema è che da un lato sembra che non ci sia più non solo segreto ma nemmeno intimità personale e che dall’altro tutto è segreto e fantomatico. Nonostante i raffinatissimi strumenti di informazione sappiamo sempre meno cosa succede nel mondo.
Lei scrive spesso nei caffè e quindi in mezzo alle persone. Isolarsi tra la folla è il luogo della scrittura o ne è il segreto?
È semplicemente un’abitudine, un piacere. Come ho detto più volte, fa bene, quando si è nella solitudine dello scrivere e si corre il pericolo di darle chissà quali significati, vedere intorno a sé gente che se n’infischia.
In questi anni gli studi umanistici sembrano essere messi in secondo piano rispetto ad altre discipline; quanto rischiamo di perdere da questa subalternità?
È gravissima la crisi di studi umanistici, perché essi insegnano a comprendere come sono fatti gli uomini e dunque il mondo. Ma è ancora più grave la sparizione di memoria storica, che ci toglie il terreno sotto i piedi. In un recente quiz televisivo, come ricordava Umberto Eco, non poche persone, per lo più giovani ma non giovanissime, credevano che Mussolini fosse ancora vivo alla fine degli anni ’80 o ’90. Per quel che riguarda gli studi umanistici, l’ingiustizia che essi subiscono è il dantesco contrappasso alla spocchia con cui, sino a decenni fa, si guardava alla cultura scientifica dall’alto in basso, come se fosse qualcosa di meno importante. Il latino non è meno ma neanche più espressione di conoscenza e cultura della meccanica quantistica.
La mancanza di visioni e prospettive sociali e pubbliche di oggi (che hanno invece contraddistinto il Novecento nel bene e spesso nel male) quanto rischia di ridurre e appiattire la vita personale e intima di ognuno di noi?
La mancanza di progetti per il futuro, di idee e speranze su come migliorare il mondo è un fatto gravissimo, che coinvolge sia la collettività sia il singolo individuo, la cui vita personale è compenetrata da quella generale.
La letteratura è una possibilità di salvezza?
La letteratura è una possibilità di salvezza, se intesa e praticata umanamente e non feticisticamente idolatrata. Di per sé, non è né più né meno ricca di possibilità salvifiche di ogni altra manifestazione creativa e critica dell’uomo. Un letterato assorbito ciecamente dal meccanismo della produzione di testi, presentazioni, recensioni, premi e così via, non è diverso dall’operaio disumanizzato dalla catena di montaggio descritto nel famoso film di Chaplin.
Questa intervista è apparsa in forma ridotta su L'Eco di Bergamo