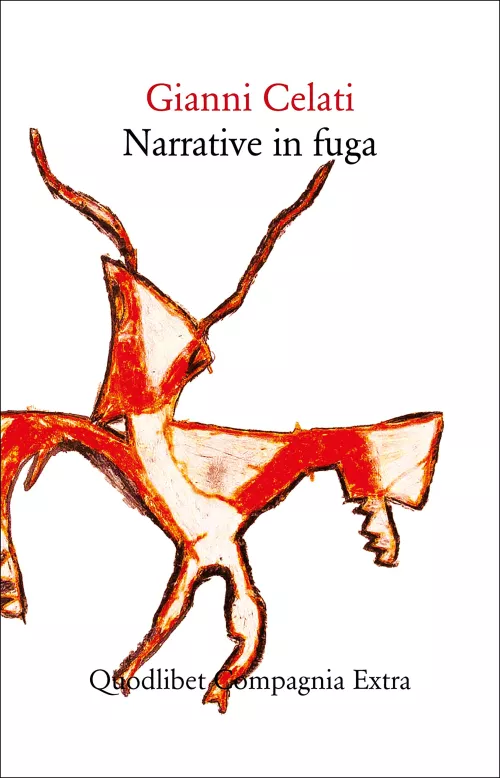Celati, saggista in fuga
Grande narratore, Gianni Celati è stato anche uno straordinario studioso e traduttore. Nella sua opera il narrare, il tradurre e gli studi sono connessi e si nutrono a vicenda. Ai tempi del Semplice (la rivista che con Daniele Benati, Ermanno Cavazzoni e altri facevamo a metà degli anni Novanta del secolo scorso), Celati aveva proposto una traduzione collettiva di Altrove di Henri Michaux (lavoro che poi abbiamo poi fatto assieme, Celati e io, per l’editore Quodlibet), come esercizio di scrittura, e accordamento (in senso musicale) con quel modo di scrivere così antiletterario. E, altro esempio, è sufficiente consultare l’enorme massa dei suoi taccuini di appunti e note sparse, ora conservati nel fondo Celati alla biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, per rendersi conto di quanto la lettura e lo studio di un filosofo come Wittgenstein, il corso universitario e la successiva cura e traduzione del racconto Bartleby lo scrivano (Feltrinelli, 1991) di Herman Melville, abbiano impregnato la sua narrativa della seconda metà degli anni Ottanta, soprattutto le Quattro novelle sulle apparenze (Feltrinelli, 1989).
In ogni caso, i lavori di traduzione e gli studi lo hanno occupato per lunghi periodi della sua vita; e credo che l’applicazione con cui vi si dedicava quotidianamente, con orari regolari, come quelli di un impiegato alle poste, l’aiutasse a placare l’ansia del “dover essere” scrittore, del sentirsi nel vuoto per il fatto di non essere risucchiato da qualche storia da raccontare. Di fatto, Celati ha mantenuto per tutta la vita un atteggiamento da studioso (per certi versi, da studente), curando, traducendo e studiando gli autori che gli erano più cari.
Così, all’inizio degli anni Duemila, Celati voleva raccogliere questi suoi scritti col titolo Studi d’affezione. La raccolta era composta da quattro sezioni, secondo la nazionalità degli autori (Americani, Francesi, Irlandesi, Italiani), e avrebbe dovuto uscire presso la casa editrice Feltrinelli intorno al 2005. Nel frattempo, ne aveva cambiato il titolo con Narrative in fuga; ma per qualche motivo il libro non è stato pubblicato, forse perché ritenuto poco vendibile.
L’editoria italiana di quegli anni, “con gli esperti di marketing che smerciavano i libri come fossero saponette” (parole di Celati, che a costoro ha dedicato varie invettive), ma anche il fatto che molti autori e libri che ci piacevano non fossero pubblicati o sparissero presto dalle librerie, ci aveva fatto pensare (a Celati, a Ermanno Cavazzoni e a me) di mettere su una piccola casa editrice. Idea che poi è confluita nel 2008 nella collana Compagnia Extra, presso l’editore Quodlibet (il nome della collana è dello stesso Celati). È stato in quel momento che Celati ci ha consegnato il pacco con Narrative in fuga, da pubblicarsi nella collana negli anni a venire. Di comune accordo con Celati, Cavazzoni e io, curatori della collana, abbiamo deciso di dividere la raccolta in due libri: prima i saggi sugli autori italiani, che erano l’ultima e più ampia sezione, con il titolo Studi d’affezione per amici e altri (2016), poi Narrative in fuga (2019), con le tre restanti sezioni dedicate agli autori stranieri.
Quelli di Narrative in fuga sono tutti testi pubblicati come introduzioni, presentazioni o postfazioni su autori stranieri cari a Celati, e in gran parte da lui tradotti; in un arco di tempo che va dal 1979 (l’introduzione alle Avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain) al 2013 (la prefazione alla sua traduzione dell’Ulisse di James Joyce, che è di fatto l’ultimo suo lavoro, sullo stesso autore a cui aveva dedicato la tesi di laurea): il Melville di Bartleby lo scrivano (che, va ricordato, proprio a Celati deve la sua divulgazione in Italia, con la sua pubblicazione per la prima volta non in una raccolta di racconti), l’amatissima Certosa di Parma di Stendhal, il Gulliver di Swift, e altri. Rispetto alle versioni stampate, tutti i saggi consegnatici nel 2008 erano stati rivisti e in diversa misura rimaneggiati; talvolta si trattava di una vera e propria riscrittura.
Libro che riflette un vasto sapere, con preziose riflessioni sulla lingua, problemi inerenti al tradurre, illuminanti analisi sociologiche (sulla società americana, per esempio), ma anche intuizioni poetiche sul nostro stare al mondo, Narrative in fuga contiene sempre un riferimento continuo a sé, al proprio scrivere, alla propria vita, mi verrebbe da dire. Sono anche, come ha detto una volta Daniele Benati, una riflessione sugli altri a partire dai propri limiti. Questa implicazione personale è ciò che spesso rende particolarmente interessanti gli scritti sulla letteratura degli scrittori rispetto alla critica o ai saggi universitari (i quali, affrontando “scientificamente” l’oggetto letterario, possono parlare indifferentemente di tutto, senza questa implicazione personale, che è affettiva e conoscitiva al tempo stesso).
Ma c’è un’altra questione che rende questi saggi così emozionanti e belli da leggere. Riguarda il tono in cui sono scritti, che è quello di qualcuno che ti mette a tuo agio raccontandoti una storia. I saggi di Finzioni occidentali (Einaudi, 1975) nascevano da studi universitari e, pur nella loro “natura puramente affettiva”, rispettavano la forma del saggio accademico, anche se con una particolare attenzione alla leggibilità (la scelta di non mettere note a piè di pagina, per esempio). Eppure lo stesso Celati, rileggendosi a venticinque anni dalla prima pubblicazione, nella premessa alla terza edizione parla di “pedanteria delle infinite citazioni”, come “esibizione di letture erudite”, a sostegno delle proprie tesi. Ecco, qui arriviamo alla questione del “saggio narrativo” in Celati; che non va preso soltanto in senso generico, per la ricchezza di esempi, storie e immagini con cui si espongono delle idee o si spiegano le cose. E non dipende solo dalla diversa occasione, questa volta non più accademica, in cui sono stati scritti. Riguarda una certa postura e un tono da ricercare nella propria scrittura saggistica.

C’è un magnifico saggio di Celati del 1996 (ora pubblicato in “Riga”, 2019), dal titolo Le posizioni narrative rispetto all’altro, che riguarda la tendenza del romanzo moderno a trattare il lettore come un estraneo (Celati rilevava che questo ha il suo corrispettivo nella vita urbana, dove le persone si passano accanto ignorandosi, a differenza della vita campagnola con i suoi rituali di saluto). La letteratura moderna, così come i giornali, si rivolge a un pubblico indistinto, “amorfo e indifferenziato”; e quindi ha abolito i cerimoniali del narrare antico, che portava con sé le tracce della narrazione orale in presenza di altri. L’eliminazione dell’altro (immaginario o reale, non importa) secca la linfa del linguaggio, ciò che infonde un tono alla lingua. Perché la sorgente del tono da trovare, quando raccontiamo una storia, è proprio l’altro a cui la raccontiamo. Così come “l’altro a cui parlo è… la sorgente del mio parlare”. Abolire questo equivale ad abolire qualsiasi connivenza di tipo immaginativo col lettore, dice Celati, che viene così sostituito da una “massa indistinta da persuadere”.
Questa massa amorfa, il cosiddetto pubblico della letteratura industriale, non è più qualcuno con cui collabori immaginativamente, un amico a cui racconti una storia, ma un “giudice” che incombe su chi scrive, un principio di autorità cui devi dimostrare di avere le “carte in regola”. Ecco quindi “le spiegazioni, le definizioni fisse o le frasi fatte”. E l’unico modo per venirne fuori, dice Celati citando Nietzsche, è “assumere l’altro dentro di sé” (con amore o con odio, non importa), cioè dargli un posto nelle nostre emozioni, “sottraendolo a quella posizione frontale che è quella di un giudice”.
Qui mi viene in mente che una volta, tanti anni fa, dicevo a Celati delle difficoltà che avevo nel trovare il tono mentre tentavo di scrivere un raccontino, allora lui mi ha detto: “Mettilo giù come se lo raccontassi a tua sorella!”. Mossa che a me fa pensare, per analogia, a quello che fanno talvolta i bambini di fronte a un estraneo che incute loro paura: corrono ad abbracciarlo. Il che è un po’ come pensare di raccontare una storia alla sorella mentre si scrive. Ma questo Altro, però, potrebbe essere anche qualcuno che odiamo; come succede, per esempio, nell’invettiva, il cui tono trova la linfa proprio in questo odio (peraltro, proprio all’arte dell’invettiva, Celati ha dedicato un bellissimo saggio alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, dal titolo Manifesto dell’invettiva, ora ripubblicato in “Nuova Tèchne”, n. 30, 2022).
Così, mentre il moderno romanzo industriale è andato sempre più verso la critica o la saggistica, con le sue spiegazioni, il tono impersonale, l’oggettività, eccetera, Celati ha cercato nella scrittura saggistica una via che andasse nel senso opposto, verso la narrazione, con la postura di chi racconta qualcosa a qualcuno, senza metterlo in quella posizione di sudditanza che di solito generano le spiegazioni.
Il che si traduce col non dover più mostrare di avere le cosiddette “carte in regola”: quindi niente inutili sfoggi di erudizione, niente citazioni (semmai riportate in forma di discorso indiretto, come si fa quando si racconta); niente più tirate ideologiche e toni assertivi nel dire le cose come fossero verità definitive; nessun irrigidimento teorico e frasari da esperti; piuttosto, un modo di sviluppare il pensiero tramite immagini e figurazioni concrete.
I continui rimaneggiamenti nel corso del tempo di questi saggi (ma è più giusto chiamarli studi, proprio per la loro implicazione affettiva), di cui mi sono reso conto curando il libro, mi sembra vadano nel senso di questa ricerca di un tono sempre più narrativo; di una fluidità e mobilità del discorso, come nelle narrazioni, che in quanto tali sono sempre nella dimensione del tempo. Perché qualsiasi forma di discorso o narrazione, se conserva la dimensione dell'altro da noi, è mobile nel tempo, dice Celati. Cosa evidente nell’estro dei veri narratori orali, che cambiano e adattano le loro storie a seconda dei momenti e dell’uditorio. La narrazione è sempre nella fluidità del tempo, al contrario della pretesa oggettività scientifica, che mira ad abolirlo. E così il confine netto che separa la narrativa dalla saggistica, in questa sua ricerca, si fa sfumato. Perché, sue parole, “le narrazioni che ci danno sollievo” non sono “spiegazioni del mondo né prodotti per un pubblico in generale, e tantomeno roba per gli uomini di cultura, ma un modo immaginativo di parlarsi in circolo e in amicizia… perché l’altro mi ispira… e il rapporto con l’altro non può essere una relazione fissa, non può essere determinato da regole forti e definitive, ma è qualcosa come una variazione affettiva inarrestabile”.
Alla fine è come se Celati ci dicesse che non è possibile nessuna intensità (ciò che più conta nello scrivere e nel tradurre, diceva Gianni) senza questo fatto affettivo; sia verso l’oggetto dei nostri racconti o dei nostri studi, che verso colui (immaginario o reale) cui ci rivolgiamo. Sarebbe bello che anche questa parte della sua opera ottenesse la stessa giusta consacrazione della sua narrativa.
Questo testo, che pubblichiamo per gentile concessione dell’autore, è una ripresa di quello pronunciato nel corso della tavola rotonda Homage to Gianni Celati, tenutasi a Londra il 27 aprile 2022 presso l’Istituto Italiano di Cultura.