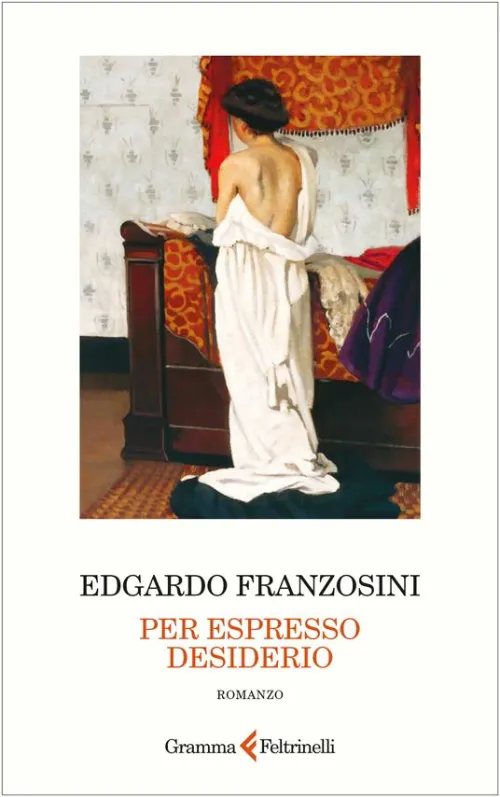Léautaud, o dell'incesto immaginario
Alle origini del nuovo romanzo di Edgardo Franzosini (Per espresso desiderio, Feltrinelli, 2025) – narrazione fondata, com’è nel suo stile, su un fatto reale: il singolare, morboso rapporto tra Paul Léautaud e la madre – sta un articolo apparso il 12 agosto 2018 su «Repubblica». Il titolo Jeanne, che fu l’ossessione di suo figlio era collocato su un occhiello che testualmente recitava: «Il poeta Léautaud era nato da una relazione clandestina tra l’aspirante attrice Forestier e un suggeritore della Comédie Française. Vide sua madre solo quattro volte. Ma coltivò per lei un amore impossibile e folle». Era insomma, già nel suo germe primitivo, un’idea buona per costruire un romanzo, cosa che l’autore ha fatto (e il filologo si chiede: abbandonò all’epoca il soggetto e l’ha poi ripescato di recente?). In ogni caso, l’articolo anticipava il fulcro della questione e, come agile premessa alla presente ideazione di Franzosini, è sufficiente rileggerlo. E qui la fortuna aiuta gli audaci, o per meglio dire i cartomani: sono tra coloro che ancora raccolgono e mettono in ordine – con indici e cartelline – i propri ritagli, il che, se è cosa mattoide, torna però utile.
La madre per cui «coltivò un amore impossibile e folle» era Jeanne Forestier, nata a Parigi nel 1852 da modesta famiglia borghese. Aveva sedici anni quando, una domenica, andò a trovare la sorella che viveva con l’ex attore Firmin Léautaud, uomo sensuale che si vantava di poter conquistare i favori di ogni donna. E poiché s’era fatta sera, quella domenica invitò Jeanne a restare: c’era in casa un solo letto, ma potevano agevolmente dormirci in tre... Cominciò così la “storia” che portò, nel gennaio 1872, al parto di Paul Léautaud, presto abbandonato da una madre che rincorreva la vocazione di attrice di operette.
Il piccolo ebbe poi modo di rivederla solo fuggevolmente. Una volta Jeanne era di passaggio a Parigi e alloggiava in un albergo: meno che adolescente, Paul andò a trovarla. Lei era ancora a letto con i capelli sciolti, il collo nudo, la camicia da notte aperta sul seno, e gli diceva di non avere timore, di avvicinarsi... Scrisse poi Paul: «Ho sentito contro la guancia la dolcezza dei suoi seni che tremavano mentre mi baciava». E lo scrisse appunto in una di quelle migliaia di pagine che formano l’immenso diario stilato in vita, quotidianamente, per sessant’anni (non comunque il più grande della letteratura francese: attorno alle 6.500 pagine soltanto, là dove quello di Henri-Frédéric Amiel toccava in origine le 17.000 manoscritte).
Si rividero a inizio Novecento a Calais, in casa della nonna: Jeanne aveva lasciato le scene e s’era sposata a Ginevra con un medico da cui aveva avuto due figli. Ed ecco il fulcro su cui s’impernia il nostro romanzo: all’inizio faticarono a riconoscersi, o finsero, ma poi si abbracciarono con calore e, nei tre giorni che passarono insieme, scoccarono baci che non sembrarono a Jeanne quelli che un trentenne doveva a una madre, ma qualcosa di più tenero, o forse di più ardente. Paul avrebbe poi nutrito un cruccio, quello che Franzosini espone al centro del racconto: «Il rammarico per essere stato tanto sciocco, tanto ingenuo, tanto stupidamente arrendevole quella sera davanti ai suoi “No”, mentre lei si spogliava e si preparava per la notte, lo angustiò a lungo. Per cercare di consolarsi di quella che considerò sempre un’occasione perduta, dava la colpa al suo carattere [...] troppo timido, troppo sensibile!».
«Un’occasione perduta» è un’affermazione che, rispetto a una madre, sollecita l’attenzione: ecco «un bel romanzo d’amore», come Jeanne chiamò quei giorni, dopo i quali madre e figlio non si videro più, ma si scrissero lettere, tante. Jeanne scomparve nel 1916 ma Paul non scordò mai i giorni di Calais e incontrò spesso la madre in sogno. Il 25 agosto 1937 annotò: «La notte scorsa mi trovavo con mia madre, tale quale l’avevo rivista a Calais... Dopo cena, l’amore, nel modo più vivo, da parte sua e mia, con lo stesso reciproco ardore. Lei era completamente nuda, il viso acceso dal piacere. L’ho comunque posseduta – in sogno!». Insomma: l’incesto ci fu, anche se onirico, e basta questo a fare del romanzo di Franzosini – molto documentato e molto narrato al contempo – una lettura seducente e, perché no, anche provocante.

Dovrei fermarmi qui, se non fosse che prima di dispormi a scrivere ho posto all’autore – con una amichevole elettro-letterina – un paio di questioni, le cui risposte credo possano destare interesse. Alla domanda «Cosa trovi di seducente nella figura di un letterato malconcio (sul piano fisico) come Paul?», Franzosini ha delineato un bel quadretto sinottico sulla personalità del letterato francese:
Cosa mi affascina in Léautaud? Ti faccio un elenco: il suo spirito libero e indipendente. La sua vita sregolata e povera. La carica libertina dei suoi comportamenti, e quella anticonformista e capricciosa delle sue opinioni. Il fatto che abbia vissuto solo per scrivere (chi scrive – diceva – vive due volte) sacrificando al piacere di scrivere («cosa voglio, come voglio, quando voglio») ogni altra cosa, senza preoccuparsi del possibile guadagno o della facile reputazione; senza per questo nascondere a sé stesso che, in fondo, la letteratura non era che una follia, una malattia, un delirio dalla quale un uomo sano non poteva che tenersi, giustamente, alla larga. La sua condizione di isolato. Il suo essere scontroso e insofferente. Il suo gusto per le malignità e per le oscenità. Le sue improvvise e commoventi tenerezze. Il suo amore per la solitudine e il silenzio. Il suo animo egoista e cinico. La sua feroce sincerità nel giudicare e nel giudicarsi. Il coraggio di trovarsi ridicolo. La sua attrazione per le sgradevolezze.
E alla domanda (interessata) «Con quale pazienza hai affrontato le migliaia di prolisse pagine del suo diario (che io pure possiedo)?», Franzosini ha risposto:
Alle migliaia di pagine del suo Journal (il manoscritto occupava circa un metro quadro del suo misero e disadorno villino alla periferia di Parigi) mi sono avvicinato con l’idea di restituire, o di ricreare con sufficiente coerenza e plausibilità, lo sfondo, l’atmosfera i particolari di questa sorta di “incesto immaginario” che è al centro del mio libro. Ho concentrato la mia attenzione con più diligenza sui primi tre volumi dei diciannove che compongono l’opera pubblicata. Su quelli cioè che coprono l’arco di tempo in cui si svolge la vicenda.
E allora, con queste risposte, mi vedo costretto a terminare con due ricordi personali: lo scrivente possiede con fierezza non l’edizione in diciannove volumi ma quella successiva in quattro corposi volumetti (di formato pléiadico, o se si preferisce meridianico) editi dal Mercure de France tra 1986 e 1995; non so se possa essere un vanto o un pianto, ma personalmente trovo che la mia edizione sia magnifica. E poi, al ritratto di un Léautaud che viveva per scrivere aggiungo un particolare che affiora da una qualche mia lettura: quando gli sovveniva una certa parola, anche se si trovava in intimità con l’amante e stava per sopraggiungere l’acme del piacere, Paul correva ad annotarla. La sua vita fu segnata insomma da un incesto immaginario e da un reiterato coitus interruptus letterario. Anche solo per questo – per sbozzare una figura se non ignota almeno trascurata – l’escursione narrativa di Franzosini è bene sia presente sui nostri scaffali. Specialmente quelli da cui mancano i diari dell’onirico incestuoso.
Leggi anche:
Splendori e miserie di un poeta pugile | Gabriele Gimmelli
Vero, verosimile, memoria e storia | Chiara De Nardi
Edgardo Franzosini. Sul Monte Verità | Andrea Cirolla