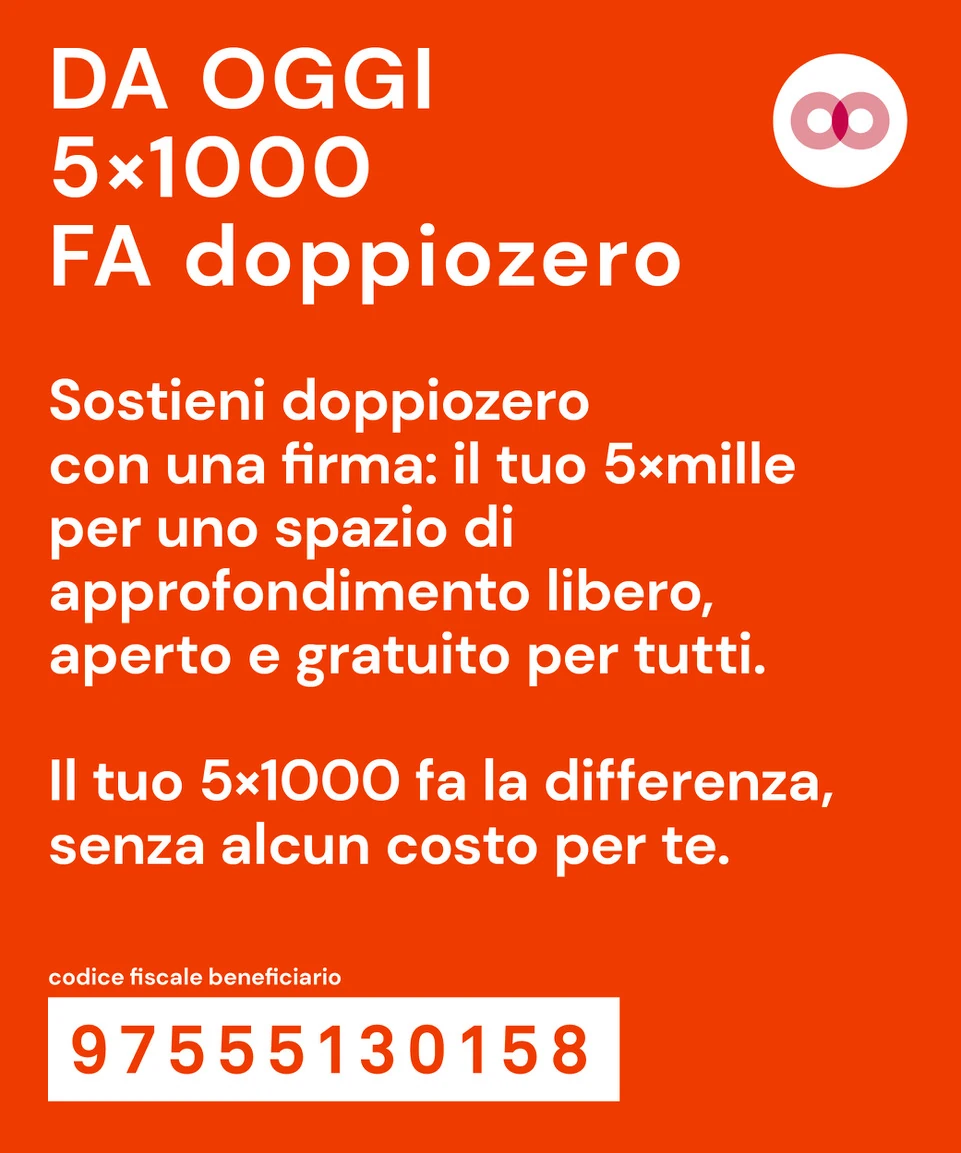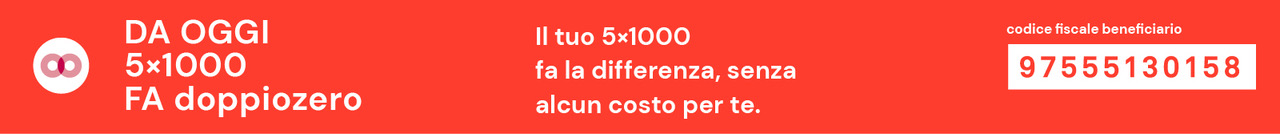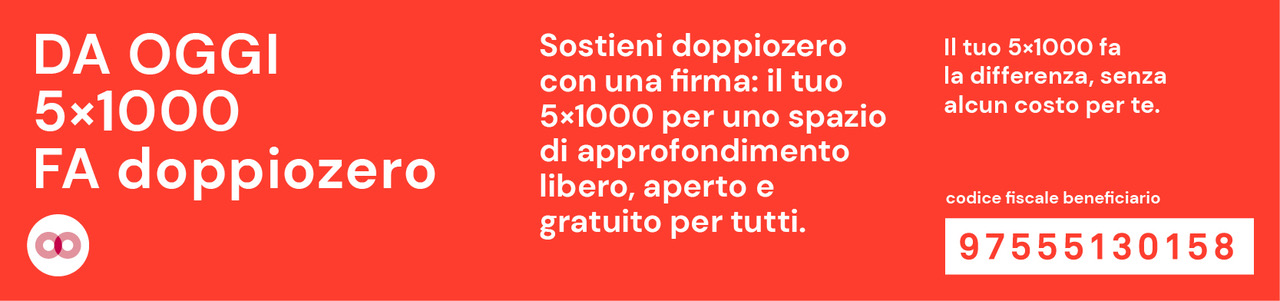C'è solo Milano?
Le indagini sono in corso e ci vorrà tempo prima che il quadro penale si chiarisca, dimostrandosi solido o meno dal punto di vista processuale. Ma le richieste di arresto (confermate dal Gip) per l’ormai ex assessore all’Urbanistica del Comune di Milano e per altre figure di primo piano del real estate milanese, insieme alla notizia che lo stesso sindaco Sala è tra gli indagati, hanno sollevato, come è ovvio, un acceso dibattito, che trascende le accuse per toccare il giudizio sul cosiddetto Modello Milano.
Bisogna dire che le indagini della Procura sono cadute come un fiammifero in una stanza satura di retorica. Retorica sull’attrattività di Milano, sul suo essere l’unica città italiana veramente cosmopolita, green, innovativa; retorica sul design, il food, l’architettura verticale, le week e gli eventi; insomma, i contenuti scintillanti di quel modello di marketing territoriale che per anni ha imperversato in città senza sostanziali contrappesi. Come messo in luce da Lucia Tozzi, questa rappresentazione – che poggia sul contraltare della cartolina stereotipata, ma sempre valida, della Milano del passato, con la domanda ricattatoria che ne consegue: “preferivate forse la città di allora: grigia, spenta, immobile e degradata?” – è stato a lungo egemonica, ma credo ci siano pochi dubbi che oggi abbia esaurito la sua spinta propulsiva. Qualcosa si è definitivamente rotto nel contrasto tra il calco della comunicazione e la realtà fattuale della vita urbana, mandando in frantumi l’immagine di Milano come città sexy e smart, che cambiando continuamente d’abito si compiace della propria crescita infinita e del suo successo.
Ma se non vogliamo accontentarci della constatazione che oggi il re è nudo – come nella favola di Andersen – dobbiamo a nostra volta abbandonare la tentazione all’iperbole e alla reificazione delle narrazioni, distanziandosi dalla cronaca per tratteggiare un ragionamento più ampio, che provi a leggere le trasformazioni di Milano con uno sguardo sospeso tra passato recente e prospettive future. Un ragionamento che non potrà che essere schematico, data la complessità del tema, e che più che per affermazione – dire cosa è oggi Milano – procederà per negazione.
Il primo punto è che il Modello Milano non è un fungo comparso d’improvviso in una notte. Per capirlo bisogna tornare indietro di almeno due decenni, e scusate se per farlo intesso biografia urbana e biografia personale.
Vent’anni fa ero un giovane dottorando di belle speranze. La sociologia urbana mi sembrava un mare aperto da solcare, ignaro dei kraken e delle sirene che la vita accademica nasconde sempre sotto la superficie (me ne sarei accorto dopo, quando ormai era troppo tardi per mettersi in salvo). Arrivato il momento di scegliere la tesi di dottorato, mi sono guardato intorno e ho visto una città – la mia città – che cominciava a riempirsi di gru come una risaia in primavera; solo che le gru in questione non erano gli eleganti uccelli dalle lunghe zampe, ma le strutture metalliche che presiedono alle nuove costruzioni edilizie. Cosa stava succedendo? Come mai Milano, che per decenni era rimasta sostanzialmente uguale a sé stessa, si stava ora punteggiando di cantieri e di progetti sui grandi (ma anche piccoli, a dir la verità) vuoti urbani, contendendosi le star dell’architettura mondiale come neanche i calciatori a inizio stagione?

Per capirci qualcosa mi compro un completo elegante, mi do una ripulita per sembrare più presentabile e incomincio a frequentare ambienti a me lontanissimi: fiere del real estate, dove tutti si scambiano biglietti da visita osservando rendering scintillanti; uffici elegantissimi del centro, dove sorseggio con indifferenza un caffè in attesa di intervistare un Ceo di una qualche società immobiliare; circoli esclusivi e dai nomi altisonanti, dove si entra solo in giacca e cravatta e rigorosamente su invito e, incredibile a dirsi, solo se si è maschi (no, il patriarcato non è un’invenzione).
A sollecitare la mia attenzione non erano solo le molte impalcature e il primo via vai per le strade dei camion del movimento terra. La mobilitazione simbolica precede e sostiene sempre l’investimento materiale, come da bravo sociologo sapevo bene. E infatti in città si respirava un’aria nuova, che si poteva riassumere in due slogan allora fortemente declamati: “far ripartire Milano” – che significava poi sostanzialmente una cosa sola: rimettere in moto lo sviluppo immobiliare, dato che la città era già riuscita a terziarizzare la sua economia, uscendo in maniera morbida dalla deindustrializzazione – e il cosiddetto “rinascimento di Milano”, l’embrione di quell’idea di magnetismo, di attrattività della città cool, vibrante di eventi e architetture iconiche, che tutti ormai conosciamo bene.
Questi slogan erano declamati all’unisono da un insieme eterogeneo di attori urbani. Chi faceva parte di questo coro? La giunta comunale, naturalmente, allora in mano al sindaco “amministratore di condominio” Gabriele Albertini, che era al suo secondo mandato; ma anche le stesse Università milanesi (la nascita dell’Università Bicocca, e la trasformazione dell’omonimo quartiere, è stata la prima grande operazione di rigenerazione di un’area industriale dismessa) oltre a giornali e stampa locale, pronti a sostenere e propagandare il nuovo corso tra annunci e facili entusiasmi. E poi loro, i veri protagonisti del mattone, la nuova razza di immobiliaristi che – sull’onda dell’euro, della finanziarizzazione immobiliare e della globalizzazione – andava sostituendo la tradizionale specie autoctona dei “palazzinari”, di cui Salvatore Ligresti era l’esempio più noto. Una nuova generazione fatta di developer dall’inglese fluente e dall’MBA collezionato negli Usa o a Londra, di spregiudicati raider che giocando in borsa avevano scalato società storiche dell’immobiliare italiano, di grandi gruppi industriali riconvertiti al FIRE (Finance, Insurance, Real Estate), di società di gestione di beni pubblici privatizzati, di fondi stranieri che mai avevano messo piede in città portando in dote i loro ricchi portafogli.
I nuovi city builders, la santa alleanza per la crescita che gli studiosi urbani di fede marxista avevano già descritto negli anni ‘80, raccontandoci la trasformazione “imprenditoriale” del governo delle città statunitensi. Coalizioni urbane che si rinsaldano intorno alla pietra filosofale che lo sviluppo immobiliare sia come la marea: alzandosi solleva tutte le barche, piccole o grandi che siano. Insomma, l’idea che tutti hanno da guadagnare dai grandi oggetti architettonici griffati che svecchiano l’immagine della città e che si impaginano nel paesaggio urbano come foto in un enorme dépliant. È così che si viene ammessi nella Champions League della competizione urbana, dove le città mondiali si contendono fondi e multinazionali desiderose di investire e aprire nuovi business, magari apponendo il proprio nome sui grattacieli più in vista (sempre che le insegne tengano…). La premessa, naturalmente, è incanalare l’azione pubblica intorno all’obiettivo di creare “un buon clima per gli affari”, che per l’immobiliare significa soprattutto pochi oneri, semplificazioni e deregolamentazione urbanistica.

Ma non solo di capitali si alimenta la competizione urbana. “Sa qual è il vero problema di Milano? Che attira soldi da cinque continenti ma non persone. Gli uomini d'affari vengono, concludono e scappano. Il quaranta per cento dei nostri appartamenti è già prenotato da business-men stranieri, inglesi, francesi, tedeschi, americani, giapponesi, cinesi. Berlusconi vendeva sicurezza a una borghesia milanese spaventata dagli anni di piombo. Noi vendiamo un investimento e uno stile di vita ai manager internazionali”. Chi diceva queste cose a metà degli anni zero? Un ambizioso protagonista dell’immobiliare meneghino di allora (non importa qui ricordarne il nome), che tra scandali e tracolli finanziari verrà presto disarcionato dal comando delle sue imprese.
Eh sì, perché nel 2008 scoppia la tempesta globale della crisi finanziaria (alimentata, ricordiamolo, dalla cartolarizzazione dei mutui subprime delle famiglie americane: i francesi, con un gioco di parole tra pietra e carta, li chiamano pierre papier, mattoni di carta). E lo sviluppo di Milano subisce, come è ovvio, un brutto colpo, mentre diversi immobiliaristi e società scompaiono o cambiano di proprietà. Intanto, la sindacatura di Letizia Moratti si affloscia stancamente su sé stessa, e nel 2011, nella sorpresa generale, la sinistra conquista Palazzo Marino con un candidato indipendente – Giuliano Pisapia – inviso al principale partito di maggioranza. Sembrava proprio che la sagoma della coalizione per la crescita immobiliare, che avevo visto delinearsi all’orizzonte di Milano, fosse solo un abbaglio.
E invece no: quel blocco di interessi si stava solo riconfigurando, adattandosi alle nuove condizioni. Quello di cui c’era bisogno era un nuovo fulcro alla leva della rigenerazione urbana, un punto di appoggio su cui concentrare le energie materiali e immateriali e far così ripartire il motore della crescita. Non c’è dubbio che l’Expo, inaugurato quasi per miracolo nel 2015, sia stato quel punto di appoggio. Un grande evento, di indiscutibilmente successo, che è riuscito nell’operazione più difficile di tutte: proiettare il capoluogo lombardo al centro dei flussi turistici globali. Milano, la città italiana più refrattaria al turismo che mai sia esistita – con la sua ruvidezza operosa, con la sua bellezza schiva, con il suo deserto nucleare estivo, chi lo ha sperimentato lo ricorda bene – si scopre improvvisamente invasa di turisti dai quattro angoli del mondo, con conseguente stravolgimento dell’offerta commerciale e del mercato degli affitti. (L’operazione ha avuto un successo tale che gli effetti trascendono, e di molto, i confini cittadini: lo sanno bene a Varenna, sul lago di Como, o nelle Cinque Terre, paesi oggi letteralmente invasi da visitatori stranieri, in buona misura figli della turistificazione di Milano.) E così arriviamo alla Milano di Beppe Sala, che di questa trasformazione è stato il principale artefice, prima come manager di Expo e poi come sindaco della città, rieletto due volte col centro-sinistra.
Il Modello Milano non è quindi un fungo, perché negli ultimi vent’anni, tra spinte e frenate (pensiamo alla stagione del Covid), ha attraversato nei fatti diverse stagioni politiche. Un modello basato sulla crescita immobiliare (più costruito e prezzi più alti), sui grandi progetti (oggi è il turno di San Siro), sui mega eventi (vedi le Olimpiadi invernali in arrivo), insomma sul principio che la trasformazione urbana non può che basarsi sulla leva dei capitali privati, che come ovvio non agiscono per filantropia, e sull’attrazione di nuova popolazione (turisti, élite trasnazionali, fasce medio-alte da tutta Italia) che può permettersi una città sempre più esclusiva.
Intendiamoci, il governo di una città, soprattutto se complessa come Milano, non si limita all’urbanistica, ma comprende molte altre voci: dalla mobilità ai servizi, dall’educazione al welfare, dalla transizione ecologica alla lotta contro l’esclusione. E tutte queste cose non sono state certo gestite in egual modo e nella stessa direzione da chi si è succeduto al governo della città in questi anni. È altrettanto certo, però, che non aver mai messo in discussione quel modello e quel blocco di interessi, gettando al contrario sempre nuova benzina sul fuoco dell’attrattività e della valorizzazione, abbia segnato il volto di Milano in maniera profonda, mutandone i connotati urbanistici, sociali e relazionali.

E infatti, come ampiamente previsto dagli studiosi e inutilmente denunciato dagli attivisti sul territorio, in questi anni Milano è diventata più diseguale, attraverso dinamiche di gentrification e polarizzazione che sono ormai sotto gli occhi di tutti. Difficoltà di accesso alla casa anche per lavoratori essenziali (infermieri, autisti, camerieri…), riduzione dell’affitto (eroso dal turismo) e crescita dei canoni, espulsione dei ceti popolari dai quartieri semicentrali e dalla periferia (Milano è una città spazialmente ristretta). Come sanno bene anche le insegnanti delle scuole milanesi, che vedono sempre più bambini costretti a trasferirsi con le famiglie in zone fuori città, economicamente più accessibili, perdendo stabilità e relazioni.
Ma gli effetti perversi di questo modello non riguardano solo la casa e non riguardano solo “gli ultimi” (coloro che dalla marea vengono travolti, invece di cavalcarla facendo affari, come sarebbe giusto che sia). Anche imprese e attività commerciali (artigianali, creative, culturali…) non riescono a restare sul mercato, venendo espulse verso zone marginali e improprie, nonostante i loro servizi e la loro offerta di lavoro contribuiscano alla qualità urbana e alla stessa attrattività della città. Presidi sociali, non piegati alla sola logica del profitto e del consumo, vengono inevitabilmente stritolati nella morsa della valorizzazione. E qui gli esempi possono essere molti, ma basterà citare i casi recentissimi di WOW Museo del fumetto (chiuso questa estate, dopo una forte mobilitazione di artisti, famiglie e abitanti del quartiere) e della storica Libreria dei ragazzi e delle ragazze di via Tadino, punto di riferimento per l’intera comunità educante milanese, che abbassa le serrande di una sede, divenuta troppo cara, senza sapere ancora dove potrà continuare le proprie attività.
La crescita dei prezzi non è spinta solo dai grandi progetti, ma anche da un fronte composito di lavori di ampliamento, ristrutturazione e nuova edificazione: un insieme di cantieri di scala più contenuta, polverizzati sul territorio, il cui effetto cumulato sulla città e sui quartieri si è fatto nel tempo sempre più pesante. Un’urbanistica a sportello che ricorre alla sola concessione edilizia o permesso di costruire (se non a una semplice dichiarazione di inizio attività, la famosa SCIA) per passare velocemente alla fase esecutiva, riducendo, e in alcuni casi annullando, gli oneri da versare nelle casse comunali o le aree da cedere per servizi, verde e parcheggi. Ai recenti casi di grattacieli spuntati al posto di laboratori a due piani nei cortili o a ridosso di parchi, sui quali la magistratura sta indagando, possono essere affiancati moltissimi esempi di questi anni, a partire dall’area Ex-Enel in zona Monumentale che a suo tempo sollevò la mobilitazione della comunità di Doppiozero.

Come uscire da questo quadro? Come ripensare Milano rifondando un progetto a sinistra su cui ricostruire una nuova proposta politica per la città? La risposta non è semplice, perché le macerie sono molte e il livello del dibattito politico, bisogna ammetterlo, è stato sinora assai deludente. Da parte mia, mi limiterò in chiusura a suggerire due spunti.
Il primo elemento è di metodo. Bisogna ridurre il deficit democratico che ha permesso e accompagnato il prevalere degli interessi privati su quelli collettivi. Mi riferisco alla sottrazione sostanziale della discussione sulle trasformazioni urbanistiche agli organi rappresentativi e di partecipazione (Consiglio Comunale, Municipi, partiti politici…), sempre più deboli e afoni. A vantaggio di saperi esperti – soprattutto gli architetti, assai meno gli urbanisti – e di organismi tecnici – come la ormai nota Commissione per il paesaggio – ai quali viene demandata, in modo per lo più autonomo e discrezionale, la definizione strategica e puntuale degli interventi. Mi scuso per l'autocitazione un po’ profetizzante, ma nella mia tesi di dottorato del 2007 scrivevo in proposito: “considerata la crescente debolezza degli organi democratici rappresentativi nei processi decisionali urbani, nel nome dell’efficacia e della concorrenza tra città i nuovi rapporti tra pubblico e privati potrebbero dare luogo a inquietanti derive, nelle quali un piccolo gruppo di attori può trovarsi nelle condizioni di imporre rilevanti progetti di trasformazione e monopolizzare così i meccanismi di scelta, assumendo sul piano locale il ruolo di una nuova oligarchia egemonica”. È in questo vuoto di partecipazione e democrazia che trovano terreno di coltura i comportamenti opachi su cui sta facendo luce la magistratura.
Il secondo elemento, invece, è di sostanza. La città finanziarizzata è una città profondamente diversa dalla città industriale, ma anche da quella dei servizi. È una città che vive della rottura di tutti i legami e le interdipendenze che la compongono. Al fondo, è una città che seleziona e divide; una città della differenza e non delle differenze. Milano in questi anni si è incamminata su questo terreno, ma non è ancora spacciata: chi la conosce e la vive sa che l’immagine di Milano come "parco giochi dei ricchi” è un’iperbole che non corrisponde a verità. Ma se si vuole rivitalizzare la varietà e la vitalità della società milanese bisogna mettere in discussione una volta per tutte il modello della città attrattiva: Milano non è una macchina scenica esclusiva votata al lusso, al consumo e alla maraviglia, ma una comunità di reti di relazioni che non nascono da eventi, massificazione e movida, ma da servizi accessibili e universali, da quartieri coesi e vivibili per tutti, da radicamento e riconoscimento reciproco. Forse la realtà è molto più semplice: nessuno, alla lunga, vuole vivere in una città vetrina, per quanto bella e cool possa apparire dall’esterno.