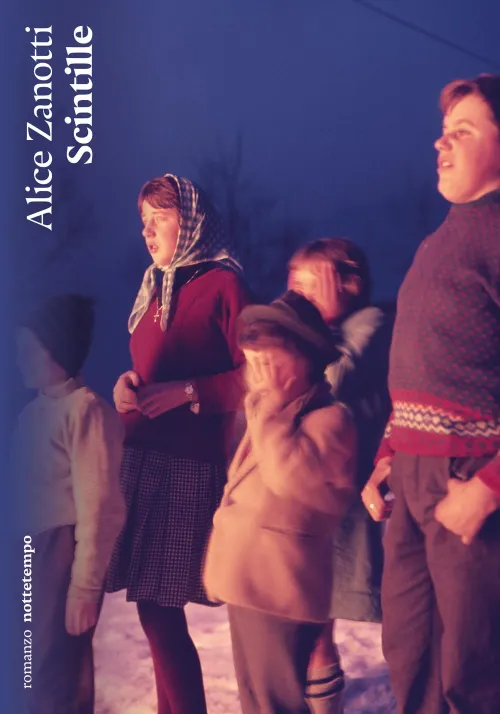Tre sorelle tra Italia e Slovenia
Paolo Nori, che è originario di Parma e riflette spesso sul suo dialetto, ha scritto nel suo ultimo romanzo che in dialetto parmigiano la parola amore non esiste (amor, aggiunge, significa Io muoio); anche nell’ultimo romanzo di Alice Zanotti, Scintille (Nottetempo 2025, 252 pp.) la parola amore non esiste; a dire il vero non esistono molte altre parole, tutte soppiantate da parole che appartengono a una lingua altra: “Noi pensiamo che certe parole in italiano ci sono, ma nella nostra lingua mancano. Il dialetto di Montefosca è fatto di poche parole, di parole che sono sempre le stesse. Di parole che si usano poco perché bisogna lavorare, non parlare.”
A Montefosca, un borgo al confine tra Italia e Slovenia, abitano le tre sorelle al centro di questo libro: sono Alma, Anna e Buia. Hanno una voce sola – “Dividerci fa male, fa tanto male alle mani, ci tira via il cuore. Dividerci non si può, noi siamo un solo fuoco.” A dire il vero Buia, la più piccola, è muta: il dialogo con le due sorelle si attiva di nascosto dal resto del mondo e sembrerebbe essere l’ultima possibilità di relazione con l’alterità che le è concessa. Ha iniziato a rifiutarsi di parlare quando Pietro le ha confessato di essere innamorato di lei, le ha porto un fiore e ha rovesciato un bidone di latte. Un presagio, una maledizione: il legame fra Buia e Pietro è celato agli occhi degli altri, agli occhi dei grandi. La ferita che causa l’afasia è generata dall’amore – è l’amore che toglie le parole, in questo romanzo in cui ogni cosa ha a che fare con il dire (scegliere cosa dire, dire il desiderio, adoperare una lingua per essere riconosciute). Sembrerebbe che tutte le volte che la persona vocalica adottata è la prima singolare sia proprio Buia a parlare: così il suo silenzio si scioglie nella prosa; e se i pensieri di Buia, secondo le sorelle, sono gomitoli, allora forse affidarle tessere di trama è un modo per permetterle di dipanarli, renderli filo.
Scintille è un libro retto da ellissi. La comunità al cui centro stanno le tre sorelle non è un cerchio: figura geometrica perfetta, sarebbe inadatta a contenere le storture del desiderio di ognuno dei personaggi che la animano. La circonferenza si allunga, viene tirata verso l’esterno, ogni personaggio porta con sé la sua energia. Špleat graffia con il coltello le sue poesie sui muri, fra i groppi d’edera; Nina Kocianua con le ossa di rana inventa magie, le interroga, pratica riti antichi.
Ecco poi Buia, Alma e Anna che si tengono per mano, stanno al centro, sono un’altra piccola comunità anche loro: intessono una rete smagliata, abitano il margine fra l’infanzia e la vita adulta, provano a capire un corpo che cambia, vivono una forma di relazione simbiotica che causa non pochi sospetti. Il loro agire non sembrerebbe deviante rispetto a quello della comunità: anche le sorelle Kokulčua vivono nell’intermittenza fra un non detto e l’altro. Eppure si dice questo: “Siamo streghe, siamo come Nina, perché ci parliamo sopra come i rami che stanno uno sopra l’altro prima di scintillare, perché ci hanno visto appendere i nostri pezzi di stoffa rosa all’albero morto giù al torrente, perché, giù al torrente, qualche volta accendiamo fuochi per girarci intorno.” Forse è qui, in effetti, che si gioca lo scarto fra queste giovani donne e gli altri: nella fiducia riposta nel rito, nel dialogo aperto, simbiotico con la natura. “Della nostra scintilla nessuno sa, del fuoco che portiamo dentro nessuno immagina.”
Su un altro piano si situano le ellissi che puntellano la trama: i non detti, i silenzi e i sussurri che scorrono carsicamente fra queste pagine, i timori rivelati per metà, gli incantesimi di Nina, le parole affidate al bosco. In effetti, parrebbe quasi un paradosso narratologico (o strutturale?): come può un’ellissi, figura della reticenza, fungere da struttura portante? È questa la vera magia narrativa che riesce a Zanotti: modulare molte lingue per confezionare una storia che nello stile riesca a mimare la trama – intessuta di singhiozzi e segreti taciuti, pause forti, lunghe, frasi brevi: i silenzi della comunità di Montefosca sono anche i silenzi del testo, che non è mai esuberante e rifiuta ogni lirismo.
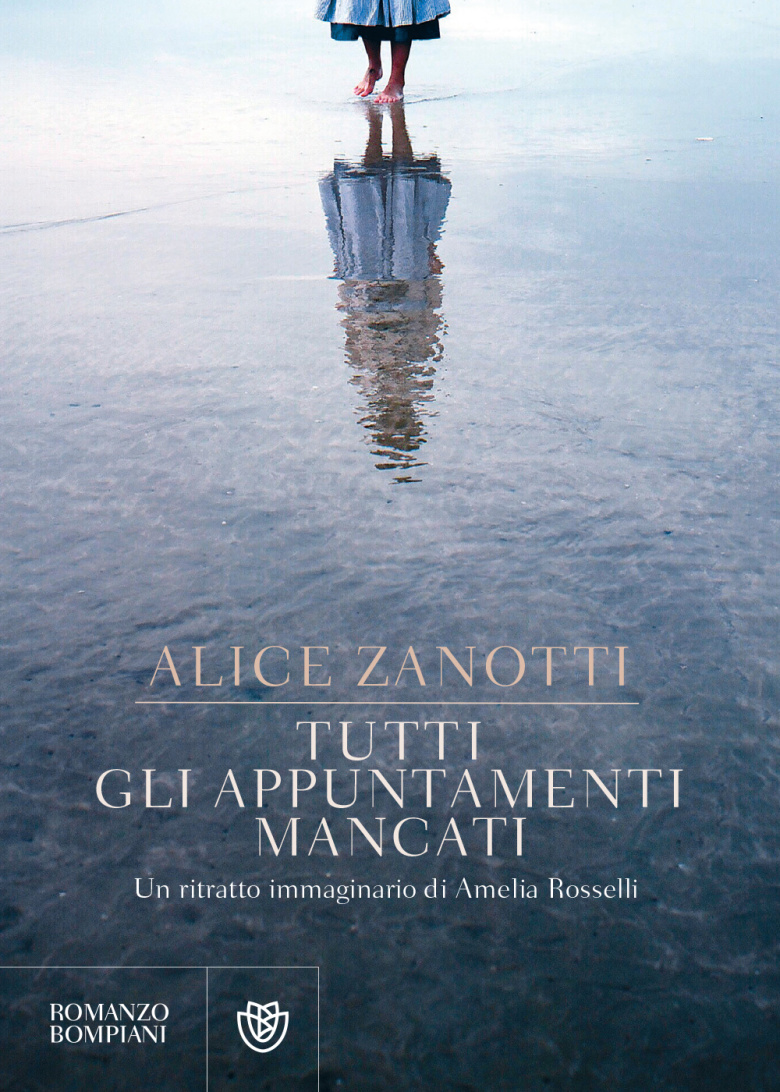
Il rapporto con l’alterità è uno dei nodi più significativi di questo testo: l’ellisse-comunità è minacciato dall’intrusione degli stranieri, arrivati quasi sulla soglia del paese per costruire una strada. Lo sradicamento simbolico del mondo per come gli abitanti di Montefosca lo conoscono si fa dunque materiale, e la strada è il segno tangibile di un progresso al quale sono assolutamente restii ad arrendersi. Non solo: il contatto con l’altro, lo straniero, è problematico perché svela il pericolo dell’ignoto – “Nessuno si fida dello straniero, a meno che non sia un cantastorie, perché nei suoi occhi si riconoscono, negli occhi dello straniero tutti vedono cose che non conoscono”. A ben guardare parrebbe problematico ogni contatto che viene registrato fra queste pagine: nessuno accoglie mai in modo sincero al di fuori della rete costituita dalle tre sorelle, che sembrano essere le uniche disposte ad un ascolto pieno.
È Buia il personaggio a cui viene affidato l’incontro ravvicinato con lo straniero; lui le descriverà il cantiere ma lei rimarrà in silenzio: “Le mie parole suonano come il paese, come le campane, come il latte che diventa formaggio, come i primi germogli dell’orto. Lo straniero non mi può capire.” Se l’altro si fa simbolo di un mondo nuovo, dominato dall’idea di progresso e velocità, Buia si autoproclama, attraverso la sua afasia, custode di un universo arcano e stupendo, arcaico e diverso. Sarà lei a organizzare la guerra, la resistenza contro la distruzione del microcosmo. Raduna “le cose che le serviranno contro gli stranieri”, “Voi mi seguirete? Alle armi ci penso io, anche a incidere i nostri bastoni”.
Il fuoco, infine. La conclusione è concitata e commovente, affidata alla voce della comunità che è alta e squillante, per la prima volta, e compatta, e abbandona il tono del sussurro – “Il nostro NO si unisce all’incendio che infuoca dietro le nostre spalle, il nostro NO risuona come il rintocco di una campana. […] NO non staremo qui a guardare mentre voi spezzate il nostro mondo in due”. Dolente, così finisce il mondo, “come tutti i mondi, con la guerra”, in una poesia graffiata su un muro insistentemente cercata.
Alice Zanotti ha a lungo studiato Amelia Rosselli (il suo esordio per Bompiani, Tutti gli appuntamenti mancati, era una sua autobiografia romanzata) e ne ha compreso la lezione: non c’è lingua che sia sufficientemente stabile da riuscire a raccontare gli angoli del nostro cuore in cui siamo inconoscibili persino a noi stessi – sbandati e balordi, per dirla con un’altra grande del secolo scorso – né a Montefosca né nel regno della poesia: e così ogni dire è provvisorio, scintilla oscillante sul crinale fra la terra ferrosa – l’erba, il fango, l’odore della morte – e una dimensione onirica, inafferrabile. Così Scintille è un’elegia, frammentata e disorientante, un coro, un romanzo che rifiuta di seguire la strada – o forse dovremmo dire le strade: quella degli stranieri e la strada canonica della narrazione. Ne trova però altre, per dire il desiderio che “sfugge da ogni parte”.