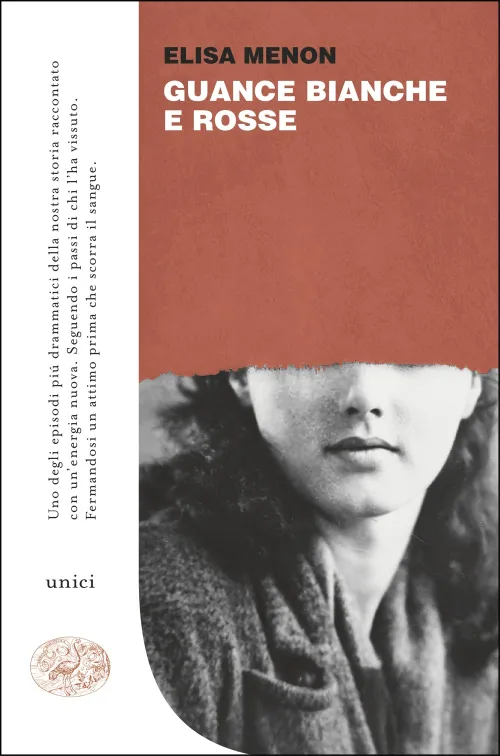Porzûs negli occhi di una ragazza
Da qualche anno nella narrativa italiana c’è la tendenza a raccontare vicende ambientate nella prima metà del Novecento, con protagoniste femminili che sfidano una tirannia che non è solo politica, ma anche di genere. Che il periodo fascista continui a essere, per larga parte della nostra letteratura, il fondale preferito su cui trasfigurare il presente è senza dubbio un dato interessante. Eppure il fenomeno alla lunga ha finito per assumere i contorni di una formula su cui un editore oggi può scommettere quasi a occhi chiusi, il che ha determinato una proliferazione di quarte di copertina che sembrano narrare tutte la stessa storia.
Perciò, quando ad affacciarsi sugli scaffali delle librerie è un nuovo romanzo che solo apparentemente batte quei sentieri, ma che in realtà si stacca per qualità mettendo in campo allo stesso tempo un importante avvenimento storico, una gigantesca questione etica, una lingua sapiente, e dei personaggi dominati dall’ambivalenza, bisogna essere veloci a intercettarlo, per evitare che si confonda e si perda nel mare del conformismo.
È il caso di Guance bianche e rosse, il nuovo titolo in uscita a settembre per la collana “unici” di Einaudi, imponente esordio letterario della drammaturga friulana Elisa Menon, già segnalato con una menzione speciale nell’edizione 2024 del Premio Calvino. Il romanzo nasce da un precedente monologo teatrale ed è incentrato sulla figura di Elda Turchetti, una giovane operaia cotoniera di Pagnacco indicata da Radio Londra come spia dei tedeschi. La ragazza è il perno intorno al quale ruota una vicenda storica tra le più problematiche della Resistenza italiana, quella che culminò nel febbraio del 1945 con l’eccidio di Porzûs, una località che si trova su una dorsale montuosa delle Prealpi Giulie, poco distante dall’odierno confine italo-sloveno.
Ma prima di inoltrarci nel racconto del romanzo è necessario dare alcune coordinate storiche. I fatti di Porzûs del resto non possono essere compresi senza tenere conto della geografia politica e militare della Resistenza friulana, attraversata da tensioni ideologiche e rivalità di comando che la guerra aveva reso insanabili. A condividere lo stesso territorio operativo, finendo presto per diffidare l’una dell’altra, erano due anime partigiane: la divisione Osoppo, costituita da formazioni di ispirazione cattolica, azionista e socialista non comunista, e i garibaldini, legati al Pci e al movimento partigiano sloveno. Sullo sfondo, il problema cruciale del coordinamento coi reparti sloveni, che da tempo chiedevano ai gruppi italiani di sottostare al loro controllo, nella convinzione che solo un comando unificato potesse garantire la giusta efficacia militare.
I garibaldini della Divisione Natisone, già abituati a operare a stretto contatto con gli sloveni, dal dicembre del 1944 entrarono formalmente a far parte del IX Korpus, una delle principali unità dell’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, e si trasferirono in Slovenia. La scelta degli osovani fu opposta: la I brigata Osoppo, guidata dal capitano Francesco De Gregori (zio dell’omonimo cantautore), con accanto l’azionista Gastone Valente, si insediò nelle malghe di Porzûs, rimanendo di fatto isolata.
Fu in quel contesto che le relazioni tra le due anime della Resistenza friulana si incrinarono irrimediabilmente. De Gregori era diffidente verso i comunisti, che definiva “nemici occulti”. Di contro, sull’Osoppo si abbatterono accuse di tradimento, di collusione col nemico e perfino di aver provocato la morte di decine di garibaldini. Si trattava di insinuazioni senza fondamento, diffuse attraverso rapporti indirizzati al Pci di Udine e ai comandi garibaldini da Mario Toffanin, detto “Giacca”.
La resa dei conti si consumò il 7 febbraio del 1945, quando un centinaio di uomini guidati da Toffanin raggiunsero le malghe di Porzûs. De Gregori venne ucciso insieme a Valente e alla giovane Elda Turchetti (la protagonista del romanzo di cui parliamo) e a un partigiano garibaldino sopravvissuto alla deportazione che aveva avuto l’ordine di presentarsi al comando osovano. Insieme a loro furono catturati quattordici osovani, tra cui Guido Pasolini, il fratello di Pier Paolo, che vennero fucilati nei giorni successivi.
La frattura non degenerò in una scissione definitiva della Resistenza friulana, ma la ferita rimase insanabile e divenne, già nel dopoguerra, materia di infinite contese politiche e giudiziarie, e resta a tutt’oggi uno degli episodi più laceranti e controversi dell’intera guerra partigiana. La storia è stata ricostruita, tra gli altri, dallo storico Tommaso Piffer in un saggio uscito quest’anno per Mondadori: Sangue sulla Resistenza. Storia dell’eccidio di Porzûs.
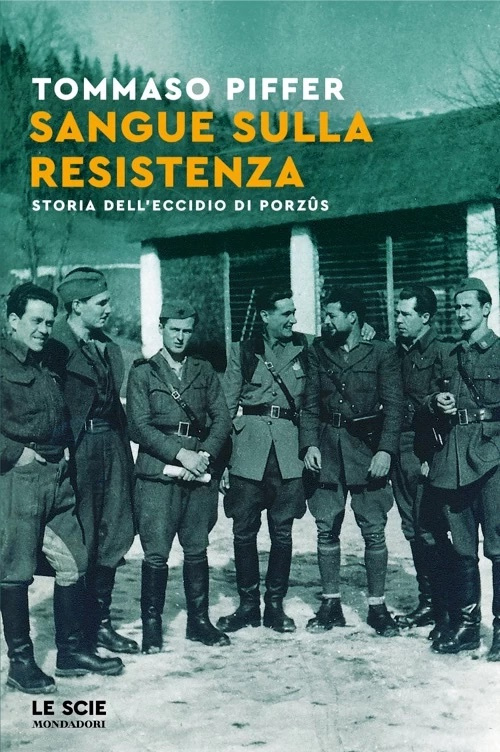
È questo lo scenario in cui veniamo calati durante la lettura di Guance bianche e rosse. Romanzo storico quindi, ma non solo. Perché c’è un dettaglio di non poco conto che riguarda uno dei protagonisti del libro, Gino Persoglia, uno dei cento garibaldini, in larga parte giovanissimi, che obbedirono all’ordine di catturare e uccidere gli osovani. Gino era il nonno dell’autrice, morto a sessantasei anni quando Elisa Menon era ancora una bambina. “Tuo nonno è finito in mezzo a quella storia, non sai?” le dice sua madre mentre in televisione scorrono le immagini di una delle tante commemorazioni della strage. La frase è l’innesco che precipita noi lettori nella caverna del tempo. Qui incontriamo Elda, che ogni giorno parte in bicicletta da Pagnacco, dove vive insieme a sua madre Lucia e al fratello Roberto, per andare al cotonificio di Udine a vedere se c’è lavoro. Ma è il 1944 e il cotone non arriva per via della guerra. Provvedere alla famiglia è sempre più complicato, così Elda, tramite l’intercessione di un amico, accetta un impiego ambiguo: diventa un’ascoltatrice di popolo. Tutto quello che deve fare è riferire ciò che vede e che sente e consegnare delle buste di cui non conosce il contenuto. Lo fa per qualche giorno, nonostante il suo fidanzato la metta subito in guardia. Ma Elda si sente uno spirito libero, ha vissuto troppo male fino a quel momento e l’istinto le dice che quella è l’occasione giusta per emanciparsi. Quando tuttavia decide di fare un passo indietro e rinunciare all’incarico, è ormai troppo tardi. Radio Londra ha già emesso la sentenza: Elda Turchetti è una spia al soldo dei nazisti.
Sull’altro fronte del racconto ci sono i ragazzi di Ruttars, il gruppo di gappisti guidato da Mario Toffanin, i più giovani, e forse inconsapevoli, partecipanti alla spedizione punitiva alle Malghe, dove nel frattempo è stata condotta anche Elda per decidere della sua sorte. Tra loro c’è Gino.
E per sussurrarci tutto questo in un orecchio, Menon usa una lingua che è pura cura, in cui l’asprezza del friulano traspare soprattutto nella costruzione sintattica della frase, e poco nel lessico, a cui ricorre più che altro in alcuni dialoghi. Sembra, per dirla con Pavese, che in questo libro “le parole sono tenere cose, intrattabili e vive, ma fatte per l’uomo e non l’uomo per loro”. Questa lingua riesce nell’impresa, più che di battere, di addolcire. È una lingua che con le sue proprietà riedifica un mondo, è la vera scenografia del racconto, più ancora del paesaggio amaro, del mondo contadino su cui passano le mani nere della guerra e dell’inverno.
Ma torniamo a Elda e Gino, che sono – va detto – due facce della stessa medaglia.
In un bellissimo saggio pubblicato in Italia da Einaudi nel 1998, Il potere terribile di una piccola colpa, Abraham Yehoshua scriveva: “La letteratura non esige dai suoi fruitori comprensione, bensì identificazione. In virtù di questo fenomeno di immedesimazione la questione morale non resta al solo livello cognitivo, ma entra a far parte della personalità stessa del lettore; diventa insomma il suo problema esistenziale. Per questo l’impatto morale della letteratura, quando è buona, raggiunge, sconvolgendoli, gli strati più profondi della personalità”. Yehoshua poneva al centro delle sue riflessioni sulla letteratura il dilemma morale. In pratica i buoni testi si distanziano dalla cattiva letteratura perché pongono il lettore di fronte a una questione irrisolvibile, lo mettono per così dire con le spalle al muro (al centro di Delitto e castigo c’è la domanda abissale se l’uomo abbia il diritto di realizzare se stesso attraverso l’assassinio di un essere spregevole).
Comprensione contro identificazione, dunque. Uno dei peggiori travisamenti degli ultimi anni, che a ben vedere non investe solo la letteratura, ma tutto ciò che ha a che fare con l’arte del narrare, riguarda proprio questa fondamentale distinzione. I lettori, imboccati dagli stessi autori, pretendono sempre più comprensione, vogliono che a guidarli nella storia siano personaggi dalle inequivocabili e specchiate qualità morali, creazioni del tutto irrealistiche nelle quali la linea che separa il bene dal male è tracciata in modo netto. Per dirla in breve: vogliono essere rassicurati su se stessi e sulla propria innocenza.
Il pregio maggiore di Guance bianche e rosse, a mio avviso, sta proprio nel fatto che rovescia questa deriva per riportare il romanzo sul suo terreno originario, che è sempre stato quello di interrogare il lettore, straziarlo se necessario, costringendolo piuttosto in una posizione impossibile. Il lettore superficiale che vorrà mondarsi l’anima, abituato a considerare il romanzo come un’aula di tribunale in cui scagliare sui personaggi i propri giudizi tranchant, considererà allora Elda e Gino in due soli modi possibili: l’una è una spia, l’altro il coesecutore di una strage. E se attenuerà questi giudizi, o se addirittura li sovvertirà, sarà solo per sguardo di parte. Il lettore più oculato, invece, percorrendo le vie dell’identificazione, si lascerà invischiare nelle innumerevoli correnti che rimescolano il bene col male, godrà delle infinite sfumature che rendono in fondo tutti noi le fragili e contraddittorie creature umane che siamo.