Il sud Felice
Si può raccontare in un libro il tentativo di esplorare, mostrando e interrogando, il senso di un luogo comune, insieme intimo e sfacciatamente pubblico, come un’autostrada. Felice Cimatti, artista e filosofo del linguaggio che insegna da anni all’Università della Calabria, lo ha fatto ora in un piccolo testo, arricchito da una serie di sue foto di viaggio, in Nella giornata più calda dell’anno. Attraversando il Sud (Donzelli Ed. 2025, pp. 95, E. 18). Tornando a qualche anno fa ricordo la bella mostra e il catalogo curato da Emilia Giorgi e Antonio Ottomanelli, in «Verso il Mediterraneo. Sezioni del paesaggio da Salerno a Reggio Calabria», (Istituto Centrale per la Grafica, Palazzo Poli, Roma, 2017, catalogo con foto e testi pubblicato nel 90° anniversario di Anas), che attraverso più di 100 scatti di alcuni dei più grandi fotografi italiani e internazionali aveva riletto e messo insieme immagini e fenomenologia del paesaggio attraversato dalla Salerno-Reggio C., mostrando aspetti inediti della realtà che corre ai lati di una grande strada e della sua storia.
Libri come questo di Cimatti respirano un’aria che conosco. Mi riportano al mio lavoro. Sulle stesse strade percorse e illustrate nel suo testo da Cimatti provo da anni a disegnare le mappe di un viaggio pubblico e privato nel contemporaneo. Da antropologo e scrittore, nei miei libri, ho deciso di raccontare soprattutto questo luogo intermedio che sono le strade, il loro paesaggio, il loro spazio umano. Le strade al Sud sono tutto, storia e geografia, flora, fauna e cemento. Un luogo comune, una sorta domicilio mobile e collettivo, che strada facendo diventa di volta in volta desertico o affollato, instabile o eterno. La strada al Sud è oggi linea mobile di un nuovo confine interno, che porta dritto al cospetto della “presenza massiccia, potentissima del mondo”, ficcandoci tutti dentro la sua più “assoluta presenza”. Del resto, come scrive ancora Cimatti, tutti insieme abitiamo un tempo sempre più dissacrato e stretto nell’asfissia dell’Antropocene, il tempo della storia che ha dichiarato naturale la signoria tecnica dell’umano su «tutte le nature», e tutto il resto ha ridotto a cosa disponibile al suo insaziabile e dispotico dominio sul mondo.
«Tutte le nature sentono». Tutte le cose del mondo, ogni cosa animata o inanimata che sia, scriveva Tommaso Campanella nel 1604 nel trattato Del senso delle cose e della magia, “sentono”. E sentendo, danno segni coglibili della loro esistenza e del loro significato. E per questa via entrano in comunità con gli umani. Campanella immaginava così un’argomentazione che, forse solo oggi, “possiamo davvero apprezzare in tutta la sua potenza e radicalità”.
Già partire da questo asserto mistico-sensista derivato dal pensiero di Tommaso Campanella, è una bella sovversione local del cogito cartesiano. Lì è infatti l’origine dello stigma che separa res cogitans da res extensa, principio imperialista di ogni antropocentrismo contemporaneo. Allora, perché non estendere alle cose del mondo di oggi, apparentemente le più corrive e stolide come il cemento e l’asfalto di un’opera pubblica, e ai costrutti umani di un’infrastruttura stradale, questo bel principio della sovversiva mistica campanelliana? Perché poi se «tutte le nature sentono», una strada (del Sud) non dovrebbe farlo? Del resto, più che un nonluogo nel senso definito da Marc Augé, l’Autostrada A2, la mitologica Salerno – Reggio Calabria, la A3 di una volta che oggi si chiama Autostrada del Mediterraneo, spiega Cimatti, è una strada che si presenta sin da principio come oggetto di “una natura indeterminata”, a partire dalla sua nomenclatura, dalla sua postura sempre sospesa e indecisa tra tecnica e natura.
Anche se si tratta pur sempre di “un’esperienza automobilistica”, precisa Cimatti, e quindi “del tutto moderna e antropocenica”, questo rovesciamento di prospettiva che avviene “da dentro la nostra automobile, grande o piccola che sia”, è sufficiente a far sì che la A3 nel suo lungo slinearsi nella varietà dei paesaggi, e al rintocco delle entità che essa attraversa, confonda da subito la nostra capacità di comprendere le ragioni e i sensi del nostro stato in luogo. Il tragitto dentro le sue corsie obbligate aumenta le incertezze e i timori, ma carica di percezioni il nostro viaggio, rende pensierosa e provvidenziale la nostra confusa e precaria presenza al mondo.
Il racconto partecipato del suo esperimento di “abitante” provvisorio di questa strada cardinale, viene presentato da Cimatti alla stregua di un piccolo ma divertente trattato speculativo (scritto e illustrato) di dromologia. L’estroversione promulgata da Cimatti per la dromologia lo porta a percorrere e fare strada da e verso il Sud tramutando il lungo tragitto automobilistico tante volte ripetuto, in un movimento che “rovescia l’usuale in estraneo, l’ovvio in misterioso”. Per Cimatti infatti “il Sud significa soprattutto questo”, ritrovare “il senso di una possibile «vita commune» fra inumano e umano, cioè fra cose e viventi”. In questo stato di coscienza aperto alla stupefazione dell’altrove meridiano, l’immagine ipostatitizzata di un Sud chiuso nella storia e fermo nel suo passato immobile, frana e si ribalta nell’insignificanza di un pregiudizio che Cimatti definisce, giustamente, ridicolo e presuntuoso. L’autostrada si offre invece come luogo rivelativo, come spazio di un’esperienza contraria, rovesciata nella presenza dei segni impermanenti del mondo della tecnologia che domina l’epoca della mobilità generale.
Il sottosopra dei trasporti, il traffico, la strada dentro l’astanza dei domini naturali. Questo è il fondale di un nuovo paesaggio meridiano che non scalza l’eterno; lì è lo spiraglio che accede alla porta simbolica del Sud contemporaneo, “che per me comincia «ufficialmente» con l’inizio dell’autostrada”, conferma Cimatti. Qui è la soglia che restituisce agli attraversamenti meridiani compiuti dall’autore, anche un senso di coinvolgimento, di “avventura”. È infatti per strada che si incontra “l’esperienza di una presa tattile sul mondo – perché anche «la visione è tatto»: “come scriveva ancora Campanella: «non può sentirsi mai la cosa che non si tocca»”. “Il Sud mi ha toccato”, scrive a sua volta Cimatti. “Ecco, per me il Sud è prima di tutto una esperienza tattile, in presenza, affettiva, piena. Per questa ragione quella del Sud si afferma come una «vita commune»: “fra cose e viventi” che si mischiano, l’esistente qui non molla mai la presa: “il mondo ti sta sempre addosso, nel Sud”.
Ma pur attuale e iperrealista, “il momento dell’autostrada” per paradosso riconduce a un’estetica percettiva potente, che quasi si bagna nelle malie e nei trasalimenti di un nuovo Grand Tour: “Ecco, se proprio si deve dire qualcosa di questa strada è che sicuramente si tratta di una delle strade più belle d’Italia. Una bellezza di cui pochi, però, sembrano accorgersi. La bellezza è invisibile. O meglio, la bellezza è così troppo visibile che non riusciamo a vederla. Il viaggio a Sud comincia con una bellezza quasi insopportabile”.
A bordo di questa strada, insiste Cimatti, ci si inoltra in una “caratteristica distintiva della bellezza”. Simile a quella che poi da secoli rappresenta in emblema lo stigma della differenza antropologica che connota agli occhi del viaggiatore il paesaggio del Sud, lo spazio naturale in cui questa stessa infrastruttura surmoderna è ancora oggi assorbita essenzialmente. Per Cimatti questa è la strada maestra che conduce alla visione di una bellezza flagrante, esorbitante a tratti, e tuttavia sempre “elusiva e timida”. Qualcosa che a prima vista sfugge, che “Non si lascia vedere, appunto. In effetti quando si parla dell’autostrada A3 (o A2 o ancora Autostrada del Mediterraneo), di questo aspetto – che è assolutamente il più evidente – non si parla mai. Eppure è appunto evidente, basta percorrere pochi chilometri in direzione sud dopo Battipaglia, e comincia l’avventura di una strada straordinaria, che attraversa spazi incredibilmente privi di tracce umane, montagne, boschi, azzurri infiniti, il nero profondissimo del cielo invernale; e poi c’è il profumo dei prati e dei boschi, che in primavera entra nell’automobile. Per non parlare degli animali, topi, cani, volpi, cornacchie che si spingono, soprattutto di notte, fin dentro il nastro d’asfalto. Una strada che non si vede, ecco cos’è la Salerno-Reggio Calabria”.
“Ma di che tipo di bellezza si tratta?” si interroga Cimatti a un certo punto del suo ragionamento figurato sulla metafisica della A2. “È interessante che la Salerno-Reggio Calabria non sia affatto bella per chi vive nelle regioni del Sud (per intenderci, Campania, Basilicata e Calabria), che anzi vede nella sua presunta incompletezza…, la rappresentazione evidente di una persistente arretratezza meridionale: l’A3 è bella per chi viene dalla A1, ad esempio, per chi viene dal Nord. Si tratta allora di una bellezza di secondo grado, se può esistere qualcosa del genere. Non è la bellezza di un Sud incontaminato e naturale contrapposto a un Nord inquinato e artificiale, per intendersi”. È, infatti, una bellezza percepibile solo nel dissidio caotico e distruttivo della nostra modernità, dice Cimatti: “Quella della A3 è piuttosto una bellezza che si può vedere solo se, prima, si è passati per uno scenario completamente diverso (non è una strada che possa piacere a un logico, ma forse nemmeno a un poeta; per la A3 ci vuole un logico che sia anche un poeta)”.
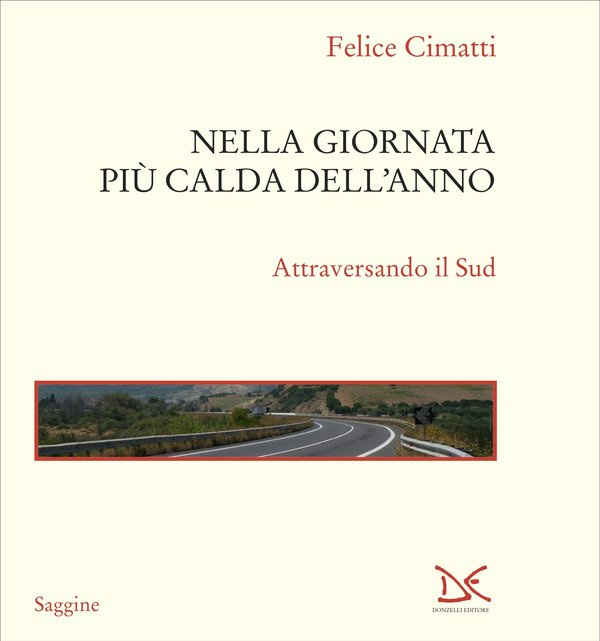
Per altri versi l’autostrada per il Sud mostra, ma solo a chi sa coglierlo come fa Cimatti, il suo profilo bifronte. Disvela un suo volto ippocratico: percorrere “la Salerno-Reggio Calabria significa esporsi a una vera e propria «crisi della presenza», come la definisce l’antropologo Ernesto De Martino. Si tratta dell’esperienza che si vive quando ci si accorge che il «proprio» mondo – i suoi valori, la sua lingua, la sua storia, il suo dio – non c’è più, è finito, sorpassato da tempi così nuovi che forse in realtà sono antichissimi. Ecco, l’A3 produce uno spaesamento simile: se si alza lo sguardo dal volante e dall’asfalto ci si accorge che ci si trova in un altro mondo. «Crisi della presenza», appunto, dove mi trovo?”. E poi, che ci faccio qui? Che è spesso la domanda che mi interroga quando, come Cimatti e differentemente da lui, da nativo, e da residente, spesso sia pure impermanente, sono io a percorrerla più o meno con gli stessi effetti impressi sul mio stato di coscienza.
Il fenomeno fondamentale che questa strada squaderna ininterrottamente davanti a chi la percorre con i sensi e la mente vigile, è la scoperta (meglio la riscoperta) di una realtà retorica e antiretorica allo stesso tempo: “È la prima scoperta, a Sud: le parole non ci servono più. Le domande sono più delle risposte e restano lì appese ai bordi della strada come cartelli indicatori di direzioni per svii e luoghi sconosciuti. “Il Sud, nonostante sia spesso rumorosissimo, è silenzioso. Il viaggio comincia, e in realtà è già finito, perché se si viaggia per fare esperienza, e quindi per poterlo raccontare, del viaggio a Sud non c’è niente da dire. Basta il Sud, e il rumore di fondo del motore della macchina. È l’unico rumore che ascolteremo per molte ore, fino a Cosenza”.
Anche in queste parole scelte da Cimatti si colgono echi di ritorno. Sono quelli di uno nuovo Grand Tour, che ci presenta però, nella discordia dei tempi della tecnica, nella radicalità rivelativa di un dissidio di coscienza, dentro un trasalimento favorito e colto dall’irreprensibilità di un luogo che resta radicalmente altro: “il Sud, “per me, non è altro che questa dimenticanza piena di stupore e sorpresa, una dimenticanza che si ripete ogni volta. Forse è per questo motivo, in realtà, che viaggio verso il Sud, perché non posso rinunciare a questa dimenticanza”.
Il suo “È un viaggio che non è un viaggio”; in realtà mossi sul nastro d’asfalto “rapidamente ci si accorge che non è importante dove si sia diretti… ma è importante il fatto che ci si trovi proprio sulla A3, Salerno-Reggio Calabria. Ero di nuovo in macchina, verso sud, sulla A3, appunto. Ma l’A3 non esiste più... Percorrendo l’autostrada e i territori che attraversa, infatti, si possono trovare cartelli stradali che – riferendosi alla stessa strada – riportano sia la scritta «A3» che «A2»” La A2 è una strada che oltre ogni evidenza resta avvolta dalla metafisica del nomos, celata nel mistero che in fondo è il destino di tutte le strade: “all’inizio di tutte le storie c’è sempre una specie di afasia, c’è una parola che non riesce a cogliere quello che si sta vivendo. Ci vuole tutto un giro tortuoso per comprendere che questa mancanza è quanto di più prezioso ci sia, e che si tratta di una mancanza non solo da non riempire con un nome ma, al contrario, è una mancanza da preservare, da custodire”.
C’è poi questa dimensione aggiornata e sensibile della demartiniana «crisi della presenza» a cui allude costantemente l’intero racconto stradale di Cimatti. Quella di uno stato in luogo della coscienza di sé e del mondo che oggi è ovunque dislocato, continuamente mutevole e spaesato: “è lo stato che si prova sulla soglia che contemporaneamente unisce e separa i due modi fondamentali di stare al mondo: da un lato quello abituale e familiare, quello di chi si ritrova e riconosce nel mondo umanizzato (e rettificato),… e dall’altro quello di chi, improvvisamente, non riesce più a comprenderlo e a ritrovarcisi. È la stessa strada, eppure è una strada completamente diversa, tortuosa e stranamente poco trafficata. Non è cambiato nulla, eppure ci accorgiamo che ci troviamo in un posto molto diverso da quello in cui eravamo fino a pochi minuti prima. La peculiare bellezza della A3 va compresa in questo contesto, come momento di passaggio che non riguarda tanto il luogo in cui ci si trova quanto il modo in cui quel luogo viene sentito”.
Un cambio di velocità e di scena impresso al paesaggio del Sud, di cui si era già precocemente accorto, a modo suo, Pier Paolo Pasolini, in un reportage automobilistico raccontato alle soglie del boom dei primi anni ‘60, La lunga strada di sabbia, quando scrive: “... per le lunghe vie parallele al mare – mi stupiva la dolcezza, la mitezza, il nitore dei paesi sulla costa... Poi si entra in un mondo che non è più riconoscibile”.
Questo fenomeno criptico e mutageno è accaduto ulteriormente a dipartirsi dalla A3, il cui congegno prepotente e dominante viene perfettamente demarcato, anzi precisamente pantografato dalla Campania alla Puglia, fin sotto lo Stretto di Messina e poi risalendo per tutto il giro della penisola calabrese, dal percorso semicircolare segnato dal collegamento con altre due strade capitali del Sud; la statale 18 tirrenica e della 106 ionica. La A3, la SS18 Tirrenica e la SS106 Ionica sono oggi i terminali di un intrico di strade inquiete, il cuore di un sistema di vasi e di nervature che descrivono l’andamento vitale di una terra vasta e travagliata, irredenta, vitale, caotica. La realtà che vi scorre ai lati è una specie di geroglifico sociale, una mappa microscopica e microfisica che attende ancora di essere misurata, decifrata e narrata nei suoi più ambivalenti e irrevocabili significati e rapporti.
L’autostrada A3, che col cambio di nomenclature ora è “A2 del Mediterraneo”, è senza dubbio la summa di questo nuovo dispositivo geografico; questa strada maestra è la nuova regina viarum, l’architrave del paesaggio contemporaneo; impone le sue leggi e le sue servitù in lungo e in largo, lontano e vicino. Le lunghe strisce di asfalto che uniscono i centri più intensamente abitati dalla Campania sino alla Calabria tirrenica, sono oggi la traccia più fedele di regioni e di un paese irrisolto, destinati a rincorrersi con l’A3 nello specchio infranto del meridione contemporaneo. Intorno si è formato un paesaggio anodino e spiazzante, costellato di centri commerciali, suburbi acefali, teorie di seconde e terze case, discariche e cementifici. Tutte le marine si sono trasformate in slums ininterrotti e fatiscenti, con le spiagge sequestrate, i paesi della costa che dimenticano i centri storici e si riversano a vivere la vita effimera della stagione breve del turismo, che lascia in mezzo al deserto pochi e traballanti generi di conforto.
Usciti dal traffico compatto dei percorsi principali, dopo un lungo rigiro su un groviglio di strade secondarie, ormai poco trafficate, si ha spesso, come racconta Cimatti, la sensazione di trovarsi sciolti come sale nelle vene capillari di un’Italia fantasma. Si incontrano indicazioni minute e vecchi cartelli stradali che suonano, più che da indicazioni e da inviti verso nuovi orizzonti turistici, come targhe commemorative di comunità e di luoghi abitati ormai defunti o in lenta decezione. Il fatto è che accanto al tracciato della A3 sfila infatti tutto il vuoto e il pieno del Sud. Una mostra en plein air. Disordine, cantieri, interruzioni, traffico, paesaggi magnifici e orrori urbanistici, lentezza e supervelocità, paesini e città secondarie alternate a pericoli incombenti a ogni chilomentro. Da Contursi in poi, e dopo il Pollino, la risalita o la discesa del tratto appenninico della Salerno-Reggio C., per chi guida un mezzo a motore fino allo Stretto di Messina, è ancora una fatica epica, una prova degna di un’ordalia medievale.
Queste arterie illuminate implacabilmente dal sole e dalle ombre meridiane sono diventate negli ultimi decenni anche le strade del turismo, delle grandi ed effimere migrazioni automobilistiche stagionali verso le vacanze e il mare. Del resto, come osservava Marc Augé, di questi tempi “l’uomo scopre di appartenere alla natura proprio quando deve fuggire dai luoghi che aveva concepito per dominarla”.
Ogni cosa, ogni possibile opzione, viene presentificata, mostrata appunto dalla strada. La strada è il regno dell’impermanenza, ma ha la forza dell'evidenza: pannelli pubblicitari, indicazioni da e per mete e monumenti che per chi guida restano per lo più allo stato di intenzione, di pura nominazione. Dalle corsie meridiane della A3 si vede e si tocca già l’Africa, l’Algeria, i Balcani, il Mediterraneo, l’Oriente, il Mondo.
In certi tratti dalla A3, nota bene Cimatti, il paesaggio rilasciato dopo i lavori di completamento del tracciato appare più lustro di prima, più ordinato, risarcito da poco, rimpolpato, ma in un modo che sembra più definitivo, e persino lussuoso. Qualche volta il tracciato solenne e tormentoso della Salerno-Reggio C. che sfocia in quello della Statale 18 incorniciando il Tirreno azzurro, o in quello collinoso e desertico della SS 106 Ionica, che si inoltra in un interregno piatto e collinoso tra Calabria, Basilicata e Puglia in cui la strada incontra invece plaghe in cui tutto può apparire ancora semi-immobile, ancestrale. Ci si inoltra in ridotte di territori che sembrano dissimulare ancora le entità di un tempo remoto, e su cui aleggia un segreto genius loci. Il segreto invisibile delle rovine e di un paesaggio in cui l’antichità e il mito scorrono quasi indifferenti a tutto e senza interruzioni. E come nella vena di un fiume carsico, i geni del luogo si fanno presenti affiorando a intermittenze, nonostante la disdetta dei tempi, e in ogni minuscola orma di vita e in ogni criptico anacronismo lasciato dagli arcani, i segni del passato ritornano in vita e si rifanno presenza. È in questi teatri della dialettica primordiale che gli ultimi geni del luogo si mescolano a sole, mare, ulivi e pietre calcinate dal sole e levigate dal vento dei secoli. Una scena che ha a che fare con il tempo puro, interiore, che è diverso dal tempo della storia: “Avevo sempre saputo che le rovine di Tipasa erano più giovani dei nostri cantieri e delle nostre macerie”, scriveva Albert Camus nel 1952, ponendo enfasi sulle trasformazioni incipienti che incominciavano a stravolgere l’ordine del paesaggio ereditato dalla storia e dai resti archeologici del tempo dei romani giacenti sulle rive algerine di quell’angolo generativo del suo Mediterraneo interiore.
Anche qui invece molti dei frammenti stradali colti dal viaggio meridiano di Cimatti si accorda solo apparentemente alla logica dell’evidenza. Risponde invece di una dialettica irrisolta tra l’eterno presente e il troppo pieno dei tempi della tecnica. E accade di capire che, più generalmente, anche le periodiche sostituzioni di questi manufatti, sono agli antipodi della rovina. Questi resti provvisori sono destinati infatti a ricreare una funzionalità continua del presente ed eliminano l’idea stessa di una persistenza alternativa del passato. Del resto come tutta l’architettura contemporanea, anche l’artificio delle strade e delle sue scorie durevoli, al tempo dei surmoderni non punta all’eternità, alla storia, ma al presente: un presente, tuttavia, insuperabile. Nulla anela più all’eternità di un sogno di pietra, ma il calcestruzzo di travi e piloni, corsie e campate autostradali mira ad assicurarsi un presente indefinitamente sostituibile, ri-marcabile, fungibile. Senonché poi, nel Sud, conclude fatalmente Cimatti, in quel luogo “che per noi è banalmente sole e mare, arriva la tempesta. Il mondo. La A3 rende il contrasto fra realtà umana e reale inumano particolarmente evidente, un contrasto che si mostra per chilometri e chilometri. La strada smette così di essere una strada, cioè uno spazio normalizzato, ed è sempre sul punto di aprirsi sul mondo, senza asfalto e barriere”.
Lo sapeva Campanella. A3, dove tutto si tocca, e dove “tutte le nature sentono”.
In copertina fotografia di Gabriele Basilico.







