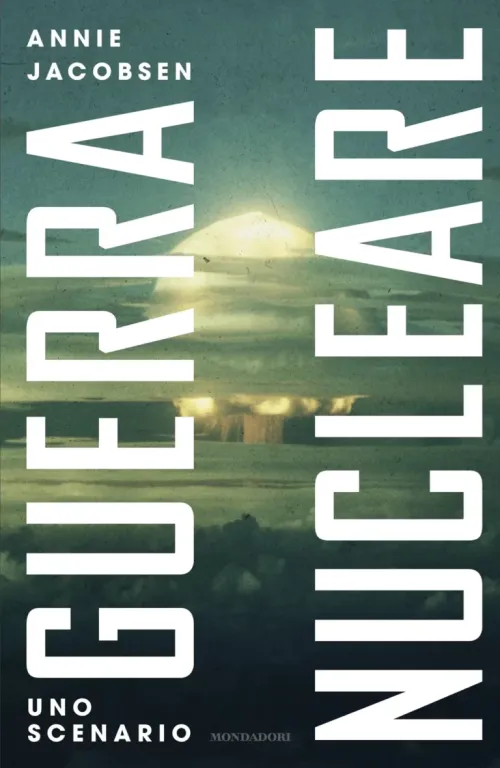A che ora è la fine del mondo?
“Un missile può essere un errore di interpretazione. Due no. La deterrenza non ha funzionato. È scoppiata una guerra nucleare, adesso. La maggior parte lo sa: questo è l’inizio della fine del mondo”. È l’ipotesi da cui parte Annie Jacobsen nel suo nuovo libro dal titolo Guerra nucleare, edito per i tipi di Mondadori.
La deterrenza in effetti è un dispositivo il cui asse portante è attivo e operante da oltre 70 anni. Era il 29 agosto del 1949, quando l’URSS si dotò del primo ordigno nucleare. Da allora ha cominciato a farsi strada il principio: mi doto di un’arma così devastante non perché intenda adoperarla davvero, ma per dissuadere il mio nemico dall’attaccarmi. Immaginate ora un antifurto eccezionale o un sistema antincendio particolarmente efficace … progettato e costruito però quasi tre quarti di secolo fa. Non si può dire che oggi funzioni meno bene: magari è anche rimasto efficientissimo! Ma è il mondo attorno che è cambiato, che si è mosso, che si è trasformato profondamente. Prima questo sistema era centrato sul bipolarismo tra Stati Uniti e Unione Sovietica: oggi sono almeno nove i paesi dotati di armi nucleari. Questo complica terribilmente il quadro: a sfidarsi non sono più due grandi colossi, ma potenze di calibro diverso e con caratteristiche interne fortemente eterogenee. Alcuni paesi sono anche grandi potenze sul piano economico, altri sono decisamente più modesti; in alcuni si respira una grande stabilità sul versante socio-politico, altri appaiono meno stabili; al loro interno vigono regimi radicalmente diversi; inoltre, alcune di queste nazioni hanno effettivamente visioni e dunque ambizioni che si proiettano su una scala globale, altre potenze sono regionali e dunque perseguono obiettivi assai più limitati.
Tutto questo finisce per modificare o comunque per alterare la valutazione di fattori come la credibilità della minaccia, i tempi e le modalità di impiego degli armamenti – ma più in generale, ciò che è mutato intimamente è la percezione del rischio. La teoria della deterrenza non è cambiata poi molto nella sua dottrina di base: a risultare assai più instabile è l’idea che le diverse opinioni pubbliche, nei vari paesi, hanno elaborato attorno ad essa.
Tra le possibilità che caratterizzano la nostra capacità cognitiva c’è anche il ragionamento per assurdo: su questo si concentra la Jacobsen, provando non a immaginare – bensì a spiegarci, con documenti alla mano – che cosa succederebbe in seguito a un attacco nucleare.
Le prime righe del capitolo intitolato “I primi ventiquattro minuti” sono inquietanti. I paragrafi iniziali ci parlano dei quattro decimi di secondo successivi al lancio, quando il sistema satellitare statunitense Space-Based Infrared System rileva i gas di scarico incandescenti espulsi dal missile termonucleare. E si va avanti per pagine e pagine sull’orlo dei secondi, mostrando come entrino in funzione livelli sempre più complessi di controllo, dal National Military Command Center alla Clear Space Force Station in Alaska. Insomma passano solo 3 minuti e 15 secondi dal lancio prima che il presidente degli Stati Uniti ne sia informato. Ma di fronte a tutto questo viene da pensare al vecchio libro di Gunter Anders, L’uomo è antiquato: si descrivono una serie di tecnologie, di tempi di reazione, di sistemi di controllo del tutto incompatibili col “nostro” modo di stare al mondo. Altro che uomo misura di tutte le cose: l’ipotesi di una guerra nucleare mette a nudo l’obsolescenza della forma-uomo!
Gli appassionati troveranno tutta una serie di dati assai utili per farsi un’opinione complessiva sulle proporzioni dei fenomeni di cui stiamo parlando. Facciamo qualche esempio: la bomba sganciata a Hiroshima aveva una potenza di 0,015 megatoni e uccise circa 80.000 persone sul colpo – più o meno altrettante morirono nei mesi successivi a seguito di ustioni e radiazioni. Già nel 1949 gli Stati Uniti possedevano 170 bombe atomiche di quel genere, ma nel 1952 fu inventata la cosiddetta Super, la bomba termonucleare, con un’energia esplosiva di 10,4 megatoni. Più o meno equivalente a 1000 bombe come quella sganciata a Hiroshima. È impressionante constatare come il sistema industriale statunitense fosse giunto a fabbricarne oltre cinque al giorno nel 1957, e circa dieci al giorno nel 1959. In vista di una guerra nucleare contro la potenza sovietica il piano elaborato nel 1960 prevedeva di scaricare su Mosca una potenza circa 4.000 volte maggiore di quella della bomba di Hiroshima. Una progressione che in realtà si arrestò poco dopo la crisi dei missili di Cuba: dalle oltre 31.000 bombe atomiche dei primi anni Sessanta, l’attuale arsenale statunitense è sceso a circa 5.000 nel 2020.

Forse ancora più interessante, rispetto al primo capitolo, dedicato ai primi 24 minuti, è il successivo, dedicato ai 24 minuti successivi: qui davvero tutto diventa più umano, forse troppo umano. Che cosa succede all’allevatore californiano che sta facendo pascolare i suoi animali in cima a una collina quando una bomba da 300 kilotoni esplode nei paraggi? Viene scaraventato a terra dall’urto; per fortuna non guardava nella direzione della bomba al momento della detonazione, altrimenti sarebbe rimasto cieco. Ora si volta, vede crescere la nube a forma di fungo, la filma col telefonino e posta il video su vari social. Tutto il mondo lo vede e si scatena il panico. Non ci sono contromisure: se si tiene conto della carica radioattiva che viene rilasciata nell’atmosfera da una bomba del genere, si tratta di abbandonare per precauzione una zona grande due volte il New Jersey.
Ma che cosa accadrebbe in un paese come gli Stati Uniti quando dovessero subire un attacco nucleare? Si mette in moto quello che in gergo governativo si chiama il “Programma”, che – come afferma Jacobsen – si basa su un concetto semplice e terrificante al contempo. Diamo pure per scontato che milioni, centinaia di milioni, miliardi di persone in tutto il mondo moriranno: ma, detto questo, “riusciremo a mantenere integro quanto basta del governo?”. La domanda centrale, l’unica che davvero conta in questo momento è la seguente: “il governo può ancora legalmente funzionare, a prescindere da quanto sia brutto ciò che accade?”.
Una delle azioni più rischiose, ma anche più vitali previste da questo scenario è il ripristino della deterrenza: malgrado il primo attacco nucleare sia stato sferrato, si può provare a dispiegare un contrattacco così schiacciante da spingere l’aggressore a capitolare, ristabilendo in questo modo – malgrado i danni già prodottisi e accumulatisi – la precedente situazione di deterrenza. Naturalmente questa opzione è pensabile soltanto se vi sia una effettiva sproporzione tra i due paesi belligeranti: qualora si tratti di due colossi, o s’inneschi una dinamica di contagio, l’opzione è impraticabile e ci si avvia verso la distruzione reciproca, tale da coinvolgere fondamentalmente anche il resto del pianeta.
Le domande si moltiplicano ed è difficile seguire tutti i fronti del problema. Per un verso abbiamo infatti la dimensione politico militare: la Jacobsen ci guida tra i vari protocolli, spiegando passo per passo l’interazione tra i rappresentanti democraticamente eletti e l’apparato militare. Si sofferma persino su uno scenario in cui la catena di comando sia saltata e dunque si avviano procedure per rimpiazzare rapidamente i vertici in modo che la macchina militare continui a funzionare. Dove si rifugia il presidente americano? E gli altri vertici? E i vertici militari e politici delle altre nazioni? D’altra parte, c’è invece il fronte della cosiddetta “povera gente”, che in questo caso sono letteralmente “tutti gli altri”: dove potrebbero trovare rifugio quote consistenti della popolazione? Oltre ai bunker, dove ci si può rifugiare? Quanto tempo si ha per cercare un rifugio?
Lo scenario che la Jacobsen decide di seguire è quello in cui la paura reciproca di essere attaccati – piuttosto che spingere i vari comandi politico-militari a evitare un’intensificazione del livello di scontro – fomenta invece risposte via via sempre più aggressive. Il conflitto partito dalla Corea del Nord verso gli Stati Uniti finisce per contagiare anche Russia e Cina: i sottomarini lanciano i propri missili, poi si immergono e scompaiono nell’oceano. Gli Stati Uniti sono pronti a riesumare la vecchia strategia: “o li usi o li perdi”. Quali sono i bersagli di questo attacco? Gli USA hanno identificato circa un migliaio di obiettivi su suolo russo: beninteso, la Russia ha fatto altrettanto. E poi c’è il ruolo che giocherebbero le basi NATO su suolo europeo.
Noi qui potremmo riempirvi di acronimi e parlarvi dei missili ICBM, del MIRV (Multiple Indipendently Targetable Reentry Vehicle), della EMP Commission, del Black Book e così via, ma tutte queste sigle assumono un senso soltanto all’interno della narrazione della Jacobsen: mano a mano, tutti i vari protagonisti entrano in gioco per svolgere il proprio ruolo. Ci soffermiamo soltanto per un attimo sulla cosiddetta “logica del re folle”: si ipotizza uno scenario in cui il leader di una potenza minore potrebbe decidere di scatenare un conflitto nucleare di proporzioni globali anche soltanto per riportare gli Stati Uniti ai tempi in cui non c’era la corrente elettrica. Vari fattori, come si vede, influenzano la tenuta complessiva della cosiddetta dottrina della deterrenza.
Da ultimo, veniamo a quelli che la Jacobsen definisce “i 24 minuti finali”. Il linguaggio stesso si trasforma: rimane una prevalenza di termini tecnici, ma in questo contesto cominciano a emergere elementi di carattere mitologico. Un capitoletto che descrive la situazione dopo 57 minuti dal primo lancio viene intitolato addirittura “Arrivano le ancelle dell’apocalisse”. Insomma, queste cose si possono spiegare solo fino a un certo punto: di lì in poi, come l’uomo ha sempre fatto, si può solo tornare a immaginare.
Bene, il conflitto è finito. La terra deve affrontare quell’orrore che in gergo si chiama “inverno nucleare”. Per via della polvere nera immessa nell’atmosfera – stiamo parlando di milioni di tonnellate – le temperature subirebbero un abbassamento drammatico. L’attuale calotta polare raddoppierebbe in estensione, le precipitazioni si ridurrebbero della metà, i sopravvissuti alle diverse detonazioni sarebbero comunque tutti contaminati da radiazioni. La dimensione della popolazione di Homo sapiens potrebbe tornare a livelli preistorici. La nostra civiltà verrebbe rasa al suolo in pochi minuti: “tutto quello che abbiamo appreso collettivamente e tutto quello che ci hanno trasmesso i nostri antenati diventerà mitologia”.
In fondo anche questo scenario, il peggiore possibile, rientra nella mitologia del terzo millennio ed è parte integrante non della teoria, non della dottrina, ma di una consapevolezza, di una opinione diffusa, di un sentire comune che in realtà alimenta ciò che chiamiamo deterrenza.
Leggi anche
Marco Belpoliti, Nagasaki, Papa Francesco, Yamahata
Yosuke Taki, Sognando l'atomo
Giuseppe Previtali, Le icone di Hiroshima
Arianna Salatino, Abbiamo davvero già visto Hiroshima?
Claudio Castellacci, Hiroshima: il peso di non sapere
Laura Testaverde, Un Nobel contro l'atomica
Anna Maria Mariani, La bomba atomica e la sindrome del bystander
Carlo Oagetti, Noi, la fantascienza e la bomba atomica