Il potere del capitalismo digitale
Di fronte alle ricadute quotidiane del capitalismo digitale espresse dalle sue piattaforme tecnologiche, spesso leggiamo un richiamo al “pensiero critico” per opporci alla retorica della Silicon Valley. Ma in cosa consiste questo pensiero critico così tanto mitizzato? Verso cosa dovremmo indirizzare la nostra critica?
Spesso trovo che la critica a queste piattaforme viene indirizzata verso i temi “sbagliati”: la paura degli effetti di dipendenza psicologici, la paura che queste piattaforme ci “distraggano” dal fare attività più rilevanti e socialmente accettabili come leggere un libro, la paura che diffondano fake news e ci facciano il lavaggio del cervello… ecc.. I sociologi dei media come me credono che queste paure siano sovrastimate, che siamo di fronte al rinnovarsi di un nuovo panico morale che periodicamente colpisce la nuova tecnologia di turno. Ma non siamo certo dei tecno-ottimisti, tutt’altro. Solo che secondo noi la nostra critica dovrebbe occuparsi di problemi più rilevanti, come il “Potere” che queste aziende detengono, o il tipo di lavoro precario che generano, o il regime di estrazione del valore economico a cui aderiscono. Al potere di manipolazione delle menti individuali (molto dubbio ed empiricamente difficile da provare), preferisco l’indagine del potere economico e politico che queste aziende esercitano.
Su questo crinale critico, interventi come quelli pubblicati dal numero 407 di Aut Aut, Digito ergo sum. Indagini sul capitalismo digitale curato da Marco Pacini (Il Saggiatore, 2025) sono più che benvenuti, perché si interrogano esattamente su queste questioni.
L’attuale numero prosegue un percorso di indagine critica sull'intelligenza artificiale e le sue ricadute sociali, già avviato nel 2021. Se allora l'interrogativo era "come pensa la macchina?", oggi l'urgenza si sposta sul potere totalitario detenuto da un ristretto numero di compagnie private che governano gli strumenti-agenti del capitalismo digitale. Il fascicolo si propone di analizzare questi processi con uno sguardo che tiene insieme il passato recente, quando "l'emergere di un potere del capitale senza precedenti ci è passato sotto gli occhi senza che ce ne accorgessimo", e un futuro in cui le derive più tossiche del progresso possono essere arginate solo con "i vecchi arnesi del pensiero critico".
Il numero raccoglie una serie di contributi che, da diverse prospettive, delineano i contorni e le implicazioni del capitalismo digitale.
Edoardo Greblo in "Il capitalismo digitale. Uno sguardo d’insieme" offre una definizione organica del fenomeno, identificandone tre pilastri innovativi: la piattaforma come forma organizzativa, i big data come risorsa primaria e l'intelligenza artificiale come strumento decisionale automatizzato. Greblo sottolinea come le piattaforme non siano intermediari neutrali, ma "strutture normative" che creano e modellano nuovi mercati, esercitando un controllo radicale attraverso la cooptazione del comportamento degli utenti. Questo potere si basa sull'estrazione di dati, che diventano una forma di capitale essenziale per ottimizzare la produzione e prevedere i comportamenti futuri. L'autore conclude evidenziando le profonde asimmetrie di potere e la necessità di un intervento politico per riequilibrare i rapporti tra le Big Tech, gli Stati e i cittadini.
Juan Carlos De Martin, nel suo saggio "Sulla computerizzazione del mondo", traccia una genealogia storica del computer, dall'ENIAC del 1946 alla sua mimetizzazione odierna in oggetti e spazi smart. L'autore evidenzia il passaggio da una computerizzazione palese a una opaca e invisibile, in cui dispositivi come lo smartphone diventano strumenti di sorveglianza continua e capillare. Questa raccolta dati senza precedenti conferisce alle Big Tech una conoscenza non solo degli individui, ma della società nel suo complesso, creando un'eccezionale concentrazione di potere tecnologico, finanziario e digitale che minaccia le democrazie e configura un vero e proprio "colonialismo digitale".
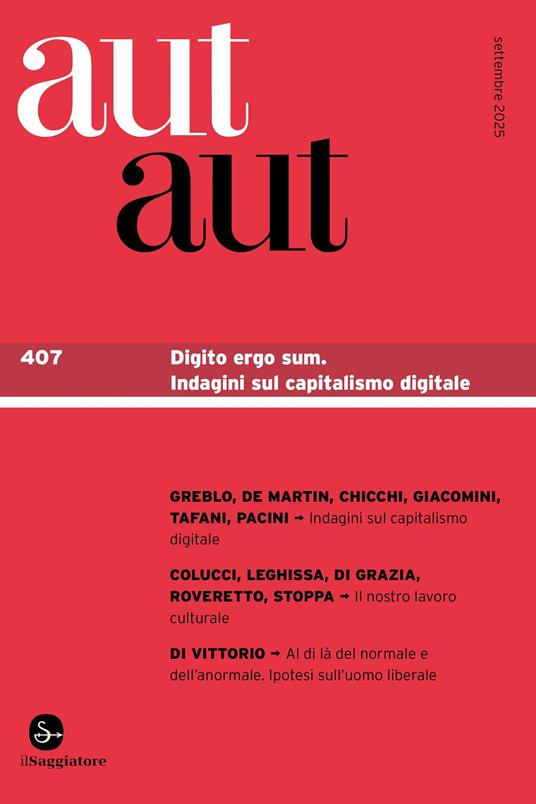
Federico Chicchi, in "Soggettività impreviste", analizza il concetto di governamentalità algoritmica, una forma di potere che abbandona la norma e la soggettività per basarsi su una razionalità operativa e predittiva. Questa razionalità non ha bisogno di senso, ma funziona attraverso correlazioni e semiotiche a-significanti che agiscono direttamente sui corpi e gli affetti. Tuttavia, citando il lavoro di Luciana Parisi, Chicchi introduce l'idea di un "ignoto computazionale": un limite interno al calcolo che non è un fallimento, ma un'apertura a possibilità non previste. È in questa "piega" o "glitch" che possono emergere soggettività impreviste e forme di agency ibrida, non contro la macchina, ma all'interno delle sue stesse operazioni.
Altri contributi arricchiscono il quadro. Daniela Tafani rilegge il potere delle Big Tech attraverso la lente del feudalesimo, sottolineando come queste reintroducano relazioni di potere assolutistiche e agiscano come "governi privati". Marco Pacini parla di un "capitalismo millenarista", animato da un'ideologia tecno-utopista che, dietro la promessa di progresso, nasconde derive totalitarie e antidemocratiche.
La lettura di questo denso numero di Aut Aut è un esercizio di pensiero critico non pigro, che fa emergere nel lettore una consapevolezza profonda del paradigma economico, sociale, politico e culturale inscritto nelle logiche del capitalismo digitale. Gli autori fanno un ottimo lavoro di traduzione per il pubblico italiano di diversi contributi teorici internazionali. Da un lato è “sorprendente” quanto, pur inconsapevolmente, filosofi politici e della scienza, sociologi del lavoro, dei media o della politica stiano convergendo verso analisi molto simili pur rimanendo confinati nei silos delle proprie comunità accademiche. Questa convergenza significa che, da qualunque prospettiva lo si guardi, il capitalismo digitale è stato ormai già ampiamente decostruito collettivamente, almeno sul piano della critica, e questa critica è rivelatoria, per chi vuole ascoltarla.
Dall’altro lato però, noto anche quanto ancora le nostre discipline umanistiche e sociali devono dialogare tra loro affinché questa convergenza diventi consapevole. Nel mio campo di studi ad esempio (media studies), gli studiosi di economia politica critica della comunicazione e i sociologi dei media digitali come quelli dei cosiddetti e recenti “critical algorithm studies” e “platform studies” hanno ormai da tempo messo in evidenza le caratteristiche estrattive e coloniali del capitalismo digitale. Per uno studente magistrale di un corso di Comunicazione (la tanto vituperata Scienze della Comunicazione) questo numero di Aut Aut non presenta novità sconvolgenti che non abbia già sentito da qualche suo docente o in qualche saggio obbligatorio per l’esame. Autori come Tarleton Gillespie, Nick Couldry, José van Dijck, Thomas Poell, Mark Graham, Mark Andrejevic, Kate Crawford, Dave Hesmondhalgh o Deborah Lupton, per citarne solo alcuni dei più popolari, hanno da almeno quindici anni (il saggio di Tarleton Gillespie sulla politica delle piattaforme digitali è del 2010) messo in evidenza le caratteristiche neoliberali ed estrattive del capitalismo digitale.
Per certi versi, sono critiche ormai molto consolidate, e, come vediamo, sono diffuse con vocabolari leggermente differenti in più discipline affini tra loro. Sarebbe utile quindi che ci fosse più dialogo tra queste comunità, e meno diffidenza, nel condividere i propri dizionari e renderli accessibili anche a pubblici più ampi.
La lettura di questo numero non solleva solo questioni relative a quanto sia ormai saturo e condiviso il campo della critica al capitalismo digitale e a quanto ancora i diversi “critici” siano divisi tra loro – una questione forse noiosa che riguarda solo gli studiosi – ma solleva anche un’altra importante questione: una critica completa del capitalismo digitale può fermarsi alla diagnosi molecolare del potere da esso esercitato?
Quando nel 2019 ho iniziato, insieme ad Emiliano Treré, a lavorare al libro che è poi diventato Algoritmi per Resistere (Mondadori 2025, ed. or. MIT press 2024), avevamo già chiaro quanto fosse fondamentale integrare e completare questa critica con un’analisi etnografica delle frizioni generate dal basso a questo potere digitale, per questo, nei saggi di questo numero, trovo due possibili temi problematici (e lo dico solo per stimolare un dibattito più ampio, riconoscendone il valore critico e analitico).
1. Il Potere monolitico e il rischio dell'oblio dell'Agency
I contributi di Aut Aut descrivono con grande lucidità un potere algoritmico pervasivo, opaco e totalitario. Greblo parla di un potere strumentalizzante "senza precedenti"; De Martin descrive un controllo capillare e centralizzato nelle mani di un duopolio; Pacini evoca un capitalismo totalitario che rende "invisibile l'unidimensionalità del governo algoritmico". Questa rappresentazione, pur accurata, rischia di cadere in quella che nel nostro libro definiamo la trappola di una visione "monolitica del potere algoritmico", che tende a non considerare le forme di agentività e di resistenza.
Come afferma Sonia Livingstone, una critica focalizzata unicamente sul potere delle piattaforme rischia di sottovalutare "i pubblici e il significato del mondo della vita". Il nostro lavoro sul campo dimostra che, sebbene le relazioni di potere siano incredibilmente asimmetriche, esse sono anche dinamiche, contingenti, socialmente costruite e costantemente rinegoziate. Le analisi di Aut Aut descrivono brillantemente la struttura, ma la nostra ricerca mostra come questa struttura sia continuamente plasmata e sfidata dall'agency degli utenti.
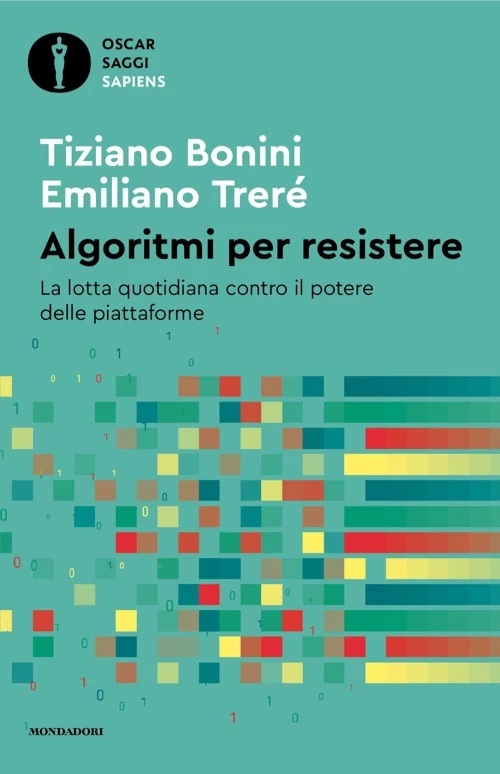
2. La "Governamentalità Algoritmica"
Il concetto di "governamentalità algoritmica" di Chicchi, che opera "al di sotto del livello di coscienza" e disattiva la soggettività, è uno strumento teorico potente. Chicchi sostiene che:
“il potere pare non esercitarsi più sulla base di leggi o di norme esplicitamente formulate, ma attraverso complessi dispositivi algoritmici e computazionali che operano al di sotto del livello di coscienza e, in ogni caso, al di fuori di ogni tradizionale deliberazione politica. Il profiling algoritmico è in tal senso la figura emblematica di questa modalità di potere. L’individuo non è più rappresentato, non è più un soggetto da conoscere, giudicare o correggere, viene trattato come una matrice di dati, come una somma di tratti e segnali da correlare con altri. La soggettività, in questo scenario, viene disattivata come moderno agente morale e trasformata in un nodo operazionale all’interno di un’efficiente rete di previsione e ottimizzazione delle condotte.” (p. 40).
Questo punto di vista che vede la soggettività umana disattivata da un potere che opera sotto il livello di coscienza richiama da vicino la prospettiva comportamentista di Shoshana Zuboff, secondo la quale le infrastrutture algoritmiche rendono il comportamento umano non solo completamente prevedibile e gestibile, ma anche automatizzato, grazie a un ordine digitale che prospera tra cose e corpi, e che trasforma la volontà in rinforzo e l’azione in risposta condizionata.
Ma è davvero così?
Le nostre ricerche empiriche ne mostrano i limiti pratici. I gig worker, i creator e gli attivisti che abbiamo studiato non sono affatto automi inconsapevoli. Al contrario, sviluppano una "consapevolezza algoritmica" attraverso un processo collettivo di reverse engineering, discussioni in chat private e la formulazione di "teorie popolari" sul funzionamento degli algoritmi.
Chicchi però riesce ad andare oltre questa visione monolitica del potere del capitalismo digitale, evocando il concetto di glitch nel sistema e riconoscendo in questi glitch uno “spazio fragile ma reale per poter pensare il politico a-venire”.
Il "glitch" o l'"ignoto computazionale" di cui parla Chicchi non è solo una possibilità teorica, ma un campo di azione pratica e quotidiana. È proprio in queste "crepe attraverso cui entra la luce" che si inserisce quella che chiamiamo "agentività algoritmica tattica": dai Surge Club degli autisti di Uber ai pod di Instagram, dalle tattiche di shuadan dei rider cinesi all'attivismo algoritmico che dirotta gli hashtag, alle forme di cooperazione tra lavoratori di piattaforma. Questi non sono soggetti "operati ma non interpellati"; sono attori che, pur con mezzi limitati, plasmano attivamente il risultato del calcolo algoritmico a proprio vantaggio.
Sebbene le finalità della governamentalità algoritmica siano evidenti, la cosa sorprendente è che questo processo di soggettivazione neoliberale operato attraverso la governamentalità algoritmica, non è efficace quanto le piattaforme vorrebbero. Sul piano speculativo possiamo anche teorizzare questa governamentalità, ma se ne osserviamo “sul campo” l’operatività, ci accorgiamo che i suoi successi sono parziali e situati e che questa governamentalità deve affrontare tutti i giorni enormi frizioni.
Conclusione: un Dialogo Necessario
Il numero di Aut Aut sul capitalismo digitale offre una critica teorica indispensabile, genealogicamente profonda e politicamente urgente. Ci mette in guardia contro un potere che, come scrive De Martin, si è fatto invisibile e pervasivo, e che, come avverte Pacini, coltiva sogni millenaristi e antidemocratici.
Tuttavia, dovremmo completare questa analisi senza fermarci alla denuncia del dominio di questa forma di potere. Come sosteneva Foucault, “dove c'è potere c'è resistenza". Le pratiche di resistenza algoritmica quotidiana, per quanto fragili e temporanee, non sono fenomeni episodici, ma atti ordinari che costituiscono il tessuto stesso della vita nella società delle piattaforme. Esse rappresentano un intoppo, o glitch, nel sistema, la prova che l'automazione del soggetto non è ancora riuscita e che la lotta è ancora in corso.
Un dialogo tra la critica teorica di Aut Aut e l'analisi empirica delle pratiche di resistenza è non solo utile, ma necessario. Permette di evitare tanto un pessimismo paralizzante quanto un'ingenua celebrazione dell'agency. Ci ricorda che, per quanto il potere delle piattaforme sia immenso, la storia non è ancora scritta: il suo esito "non è dato, ma agito".
Leggi anche:
Tiziano Bonini | Costi planetari / IA: né intelligente, né artificiale
Tiziano Bonini | Social media come imprese coloniali
Tiziano Bonini | Può l’intelligenza artificiale essere etica?
Tiziano Bonini | Traditi dal digitale
Paolo Landi | Algoritmi: resistere, resistere, resistere







