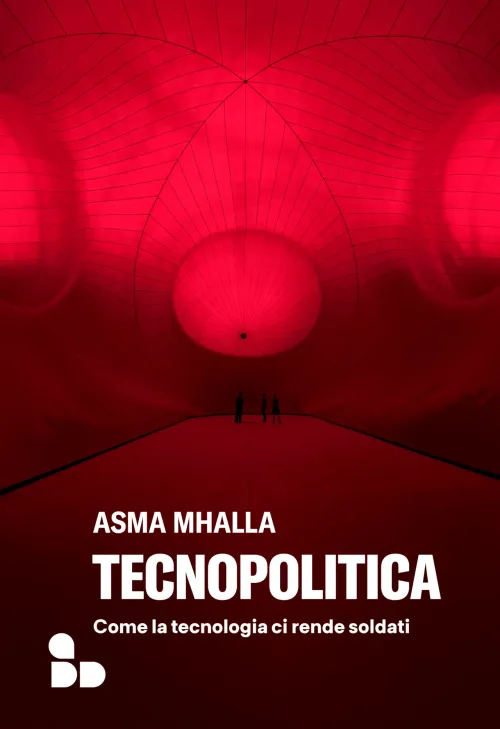Speciale
La palude
Dovremmo tornare ad attraversare lo spazio anomico di La palude definitiva di Giorgio Manganelli, incursione visionaria nell’immobilità del mondo. Che poi proprio immobile non è, ma, a modo suo, assapora i guizzi di una “vita minuta”: “Per tutta la palude scorre un sommesso crepitio, un viscido scorrere di membrane, un fruscio di rettili, un sommesso cicalio di bozzoli che si schiudono, il tremolio di ali invisibili”.
Quando ripenso a La palude definitiva mi colpiscono le date in cui probabilmente il libro è stato composto. Manganelli muore nel 1990, alla fine di maggio. La palude definitiva, che uscirà nel 1991, è l’ultimo dei suoi lavori, in via di revisione quando lo scrittore muore. Possiamo dunque immaginare che sia stato steso fra il 1989 e i primi mesi del 1990. Chi non ricorda l’effervescenza impaziente di quella stagione? Le masse che, dopo un lungo sottomesso letargo, tornano a rovesciarsi sulle strade. E fanno anche di più: a partire dai primi di novembre dell’89 i muri vengono abbattuti, provocando un tonfo assordante, che risuonerà in tutta Europa e nel mondo intero. Quel suono si propagherà per anni, polverizzando un’architettura di idee, che, fino a quel momento, avevano sostenuto pensiero e azione. Azzerata la storia, smaniava un nuovo inizio. Cose note, e più volte ripetute nel corso dei quasi quarant’anni che ci separano dagli avvenimenti del 1989.
Ora proviamo ad immaginare il nostro scrittore, che ha nutrito sempre pochi riguardi verso la realtà circostante, e niente affatto disposto a celebrarne i fasti; lo possiamo immaginare rivolgere uno sguardo ai diffusi strepiti dell’89, un colpo d’occhio riluttante, solo di sfuggita, di sbieco, forse imbronciato, se non addirittura infastidito. Non ha la protervia di collocare gli eventi nell’ordine di una qualsiasi rappresentazione, l’ordine non lo ha mai attratto, non lo interessa, preferisce assecondare il caotico flusso delle parole e delle immagini che in lui gorgoglia come una forza naturale.
Allora, semplicemente guarda; non si può dire che lo faccia in silenzio, perché, dalla sua osservazione, si dipanano rivoli di parole, che spesso s’ingrossano come impetuosi torrenti: “La mia vita ora è essenzialmente questo: osservare la palude dalla grande finestra del piano alto. La palude è sempre se stessa e tuttavia è sempre altro. Immersa in una luce instabile, un crepuscolo che allude alla sera e alla notte, talora all’alba e al giorno, la palude si copre di innumere forme”.
Affacciato alla “grande finestra del piano alto”, a ragionata distanza, Manganelli osserva la concatenazione degli eventi di quell’anno, 1989. Nel suo forsennato, liberatorio dinamismo, vede la rapida combustione del “possibile”. E, nel punto più alto della sua fiamma, un “lampo catastrofico” lo porta a constatare la “stanchezza del futuro”, proprio dove il “futuro” sembrava riprendere voce e vigore. Evidentemente, Manganelli non dà troppo credito alle rinnovate energie che, nervosamente, percorrono i giorni dell’89; in esse registra piuttosto la “febbre del disfacimento”, l’inflessibile avanzare di una “precipitosa entropia”. Ecco allora svilupparsi la bizzarra esistenza della “palude”, un geroglifico mentale estratto dal vasto repertorio dello scrittore, un agglomerato di forme, un accumulo di identità frantumate, luogo terminale, “definitivo”, ma, al tempo stesso, indefinita estensione.
Viene da considerare, ma sarebbe azzardato, la “palude definitiva”, e la sua “vita repellente e inesauribile”, come una variante letteraria della “fine della storia”, il verdetto pronunciato da Alexandre Kojève (“Il mondo e l’uomo non possono più muoversi”) alla metà degli anni trenta del secolo scorso. In La palude definitiva la Storia non è mai neppure cominciata.
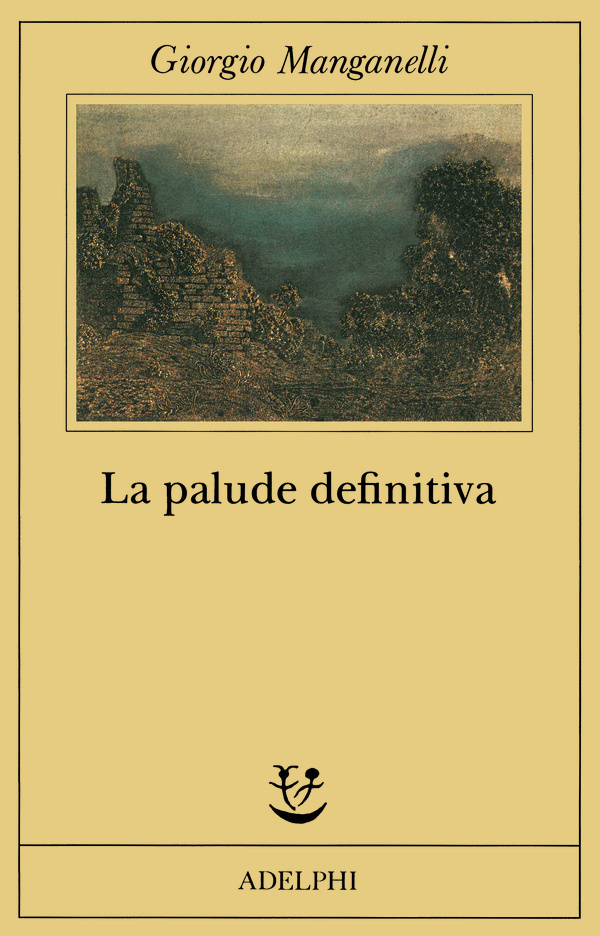
Il politologo americano Francis Fukujama scrive, nel ’91, La fine della storia e l’ultimo uomo, dove riprende il verdetto di Alexandre Kojève collocandolo a ridosso delle rovine ancora fumanti del muro di Berlino, dove i rumori della Storia, dopo un’ultima vampata, sembrano spegnersi. Per Fukujama non ci può essere più storia dopo gli eventi del 1989, ma quello che segue non ha il mortifero aspetto della immobile “palude” di Manganelli. Quella “fine” non corrisponde a un torbido degrado, putrefazione che avanza. Tutt’altro: ha, per Fukujama, lo splendido profilo della democrazia americana e del suo indiscusso trionfo su scala mondiale. È lì che la Storia esaurisce le sue forze, lì è il suo punto conclusivo.
Eppure l’idea dell’inizio non smette di sedurre, e forse di fuorviare l’esercizio del pensiero. D’altra parte, come rinunciarci? ““La Storia ricomincia da capo”, dichiara Asma Mhalla in Tecnopolitica, dove riflette sulle nuove frontiere della nostra esistenza collettiva, un bel libro, utile anche, perché capace di penetrare in ciò che più ci sfugge, quello che si estende ai confini della nostra vita artificiale, o “spettrale” come qualcuno dice, e della “tecnopolitica” che è il suo presupposto. L’uomo “diviene” o “muore”, osserva Asma Mhalla sulla scia di Nietzsche. Ma questo non può voler dire che tutta l’attrezzatura concettuale della cultura d’Occidente resti a disposizione del nostro “divenire”. No, qualcosa si è consumata strada facendo, molte parole del nostro lessico si sono svuotate. E Storia è una di queste. “Il cerchio del Tempo – scrive Kojève – non può essere percorso che una sola volta. La Storia finisce, ma non ricomincia più”.
D’altra parte, può l’idea di Storia resistere all’erosione dell’idea d’Occidente, al suo progressivo sgretolarsi? Può rimettersi in piedi, e “ricominciare” del tutto priva di un’immagine di Futuro, mentre la stessa idea d’Uomo va scemando. La Storia che conosciamo non è altro che la vasta epopea dell’umano, “peripezia” e “Nostos”. E questa epopea ora stenta a cantare le sue gesta. Questa epopea tace.
Non sappiamo, credo, come attraversare questo silenzio. In una sofferta passività (ma come superarla?) ci si può affacciare alla “grande finestra del piano alto” per osservare la “palude definitiva” che definitiva non è, perché inizio e fine, epilogo e compimento, non sono esattamente distinguibili. E incompiute le vite che l’abitano: bozzoli, minuscoli insetti, ali, membrane, e altro, un mondo minore che mormora nell’ombra, del tutto ignaro della presenza umana, i frutti forse di un’evoluzione interrotta o sviata, come se le creature che si agitano nel fango, si fossero affrancate dal ferreo dominio del suo disegno, senza tuttavia sapere a che cosa dar vita.
Della “palude” non si può stendere una “mappa”, segnare dei punti d’orientamento. Nella sua confusa cornice, la vita appare titubante, irresoluta, impacciata. E anche la sua origine sembra irraggiungibile, come liquefatta. Nel “brulichio sterminato” della “palude” tutto è in transito, nulla giunge al suo termine, e nulla riposa nel suo essere. C’ è soltanto vita che si prova, in un inesauribile esperimento. C’è il mondo che non si adatta ad acquietarsi, ma neppure prorompe, con strabordanti energie, in un improbabile inizio. Chiudendo il suo libro Asama Mahlla ricorda Raymond Aron (in Pace e guerra fra le nazioni): “Non possiamo saperlo, dobbiamo volerlo, abbiamo il diritto di sperarlo, e a noi resta ancora tanto da sperare”.
Leggi anche:
Maurizio Ciampa | Breve storia della nostra inerzia
Maurizio Ciampa | Tutti ciechi davanti alla fine
Maurizio Ciampa | Il rischio infinito
Maurizio Ciampa | Sonnambuli
Maurizio Ciampa | L’esitazione
Maurizio Ciampa | Vito Teti: il senso dei luoghi