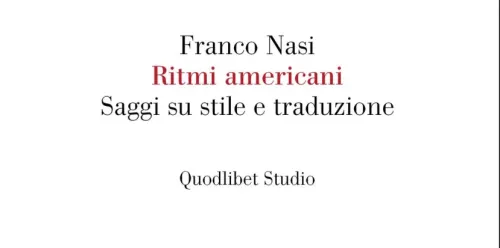Franco Nasi e l'elefante nel testo
L’ultimo libro di Franco Nasi, Ritmi americani. Saggi su stile e traduzione, uscito da poco per Quodlibet, dimostra come parlare di traduzione di testi letterari convochi al tavolo della discussione il nostro modo di vedere la letteratura, di concepire il passato e la tradizione, e di immaginare un futuro per i testi che amiamo. Occuparsi di traduzione non solo nella pratica, ma anche come ‘critici della traduzione’ significa in fondo porsi il problema di cosa della letteratura ci importa di più, se è vero che rientra tra le responsabilità di chi traduce non solo cosa tramandare e far circolare in un’altra lingua, ma anche come un testo del passato (recente o remoto) possa tradursi in una versione che resti viva e a disposizione dei lettori e delle lettrici a venire (con implicazioni anche di natura pedagogica, dunque).
Come ricorda Nasi (anzi ribadisce, e opportunamente, viste le resistenze generali) la traduzione è un esercizio creativo che chiama in causa il rispetto della tradizione (da intendersi più che in senso fideistico, come conoscenza attiva, non solo ereditata, della tradizione), ma soprattutto il ricorso all’invenzione, necessaria per destreggiarsi tra gli ineludibili scarti tra le lingue. È forse questo della creatività di chi traduce uno dei punti su cui più spesso s’incaglia il discorso sul lavoro della traduzione: sotto il vessillo della fedeltà, che ha il vantaggio di occultare in sé una certa ottusità ideologica e una vibe moralistica (e persino misogina, se si pensa al mito delle belle e infedeli), sfilano infatti giudizi sommari di chi reclama una maggiore adesione al testo, in nome di un’idea presuntamente oggettiva (e astorica) di quel testo. L’attenzione si concentra sulla mera rilevazione della mancata corrispondenza dei codici linguistici, senza lo sforzo di analizzare le strategie macrotestuali o di compensazione con cui chi traduce tenta di restituire gli aspetti che emergono dalla lettura approfondita del testo, come ritmo, tono, voce, stile, che sono il vero centro dell’espressione letteraria e dunque dell’impresa traduttiva (come ampiamente sottolineato dagli studi di Meschonnic, Buffoni, Cavagnoli, Terrinoni, tutti citati nel volume).
Proprio dal concetto di ‘ritmo’ prende le mosse Nasi, che sin dal titolo gioca con i ‘ritmi americani’ – i generi musicali che arrivarono in Europa tra fine ’800 e gli anni ’60 del ’900, modificando radicalmente le linee melodiche della tradizione musicale italiana – per addentrarsi in sette casi di traduzione di autori americani e analizzarne il ‘ritmo’, qui inteso in senso ampio come le peculiarità stilistiche dei testi, la loro marca individuale, la loro impronta digitale. Sette casi che spaziano dal romanzo al teatro, dalla poesia alle canzoni popolari, per mettere a fuoco problemi di resa che coinvolgono questioni formali e culturali. Dopo la ricca introduzione sullo ‘stile’ della traduzione su cui tornerò, siamo accompagnati nelle avventure traduttive dei ‘reticoli vernacolari’ in Le avventure di Tom Sawyer, di cui si passano in rassegna le maggiori traduzioni italiane: da quella di Tito Dambria del 1939 alla traduzione di Celati del 1979, e fino alle versioni di Stella Sacchini del 2016 e alle due commissionate a DeepL e Google traduttore nel 2023, che aiutano a individuare tendenze diffuse e discusse nei vari capitoli, come la chiarificazione (quando il testo è opaco), la nobilitazione, la semplificazione, ma anche le nuove tendenze di standardizzazione della lingua di arrivo dei traduttori automatici. In questo caso, come sottolinea Nasi, se è la lingua parlata dei personaggi una delle grandi innovazioni stilistiche di Twain, allora è soprattutto su questo che si gioca la partita – tra i due poli dello straniamento e dell’“assopimento normalizzante” – di una traduzione “che sia viva, e che non rinunci a tentare di restituire, ricreandola, la peculiarità letteraria e la valenza estetica del testo fonte” (61). Si prosegue con un viaggio, o un’escursione, attraverso le riflessioni sulla scrittura e sulla traduzione di Gianni Celati, figura imprescindibile della storia delle traduzioni in Italia, di cui Nasi analizza in particolare le traduzioni da Twain e London, rispettivamente del 1979 e del 1986, utili a registrare “un significativo cambiamento nello stile celatiano” (68) riscontrato dalla critica anche nella sua produzione narrativa. Di ambito poetico, invece, sono i due capitoli successivi, dedicati (il quarto) alla resa, nella metrica italiana, dell’innovativo ritmo psichico di Whitman e a quello all’opposto ‘quasi invisibile’ di Mark Strand (il terzo), che offre l’occasione per ribadire che “non c’è niente di più insidioso […] che rendere in traduzione l’apparente semplicità di una poesia priva di vincoli formali evidenti” (89). Vere e proprie sfide-limite sono quelle raccontate nei capitoli seguenti: dai tentativi di restituzione in italiano di un testo poetico estremo di Edgar Allan Poe - un oscuro acrostico obliquo che nasconde il nome della donna a cui la poesia è dedicata -, alla ritraduzione in italiano di passi di Malatesta che Pound aveva tradotto in inglese e inseriti come lacerti nel Canto VIII, fino alle traduzioni italiane di A View from the bridge di Miller che sin dal titolo pone problemi traduttivi (vista, veduta o sguardo?). Infine, l’autore si congeda con un’appendice sulle cover, che implicano un’attenzione ancora maggiore ai vincoli relativi al ritmo nella resa traduttiva delle canzoni.
C’è, come si vede, molta carne al fuoco, ma è possibile forse individuare la centralità di due questioni diverse ma complementari che, presentate nell’introduzione, attraversano l’intero esercizio critico di Nasi: la necessità, da parte di chi traduce, di mettere a fuoco lo stile del testo, usando il processo traduttivo come strumento interpretativo; e la necessità per chi traduce di inventare uno stile come risposta coerente e consapevole all’analisi stilistica effettuata. Può suonare quasi come una banalità annoverare tra i compiti di chi traduce l’invenzione di uno stile ma è forse un aspetto problematico in una cultura traduttiva come quella italiana che, a parte rari casi, appare ancora legata all’idea dell’invisibilità del traduttore. Un’invisibilità spesso editoriale (l’omissione del nome dalla copertina lo attesta), ma direi soprattutto sostanziale, se nel complesso gode di ottima salute il luogo comune secondo cui il traduttore letterario è bravo se si annulla, si nasconde, diventa trasparente, in modo da non inficiare o corrompere l’integrità dell’originale mettendoci del suo.

E qui, per una volta, il confronto con l’intelligenza artificiale è utile: se la traduzione letteraria è infatti mera decodifica e ricodifica di codici linguistici, al punto che nessuna traccia deve restare del passaggio interpretativo di un umano, possiamo serenamente consegnare il futuro della traduzione letteraria a un dispositivo tecnologico ben congegnato. Ma se questo non è possibile per molti motivi – perché le lingue sono organismi viventi che mutano e non parallelo, perché lo stile di un autore o autrice consiste in uno scarto sempre imprevedibile e divergente dalla norma (come insegna Spitzer, più volte citato nel volume) che solo un altro umano può restituire inventando efficacemente nuovi scarti e divergenze, ecc. –, converrà allora riconoscere l’elefante nella stanza: ovvero che quando leggiamo un autore o un’autrice in traduzione stiamo inevitabilmente (e non come effetto collaterale, ma come presupposto di esistenza) leggendo la voce del traduttore o della traduttrice, o meglio stiamo leggendo lo stile che hanno inventato, coerentemente con la propria interpretazione del testo, per restituire la voce dell’originale.
E poco o nulla cambia se chi traduce è scrittore in proprio: anche le cosiddette traduzioni di servizio devono scegliere uno stile, perché (per fortuna) una lingua neutra, tanto più in letteratura, non si dà, e se si è scelto uno stile dimesso “con il freno a mano tirato” (per citare un’immagine molto opportuna usata da Nasi a proposito di Whitman nel volume), non è affatto un ‘buon servizio’ quello che si sta facendo al testo letterario. In questo modo, infatti, il testo tradotto resta in un limbo, mai traghettato davvero sulla sponda che dovrebbe ospitarlo ma lasciato lì, in vista della costa, lontano dalle inesplorate possibilità stilistiche della lingua di arrivo, dalla sua storia e dal suo campo letterario.
Nasi cita la tesi di Arduini della traduzione come l’elaborazione di un lutto, del sentimento di perdita per un testo che appare intraducibile nella sua totalità, e ciò è in parte vero, anche se forse qui, invece che di lutto, parlerei piuttosto di malinconia, perché in questo caso l’oggetto è non già perduto, ma assente e non postulabile nella realtà: l’originale continua la sua vita tranquilla nella sua lingua, mentre il desiderio impossibile di un testo ideale che ne sia la traduzione perfetta rende difficile accontentarsi dell’unica via possibile, cioè tentare di avvicinarsi a quell’ideale attraverso un’approssimazione - concetto molto caro a Nasi così come la malinconia attraversata già nel suo La malinconia del traduttore (Medusa 2008).
Per approssimarsi, chi traduce dovrà inventare lo stile più adatto per dare concretezza a quel desiderio ideale, affidando a traduttori e traduttrici futuri il compito di ritentare l’impresa, all’infinito, beckettianamente (fail again, fail better). Solo così, tra l’altro – accettando la sfida integrale della traduzione senza freno a mano tirato – i testi tradotti potranno lasciare un’impronta nella tradizione che li ospita. Non è mai abbastanza riconosciuto il ruolo che hanno avuto le traduzioni (lette o prodotte) nel plasmare le svolte, le accelerazioni, le deviazioni che hanno modificato il corso della nostra letteratura (come si rileva a proposito di Celati, per esempio), così come è bene restare in guardia rispetto ai pericoli che alcune mode traduttive continuano a rappresentare oggi: penso in particolare alla tendenza, rilevata anche da Nasi nel capitolo dedicato a Strand, di ‘nobilitare’ in senso aulico ogni testo poetico, anche il più radicale o sperimentale, con il risultato che ancora oggi l’idea di poesia dominante è legata a stilemi tardo-ottocenteschi che ignorano decenni e decenni della poesia italiana più recente.
È questo solo un campione delle riflessioni sulla traduzione che costellano il volume di Nasi, che con uno stile, il suo, coinvolgente e di grande chiarezza, si presenta anche come un necessario manuale di critica della traduzione: pur ricorrendo talvolta al confronto diacronico o sincronico tra diverse traduzioni, lo scopo non è fare le pulci agli errori (cui Nasi ha dedicato un altro volume Quodlibet nel 2021), ma analizzare di volta in volta le letture, le strategie e le loro ricadute stilistiche per illuminare la complessità del lavoro della traduzione letteraria e il suo modificarsi nel tempo, al variare delle consuetudini traduttive e dei cambiamenti che intervengono nella sensibilità letteraria e culturale dei contesti. Tradurre lo stile è per Nasi la sfida più importante perché spinge la traduzione a confrontarsi con aspetti che sono il fondamento stesso della letteratura, e che proprio per questo non devono essere anestetizzati da un’idea diminuita del compito della traduzione. Non si tratta di creare una riproduzione a calco dello stile, in cui aleggerebbe ancora lo spettro malinconico della corrispondenza perfetta, ma di un lavoro di coerenza testuale che richiede competenze letterarie, storiche e critiche che assicurino una vita ‘altra’ ai testi.
Infine, il merito del volume è anche quello generale di riportare al centro la nozione di stile, che mi sembra tornata alla ribalta anche in molti dibattiti sulla letteratura contemporanea, spesso accusata di ricorrere a uno stile standardizzato (anche su pressioni editoriali), di temere gli stili troppo divergenti, di essersi adagiata in una comfort zone che rassicura (o annoia) i lettori. Ciò conferma, credo, la convergenza di temi e questioni che riguardano tanto la traduzione quanto la critica letteraria, e suggerisce anche come l’appropriazione più diffusa di strumenti di critica della traduzione – come quelli presentati da Nasi nel suo volume – potrebbe non solo avviare una più fruttuosa riflessione su come leggere e interpretare le traduzioni di oggi, ma anche offrire un contributo importante alla discussione sulla letteratura, ma ciò solo a patto di fare pace con i fantasmi della malinconia, di rinunciare a credere all’invisibilità, e di mettersi in ascolto della voce tutta umana di chi traduce: dentro, intorno e fuori dai testi tradotti.