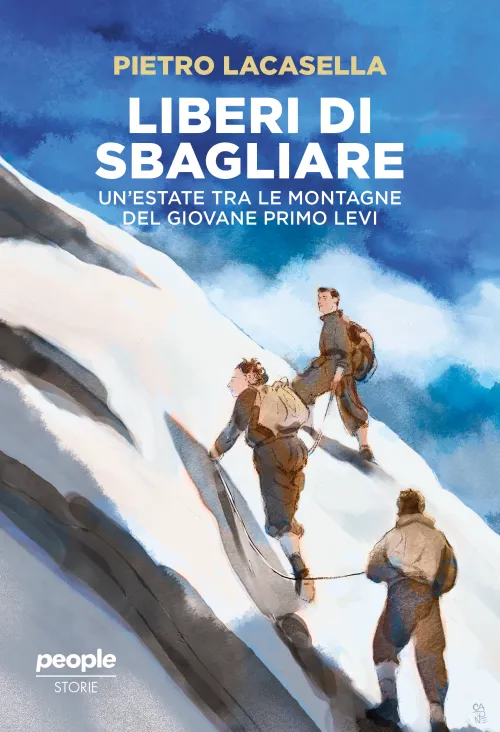In montagna con il giovane Levi
Su Primo Levi è stato scritto tanto, la scorsa primavera è arrivato anche il bel libro di Roberta Mori che racconta la vita di Sandro Delmastro, il suo migliore amico, caduto nei giorni della Resistenza. Cosa aggiunge questo Liberi di sbagliare (People, 2025) di Pietro Lacasella? Il desiderio di seguire i ricordi e i passi di Primo Levi sulle montagne della giovinezza, coniugando passione alpinistico-letteraria e freschezza narrativa.
Quando Primo Levi viene rinchiuso ad Auschwitz non era quel signore con occhiali e pizzetto immortalato da tante immagini degli anni Settanta e Ottanta, era un ragazzo pieno di voglia di vivere e di amare, di scalare vette e di leggere, che nelle montagne cercava e trovava libertà e leggerezza, lontano dal cupo grigiore della sua Torino, annichilita dal pensiero unico del regime fascista. E che in montagna, nel dicembre del 1943, perse tutta la sua libertà.
Levi si era rifugiato con altri giovani tra le baite di Frumy e il villaggio di Amay, sopra Saint-Vincent, formando una piccola e mal addestrata banda partigiana di Giustizia e Libertà. Amay, posizionato a 1.400 metri, era sembrato un punto strategico per osservare dall’alto i movimenti di truppe repubblichine, e fuggire se necessario oltre il Col de Joux, nella retrostante Val d’Ayas. I suoi declivi accessibili e la sua posizione nevralgica, tra la Val d’Ayas e la valle centrale traversata dalla Dora, lo rendevano però anche un possibile obiettivo di un’operazione di accerchiamento. La storia è nota: traditi da alcuni fascisti che si erano infiltrati nella banda, furono catturati e incarcerati ad Aosta, per finire prima a Fossoli e infine ad Auschwitz. Una beffa crudele per Levi perdere la libertà in quella piccola montagna dai grandi orizzonti.
Per un anno e mezzo Primo Levi divenne un numero tatuato sul braccio. Era solo un ragazzo, Se questo è un uomo va letto sapendo che nel primo anno di lager aveva 24 anni. Riuscì a sopportare l’insopportabile grazie alla resistenza fisica e mentale acquisita in montagna – lo dirà lui stesso –, alla conoscenza della chimica, di un po’ di tedesco, e a tanta fortuna.

Pietro Lacasella è un giovane appassionato di alpinismo, di buoni libri e di lunghi viaggi in bicicletta. Cura da alcuni anni il sito web di cultura, ambiente e alpinismo L’AltraMontagna. Segue i passi di Levi nelle vicende biografiche, nelle pagine, su lunghi tracciati stradali percorsi in bici per avvicinarsi alle montagne, su pareti rocciose e su quel che resta dei grandiosi ghiacciai alpini.
Lacasella sceglie di ripercorrere le cime raggiunte da Levi in gioventù, prima del Lager – Punta Melchiorre, Rocca Sbarüa, Uja di Mondrone, Picchi del Pagliaio, Monte Disgrazia, e anche la Torre del Gran San Pietro, scalata da Delmastro con la sorella Gabriella. Non raggiunge la Testa Grigia e il Monte Rosa, dove Levi tra gli anni Cinquanta e Sessanta volle riprovare il gusto di sentirsi libero e forte. Troppe sofferenze, troppi incubi, troppe illusioni svanite, in quelle ultime montagne si sentì felice, ma senza la spensieratezza provata con Delmastro e gli altri amici di un tempo ormai lontanissimo.
Il titolo del libro allude alla nota frase di Primo Levi che suggella il racconto Ferro, forse il più bel racconto di montagna del nostro Novecento: “Era questa, la carne dell’orso: ed ora, che sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca, poiché, di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino”.
Primo e l’amico Sandro sbagliavano a volte direzione, distanza o tempi di percorrenza, e sbaglia anche Lacasella, quando cerca il paese dove fare base per la salita sui Picchi del Pagliaio e quando cerca il lago Miserin e la Finestra di Champorcher, finendo invece – sotto un temporale –, al lago Bianco, comunque caro al Primo Levi degli ultimi anni, quando lo percorse con l‘amico giornalista Alberto Papuzzi. “Mi fa pensare al Canada, ai racconti di Jack London che leggevo in gioventù”, gli confidò.
Il libro appare agevole da leggere, le pagine scorrono fluide, con descrizioni efficaci: “al di fuori del golfo, il respiro irrequieto del mare si schianta contro scogliere ripide e compatte”, “procedendo tra i sassi, ho sfiorato una cascata che spandeva nell’aria vapori ghiacciati”. La leggerezza è sostenuta da una seria attenzione ai riferimenti storici e letterari. Le vicende collettive di un Paese allo sbando, etico e civile, si amalgamano alle vicende personali di Primo, di Sandro, di Alberto, di Bianca e degli altri. Giovani senza più un futuro, finiti nei tragici ingranaggi di una Storia divenuta orrore.

La facilità di lettura e la precisione storica lo rendono un libro ideale per far avvicinare i più giovani a Primo Levi, al richiamo verso una vita libera e responsabile, al piacere dell’avventura, del misurare il proprio coraggio e anche i propri limiti, per capire quando vale la pena lottare e quando è invece opportuno rinunciare. Nel racconto Potassio, ricordando la sua giovinezza Levi parla dell’impulso che “ci spingeva a conoscere i nostri limiti: a percorrer centinaia di chilometri in bicicletta, ad arrampicarci con furia e pazienza su pareti di roccia che conoscevamo male, a sottoporci volontariamente alla fame, al freddo e alla fatica, ad allenarci al sopportare e al decidere”, e torna col pensiero alle “montagne attorno a Torino, visibili nei giorni chiari, e a portata di bicicletta, erano nostre, non sostituibili, e ci avevano insegnato la fatica, la sopportazione, e una certa saggezza”. Ripercorrendo le sue tracce, Lacasella, che ha alle spalle molte grandi distanze coperte pedalando, resterà sorpreso dal numero di chilometri che Primo e i suoi amici percorrevano in bici (dell’epoca…) per arrivare alle montagne.
Accostare il Levi del racconto Ferro – i suoi giorni tra montagne e libertà –, a quello di Se questo è un uomo (solo 4 anni di distanza tra le due vicende) aiuta a vedere la crudele assurdità delle leggi razziali e dello sterminio nei lager. Vedere, non comprendere, Levi stesso ribadirà più volte l’impossibilità di comprendere l’orrore della Shoah.
Le montagne appaiono comunque anche in Se questo è un uomo, quasi un rifugio dell’anima, in mezzo a fame, freddo, umiliazioni, morte. Quando Levi prova a tradurre la Divina Commedia a Pikolo, il giovanissimo compagno di prigionia, a un certo punto giunto ai versi “mi apparve una montagna, bruna. Per la distanza, e parvemi alta tanto”, viene colto da un’acuta nostalgia: “E le montagne, quando si vedono di lontano... le montagne... ok Pikolo, Pikolo, dì qualcosa, parla, non lasciarmi pensare alle mie montagne, che comparivano nel buio della sera…”.
Il libro è arricchito da una garbata prefazione di Ian Thomson, l’autore della migliore biografia dello scrittore torinese (Primo Levi. A Life, 2002), un pegno di simpatia e di attenzione. Thomson del resto era anche lui giovanissimo – aveva 24 anni –, quando nel 1986 intervistò Levi, giudicandolo “cordiale e coinvolgente, un misto di serietà e dolcezza”. Anche lui appassionato delle Alpi Occidentali, in particolare dei Piani del Nivolet e delle cime attorno, non poteva non apprezzare l’idea che sorregge il lavoro di Lacasella: dare senso ed emozione alla memoria percorrendo i sentieri di Levi tra pagine e paesaggi. Un’idea che viene dichiarata esplicitamente nelle pagine finali del libro, citando le parole di Mario Rigoni Stern: “sarebbe bello che un giorno, leggendo un mio racconto, qualcuno potesse individuare il luogo e provare i miei stessi sentimenti e le mie stesse sensazioni” (da Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no, Einaudi, 2013).

Il viaggio per monti di Lacasella raccoglie momenti di silenziosa commozione, ma anche, a volte, di profonda amarezza. Quando vede gli scempi di ferraglia e cemento lasciati dalle Olimpiadi invernali di Torino: “Con l’avvicinarsi al Sestriere, i boschi si presentavano compatti come un sipario leggermente aperto, in modo da permettere al torrente e alla strada di passare. Proprio in quel paesaggio fiabesco abbiamo incontrato i trampolini di Pragelato, dall’aspetto tristemente acciaccato. Realizzati in occasione dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e costati la bellezza di 34,3 milioni di euro, sono fermi dal 2008”. E quando si ferma impietrito davanti a quel che resta del ghiacciaio del Teleccio. “Scavalcando con un ultimo sforzo un grande masso, mi sono ritrovato di fronte a quello che doveva essere un ghiacciaio. Doveva, sì, perché ormai non lo era più. […] Se sulla carta la valle era colorata di un azzurro intenso, davanti ai miei occhi si profilava un residuo grigiastro. Ghiaccio sporco venato in superficie dai canali di scolo scavati dalle acque di fusione e coperto da detriti e residui di ossa. Uno scenario inquietante”. Il ghiacciaio e il paesaggio percorsi da Primo Levi erano svaniti per sempre.
In un fine maggio appesantito di caldo e di umido dai cambiamenti climatici, ben diverso dal gelo di quel dicembre del ‘43, Lacasella raggiunge anche Frumy e l’ex albergo Ristoro di Amay dove Levi fu catturato. “Una volta emersi dal folto del bosco, il nostro sguardo ha abbracciato un paesaggio caliginoso, opaco e dalle sembianze tropicali. Dalla valle salivano correnti tiepide e con esse una bruma in cui si nascondeva la maggior parte delle vette. Solo i ghiacciai del Monte Bianco riuscivano a bucare la foschia”.
Il viaggio di Roberta Mori sulle tracce di Levi e di Delmastro, questo di Pietro Lacasella sulle loro montagne, stimolano a leggere, viaggiare e cercare, con empatia e con passione. Per vedere e per capire. Lacasella, laureato in Antropologia a Venezia, vive soprattutto a Vicenza, ma anche ad Asiago, nell’Altipiano dei Sette Comuni. Proprio nella Biblioteca Bertoliana di Vicenza è custodita una bellissima lettera di Levi a Luigi Meneghello, uno scrittore veneto cui l’univano molte cose: il gusto dell’ironia e dell’etica civile, la vicinanza agli ideali di Giustizia e libertà, la memoria condivisa con la moglie di Meneghello anche lei sopravvissuta ad Auschwitz. Levi scrive che I piccoli maestri, ambientato nell’Altipiano dei Sette Comuni, “non è un ma il libro vero della Resistenza”. Una storia di giovani innamorati della libertà, che commisero errori nelle montagne dove combatterono – “non sapevano fare la guerra” scrive Meneghello –, che preferirono una vita di rischi e di sbagli alla quieta e rassicurante sottomissione di tanti loro coetanei.
I loro nomi e la giovanissima età in cui furono uccisi (il maggiore aveva 22 anni) sono incisi sugli spalti a nord dell’Altipiano; chi ama la storia e l’etica civile, chi vuole seguire i sentieri dei nostri maggiori, vada su quelle montagne e fermi un momento lo sguardo su quel ricordo di giovinezza e di libertà.