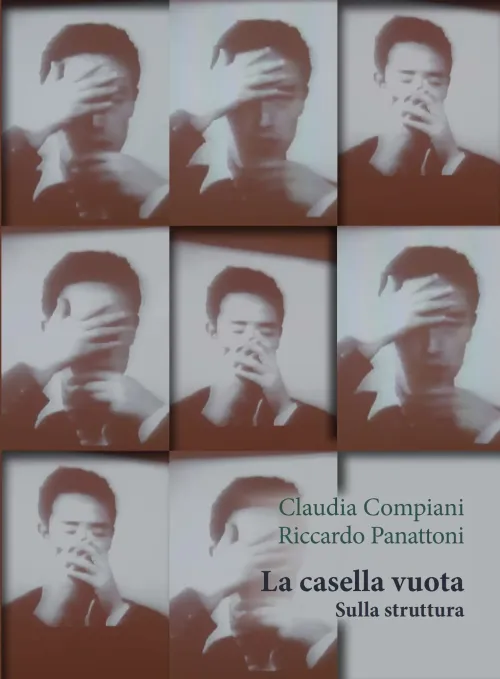La casella vuota della politica
Un tizio entra in un bar e dice al cameriere: “Un caffè senza panna, per favore”. E il cameriere risponde: “Mi dispiace, ma abbiamo finito la panna. Va bene anche senza latte?”.
Cosa c’è di politico in questa barzelletta tratta dal film Ninotchka di Lubitsch? Apparentemente nulla. Quello scambio di battute esemplifica però una nozione chiave dello strutturalismo che può avere importanti implicazioni politiche. Indica infatti il punto cardine di ogni struttura. Si allude lì a qualcosa di più di un semplice vuoto, di una mera mancanza, di una pura negatività (il “senza panna”). Vi troviamo semmai un vuoto pieno, una mancanza in eccedenza, un’assenza in presenza. Con la sua risposta, infatti, il cameriere sembra presupporre che senza qualcosa voglia dire con la mancanza di qualcosa. Rispetto alla semplice mancanza vi è in più un’entità spettrale e paradossale che abita la dimensione della negatività dandole un tono positivo: il caffè con-senza qualcosa. Questo con-senza è ciò che, nel paradigma strutturalista, costituisce la chiave segreta di ogni struttura, l’elemento virtuale che la fa funzionare. Si tratta del punto su cui far leva per una politica delle strutture, quali che esse siano (psichiche, familiari, sociali, economiche, organizzative, culturali, ecc.) e quale che sia l’ambito di riferimento.
Uno dei primi ad aver messo a fuoco questo elemento virtuale è stato Claude Lévi-Strauss, padre dell’antropologia moderna ma anche padrino dello strutturalismo culturale, da lui teorizzato e promosso a partire dagli anni Cinquanta come metodo in grado di riunire tutte le scienze umane, dalla linguistica alla sociologia, dall’antropologia all’economia. Ognuna di queste discipline studia infatti le relazioni tra gli elementi di un sistema. E, in termini strutturali, ogni elemento (sia esso un fonema, un concetto, un mitologema, una funzione sociale, un’istituzione politica) ha valore unicamente per la posizione differenziale che occupa entro la rete di relazioni in cui è inserito (la struttura). In ogni siffatta rete, osserva dunque Lévi-Strauss, c’è sempre uno squilibrio che si manifesta in un elemento paradossale. Un «significante fluttuante», come lo chiama l’antropologo francese. Ovvero, un elemento che è con/senza, pieno/vuoto, presente/assente, eccedente/mancante. Quello che, per intenderci, nel mazzo di carte è rappresentato dal jolly: un elemento vuoto (privo di valore in sé) ma anche pieno (in grado di assumere qualunque altro valore). Come il caffè con-senza latte, esso indica una mancanza che, guardata nel suo rovescio, si rivela come un’eccedenza. È infatti proprio la mancanza (di un valore specifico) a generare l’eccesso (la possibilità di assumere qualunque altro valore). Si tratta, dunque, di una pura differenza di potenziale: è questa l’anima pulsante di ogni struttura.
Nella sua Introduzione all’opera di Marcel Mauss del 1950 Lévi-Strauss porta diversi esempi di «significante fluttuante». Accanto al fonema zero nella linguistica di Jakobson, il più celebre è sicuramente la nozione melanesiana di mana, che alla fine del loro Saggio di una teoria generale della magia (1902) Mauss e Hubert definiscono proprio come una «differenza di potenziale». In un testo del 1976, Lo strutturalismo, Deleuze aggiunge ulteriori esempi: il fallo e l’oggetto a piccolo nella psicoanalisi di Jacques Lacan, il valore del «lavoro in generale» nella lettura marxista dell’economia svolta da Louis Althusser, il posto del re in Le parole e le cose di Foucault, il debito nel caso clinico dell’Uomo dei topi di Freud. E ribattezza questo elemento virtuale “casella vuota”, per quanto si tratti di un vuoto paradossale, un vuoto/pieno, una differenza di potenziale appunto. Il nome proviene da un antico gioco cinese, chiamato huarong dao e diffusosi in Francia come Asino rosso, citato da Lacan in uno dei suoi Scritti. Si tratta di un quadrante con delle tessere in legno, una sorta di puzzle a cui però manca una tessera. La casella vuota lasciata dalla tessera mancante è esattamente ciò che permette di giocare, ossia di muovere le tessere spostandole sulla superficie finché l’unica tessera rossa, che rappresenta un asino, non sia fatta scivolare verso la base del quadrante, permettendo all’asino di uscire dal recinto, che è lo scopo finale del gioco. La casella vuota ha dunque la stessa funzione del jolly: rappresenta una mancanza che può essere riempita da qualunque altro elemento del sistema. E costituisce lo spazio di gioco, il vuoto su cui fa perno l’azione, la garanzia del movimento e del cambiamento: la potenza virtuale che permette di riconfigurare il sistema e di ridisporne le parti assegnando loro nuovi posti e rinnovate relazioni. Più che un elemento della struttura, per quanto anomalo, si tratta di un ritmo immanente, di una densità che attraversa il campo nelle sue differenti articolazioni.
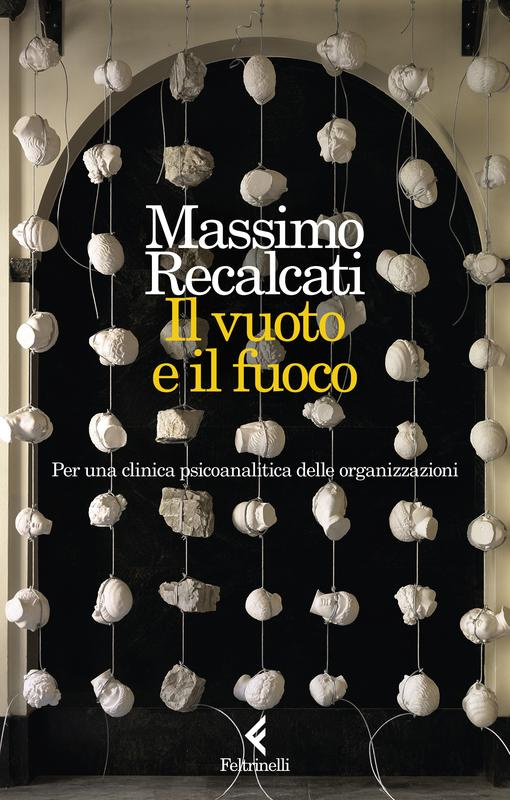
La casella vuota è dunque la vita dinamica della struttura. Attorno a questa idea è costruito il libricino La casella vuota. Sulla struttura, scritto da Claudia Compiani e Riccardo Panattoni da poco uscito per Orthotes. I due autori mostrano l’inesaurita fecondità dello strutturalismo mettendone anzitutto in luce la differenza rispetto alla teoria dei sistemi di Niklas Luhmann. Se quest’ultima ha avuto il merito di concepire i sistemi come aperti e dinamici ha però nel contempo mancato di mettere a fuoco la casella vuota, lasciando nel mistero il funzionamento del sistema e la comunicazione che esso intrattiene con l’ambiente esterno. Proprio questo è invece il punto di forza dello strutturalismo, se riletto alla luce della sua declinazione post-strutturalista, come suggerisce Deleuze. Porre alla base del funzionamento di un sistema un elemento paradossale interno/esterno, una potenza virtuale, un movimento intensivo è l’unica via per pensare in termini ecologici e realmente dinamici. Il libro tesse dunque un articolato confronto con Cassirer, de Saussure e i protagonisti della stagione strutturalista francese, da Lacan e Barthes, da Lévi-Strauss a Deleuze. La nozione di struttura ne esce ridisegnata come un campo di coesistenza di singolarità. Solo saggiando le densità che lo attraversano – suggeriscono gli autori – si riesce a far respirare la struttura, a mantenerla in vita, a rinnovarla. Si apprende così anche un certo know how, un certo modo di intendere e trattare le strutture organizzative e istituzionali, non privo di ricadute sul piano etico e politico. Da tempo, infatti, Riccardo Panattoni ha raccolto attorno a sé un gruppo di ricerca all’università di Verona che investe sul progetto di un design “filosofico” delle organizzazioni e delle istituzioni in grado di concepirle e gestirle in un’ottica dinamica ed ecosistemica.
Negli ultimi anni l’attenzione alle istituzioni e la riflessione sul loro funzionamento e sul ruolo vitale da esse svolto nella sfera collettiva sono sempre più cresciute nell’ambito delle scienze umane. Non solo in filosofia, dove il “pensiero istituente” di Roberto Esposito e l’approccio deleuziano al tema – ne è un illustre esempio, in Italia, il lavoro di Ubaldo Fadini – hanno impresso una svolta rispetto alla concezione unicamente negativa e repressiva delle istituzioni tipica della seconda metà del Novecento.
Anche nell’ambito della psicoanalisi si registra una sempre maggiore attenzione al tema. Ne è prova la recente pubblicazione di una nuova edizione del libro di Massimo Recalcati Il vuoto e il fuoco. Per una clinica psicoanalitica delle istituzioni (di cui Rocco Ronchi ha scritto un’ampia recensione qui su Doppiozero). La riflessione dello psicoanalista di muove su una linea di pensiero non molto differente da quella degli autori della Casella vuota. Che cosa è infatti necessario per preservare le istituzioni dal rischio della sclerotizzazione o dalla loro “evaporazione”? La casella vuota. O, come lo chiama l’autore, il vuoto centrale che dà vita e respiro a ogni organizzazione. Se quel vuoto fosse riempito avremmo una chiusura della dinamica istituzionale attorno a un tappo mortifero: un capo, una parola d’ordine, un ordine gerarchico fascisteggiante. Per questo è bene che il vuoto resti tale, permettendo a ogni istituzione di vivere e di rinnovarsi, come suggerisce l’autore traendo ispirazione da Lacan e dalle riflessioni di Roberto Esposito a cui il libro è dedicato.
La casella vuota, intesa come ritmo vitale della struttura, è insomma anche una questione di presa in carico e di cura delle istituzioni. Nel tempo in cui queste sono osteggiate e guardate come nemiche della vita dai vari populismi che sospettano di ogni regola ed etichetta, pensare il funzionamento delle strutture sociali a partire dalla casella vuota e porre questa al centro di ogni progetto istituente è un gesto sommamente politico.