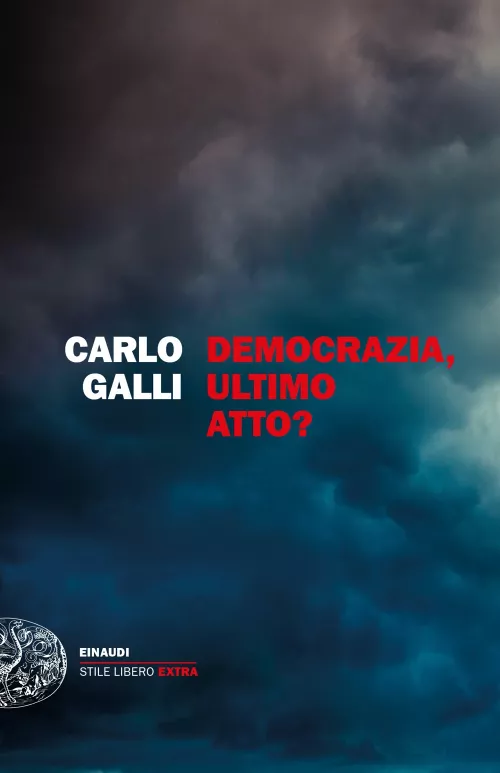Speciale
La democrazia in recessione
Se volessimo applicare il termine recessione anche alla politica – e recessione designa una riduzione dell’attività economica misurata dal Pil per almeno due trimestri consecutivi – dovremmo dire che siamo in recessione democratica da quarant’anni. Cioè da quegli anni ‘70 che sono stati – nel loro inizio, ma grazie al lavoro preparatorio del decennio precedente – da un lato un momento di grande diffusione e sviluppo qualitativo della democrazia (Statuto dei lavoratori, riforma del diritto di famiglia, diritto allo studio, divorzio, aborto ma anche ecologismo e altro ancora) – e però anche l’avvio del neoliberalismo come ideologia progressivamente egemone a partire dal golpe cileno del 1973 (dove venne sperimentato sulla carne viva dei cileni per poi essere adottato/imposto a tutto il mondo).
Neoliberalismo che è l’unica ideologia politica del ‘900 tracimata nel nuovo secolo, la più subdola in quanto offerta in nome della libertà individuale (rimandiamo a Psicopolitica, di Byung-Chul Han). Al neoliberalismo si è poi aggiunta, negli anni ‘80/’90 l’ideologia (ancora più subdola) delle nuove tecnologie di rete, offrendo anch’essa il massimo della libertà individuale per produrre in realtà il massimo della integrazione/connessione di tutti come forza-lavoro nella società-fabbrica – come nel mercato, per il neoliberalismo.
E da allora – e sulla crisi della democrazia rimandiamo a Carlo Galli e al suo bellissimo Democrazia, ultimo atto?– siamo arrivati a una ennesima fuga del dêmos dalla democrazia e quindi dalla libertà (si rilegga Erich Fromm), all’accettazione delle democrazie illiberali, delle democrature, delle democrazie caricaturali e parodistiche, dei sovranismi/nazionalismi, dei populismi/(neo)fascismi/afascismi, delle tecnocrazie, delle democrazie dispotiche; e oggi – la peggiore forma di fuga dalla libertà – alla delega del potere del dêmos alle macchine/algoritmi/i.a. e alle grandi imprese hi-tech che governano il mondo, lo organizzano, lo comandano e lo sorvegliano, come fosse appunto una grande fabbrica – e noi la sua forza-lavoro oggi h24.
Ma populismi, sovranismi, afascismi, tecnocrazie, algoritmi sono solo alcuni dei sintomi di una malattia che sta a monte: nell’azione appunto – e reciprocamente funzionale in senso antipolitico – di neoliberalismo e sistema tecnico (il tecno-capitale) e definibili quindi come arché se utilizziamo (con tutti i rischi di una loro attualizzazione) concetti che risalgono alla Grecia antica – e rinviamo, per gli spunti che ci ha offerto e che in parte liberamente reinterpretiamo, al recentissimo e coinvolgente saggio di Donatella Di Cesare, Democrazia e anarchia (Einaudi). Poteri che in quanto accolti come arché sono deterministicamente contro il dêmos e il suo krátos (il potere del dêmos). Arché per propria essenza, per propria logica di funzionamento, per il loro porsi come fondamento della modernità e per la propria incessante rilegittimazione come arché, per il determinismo ecocida che contengono (il loro accrescimento illimitato, la dismisura compulsiva che incorporano come sempre di più!).

Un’arché che è invece tutto meno che naturale e fondativa – e però dobbiamo crederlo – ma solo storica e che quindi potrebbe essere rovesciata e sostituita da qualcosa di meglio, se solo il dêmos volesse tornare ad essere potere/krátos.
E infatti, se per l’ideologia neoliberale il mercato e la concorrenza devono sovraordinarsi (esserne il fondamento) a società/dêmos e a stato, altrettanto agisce il sistema tecnico im-ponendosi come un dato di fatto immodificabile (l’innovazione tecnica non si deve e non si può fermare!). Lo evidenziava già nel 1939 F. G. Jünger (1898-1977 e fratello del più famoso Ernst): “non è più l’uomo a creare il mondo che lo circonda, ma l’apparato industriale e così [l’uomo] impara ad agire contro la sua stessa volontà, deformata dalla macchina, […] e i suoi sforzi sono sempre provocati dalla macchina e sempre finisce per seguire la legge che è insita nello sviluppo della nuova tecnica” (in La perfezione della tecnica). Perché l’aspirazione al potere della tecnica come del capitalismo “si prefigge anche lo scopo di subordinare lo stato e di sostituire l’organizzazione statale con una organizzazione tecnica”. Perché “il tecnico oppone sempre i regolamenti tecnici allo stato e all’intera organizzazione sociale, in una instancabile produzione di leggi e di regolamenti contrassegnati da un carattere tecnicamente normativo”, cioè “la decisione tecnica è allo stesso tempo dispositiva e causale” – descrizione perfetta (impossibile negarlo) del mondo di oggi.
E se la demo-crazia greca aveva rovesciato la mon-archia (il governo di uno solo) e l’olig-archia (il governo di pochi), oggi dobbiamo dire che è invece sconfitta dall’arché del tecno-capitale – arché intesa come potere che pre-tende di essere originario e appunto fondativo/generativo di tutto (dell’era iperindustriale, della modernità) e a cui tutto deve sub-ordinarsi e a cui tutto deve tornare. Cioè la demo-crazia è stata sconfitta della tecno-archia – cosa diversa dalla tecnocrazia positivista, ma sua evoluzione totalitaria – che produce la forma necessaria e ad essa funzionale del nostro dover vivere in un mondo dove però non è più l’uomo ma la tecnica ad essere soggetto della storia (Anders, L’uomo è antiquato, II). Con la realizzazione via digitale di quella società amministrata e automatizzata temuta da francofortesi come Max Horkheimer (1895-1973), dove “tutto sarà regolamentato, veramente tutto! […], dove il singolo potrà sì vivere senza preoccupazioni materiali, ma dove non conterà più nulla […] e tutto si ridurrà al fatto di imparare come si usano i meccanismi automatici che assicurano il funzionamento della società” (in La nostalgia del totalmente altro) – una società oggi automatizzata/amministrata da algoritmi dove però non è più necessario imparare a schiacciare pulsanti, perché le macchine sono ormai autonome dall’uomo, anche se poi sono gli uomini a dover essere ibridati e sussunti nelle macchine.
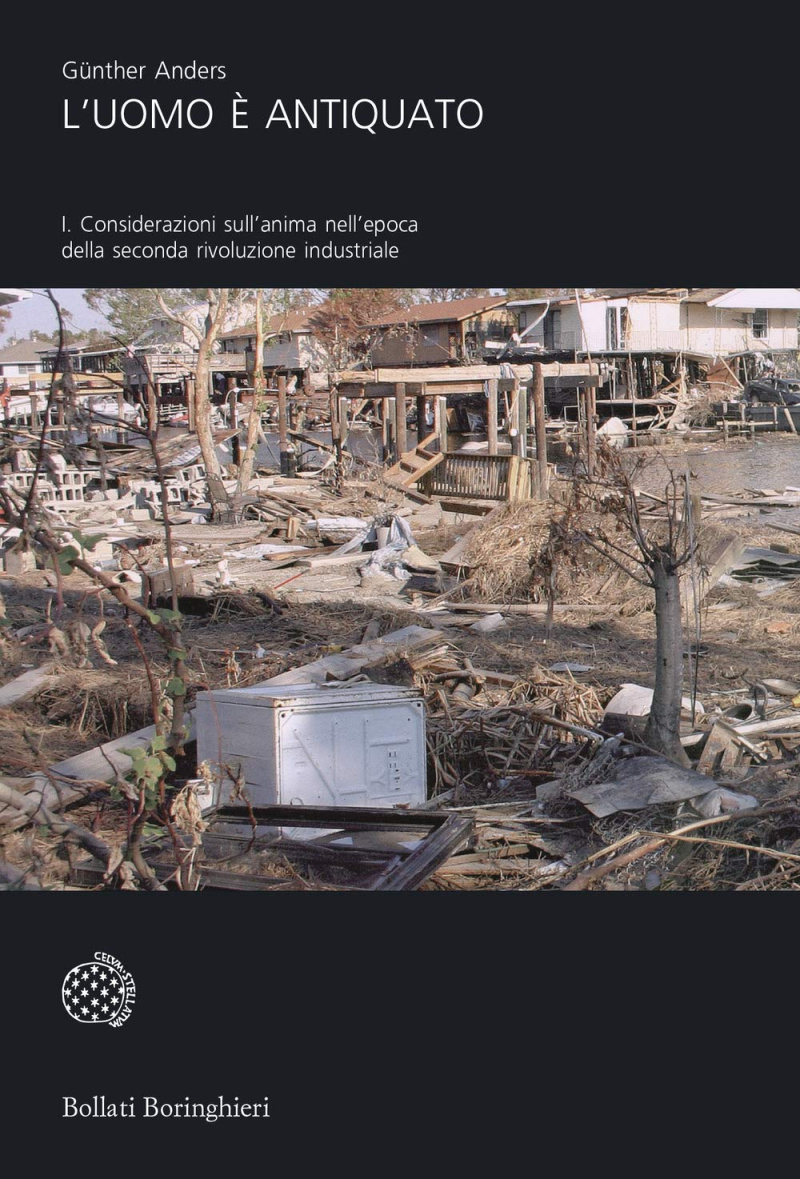
È questa l’arché, è questo il dispositivo archico – incarnato dalle multinazionali tecnologiche e finanziarie, ma anche dell’energia fossile – che produce un mondo a sua immagine e somiglianza, anche generando, come sua ulteriore scelta antipolitica, disuguaglianze crescenti e quindi ancora rin-negando la democrazia e che invece si basa sull’uguaglianza dei cittadini della pólis, che si riuniscono nell’agorá esercitando il proprio krátos. Un’arché di tecnica e capitale che svuota appunto il krátos del dêmos, facendo però credere che la rete sia la nuova agorá e la nuova pólis e il nuovo dêmos – quando è in realtà solo un gigantesco óchlos (nel senso di una folla indistinta dominata dalle passioni più ciniche e antipolitiche) però anch’esso funzionale alla costruzione dell’arché antipolitica e antidemocratica del tecno-capitale. Un’arché che è ciò che definiamo razionalità strumentale/calcolante-industriale – che è il vero potere fondativo della modernità e che si sublima appunto nell’industria/industrialismo (società, industria e progresso sono sinonimi, scrivevano i positivisti Saint-Simon e Comte due secoli fa e a questa realtà bisogna saggiamente rassegnarsi), ma meglio ancora nel concetto di fabbrica e oggi della società-fabbrica.
Certo, la democrazia ha sempre avuto una vita difficile, a partire dalla Grecia antica, ma oggi (in realtà da tre secoli di rivoluzione industriale e di positivismo) la sua crisi è più pesante, per l’azione combinata appunto dei due poteri indicati sopra e che per accrescersi sempre più come arché (fondazione, organizzazione, comando e controllo) de-politicizzano la pólis (populismi, tecnocrazie e social sono alcuni degli ultimi mezzi utilizzati per raggiungere lo scopo) e de-socializzano gli uomini. E questo per (1) politicizzare in senso archico il potere del capitale/capitalismo e della tecnica come forma unica e ineluttabile; e (2) ri-socializzare gli uomini, trasformati in merci/capitale umano e nodi e dati, nel mercato e nel sistema tecnico. De-politicizzare la pólis (e quindi l’azione consapevole dell’io e del noi nella pólis: un noi che oggi dovrebbe comprendere anche la biosfera e le future generazioni e i migranti – perché non c’è democrazia senza responsabilità e senza solidarietà; e de-socializzare gli uomini, perché quanto più e meglio si isolano/separano gli individui dal noi e dalle relazioni e dalla socialità, più li si esclude dalla pólis e dal noi-krátos, meglio sono appunto integrabili (secondo il vecchio/nuovo divide et impera) nel mercato come merci/forza-lavoro e nella tecnica come nodi-dati-merci/forza-lavoro – sempre ricordando, ma sempre lo si dimentica, che in verità più si è integrati (rete/social/community, la società-fabbrica), meno si è ovviamente liberi.

E l’ideologia neoliberale è ben riassunta nello slogan di Margaret Thatcher per cui la società non esiste, esistono solo gli individui (e al più la famiglia). Ma è evidente – dovrebbe essere evidente, ma non lo è, tale è la potenza ideologica del neoliberalismo – che se la società non esiste e anzi non deve più esistere, allora viene a mancare anche il dêmos e il noi della pólis, cioè la relazione sociale e quindi politica, senza i quali anche l’individuo viene meno perdendo ogni capacità e possibilità di solidarietà, di immaginazione, di progettazione, di costruzione di un proprio mondo umano, umanistico. Di democrazia. Se poi questa non-società di mercato si deve basare sulla competizione di tutti contro tutti (una guerra civile individualizzata) è altrettanto evidente che il suo effetto è appunto la morte della società e della socialità e della politica e della democrazia. Ma cancellare la società e quindi la politica cancellando l’individuo e la sua libertà era appunto nella strategia neoliberale, oltre che del sistema tecnico (supra). Perché – come scriveva negli anni ’30 uno dei rifondatori del liberalismo, Walter Lippmann (1889-1974) – il neoliberalismo (ulteriore versione del positivismo) è l’unica filosofia “che possa condurre all’adeguamento della società umana alla mutazione industriale e commerciale fondata sulla divisione del lavoro” (che è un altro fattore di de-socializzazione/de-politicizzazione se il lavoro viene digitalizzato e piattaformizzato), che a sua volta è un dato storico – un dato di fatto che non può essere cambiato (appunto perché, aggiungiamo deve essere creduto fondativo/arché); quindi suo compito è modificare l’uomo, adattandolo alle esigenze della produzione e di un capitalismo che diventa “un nuovo sistema di vita per l’intera umanità”, accompagnando “la rivoluzione industriale in tutte le fasi del suo sviluppo”; e poiché esso è infinito, “l’ambiente sociale e il sistema capitalistico devono tendere a formare tra loro un tutto armonico”.
Ma questo doversi adattare a qualcosa che l’individuo e la società non devono modificare e nemmeno governare politicamente e men che meno democraticamente – e lo stesso accade con le tecnologie di rete, alle quali ci si deve solo adattare, come ci si deve adattare al riscaldamento climatico, altrimenti addio profitti per il capitale – è appunto la negazione della libertà individuale, dell’autonomia del dêmos e quindi del krátos della demo-crazia – sempre riattivando anzi il servo arbitrio di un individuo che deve restare chiuso nella minorità kantiana.

E il neoliberalismo del ‘900 non fa che riprendere in altro modo non solo il positivismo ma anche ciò che scriveva Benjamin Constant nel 1819, confrontando la libertà degli antichi con quella dei moderni, cioè: “Il fine degli antichi era la suddivisione del potere sociale fra tutti i cittadini: era questo che chiamavano libertà. Il fine dei moderni è la sicurezza dei godimenti privati; e chiamano libertà le garanzie accordate dalle istituzioni a questi godimenti”. Solo che questi godimenti privati – e ciò che è solo privato, egoistico nega ex ante il politico, la pólis, ciò che deve essere comune e in comune, quindi è nuovamente anti-democratico ma anche irresponsabile (si pensi ancora alla crisi climatica) per sua essenza e finalismo – non sono mai dell’individuo libero e autonomo, ma sono sempre più etero-prodotti – cioè other directed – da management, marketing e social e dalla propaganda neoliberale e tecnica – anche se devono sembrare inner directed, cioè libera scelta dell’individuo.
Ma c’è altro. E di ben più antidemocratico. Chi governa democraticamente i processi di innovazione tecnologica? Il dêmos, come dovrebbe essere in democrazia/stato di diritto, dove non possono e non devono esistere poteri non bilanciati da altri poteri? No, è l’impresa autocratica/archica del capitalismo oggi diventato digitale. Scriveva Luciano Gallino (1927-2015 – in MicroMega 4/2011): Oggi “la grandissima maggioranza della popolazione è totalmente esclusa dalla formazione delle decisioni che ogni giorno si prendono”, di fatto alienata dalla democrazia per l’azione di quel soggetto che si chiama grande impresa. E il cui potere [appunto, archico] “di decidere a propria totale discrezione che cosa produrre, dove produrlo, a quali costi per sé e per gli altri, non è mai stato così grande […]”, configurando quindi un deficit di democrazia tale “da costituire ormai il maggior problema politico della nostra epoca”. Da allora il deficit di democrazia non ha fatto che aumentare ma non è un problema politico – si pensi alla i.a. sviluppata da imprese private per profitto privato a prescindere dal dêmos.
E allora, per uscire davvero dalla recessione – meglio: dal dissolvimento progressivo – della democrazia servirebbe nuovamente un dêmos capace – lo spunto ci viene ancora da Donatella Di Cesare – di rovesciare l’arché (per noi equivalente a totalitarismo) della razionalità strumentale/calcolante-industriale mediante l’attivazione di un potere an-archico. Cioè demo-cratico.