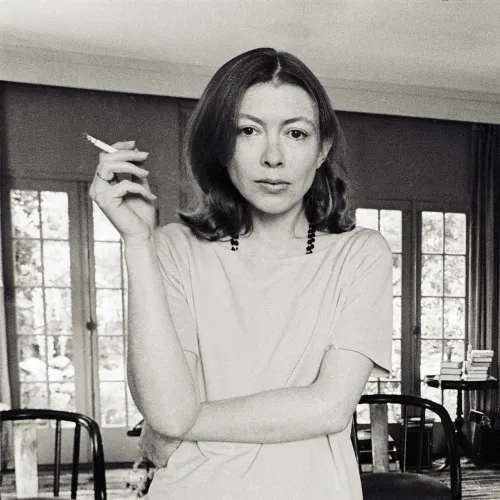La vita che conoscevi. Il diario di Joan Didion
Leggendo i quarantatré scritti privati che formano Diario per John, pubblicazione postuma uscita da pochi mesi per il Saggiatore, il lettore di Joan Didion non può che essere preso da sentimenti contrastanti.
Anzitutto, si ritrova ad avere la persistente impressione di essere un intruso che assiste alla storia di un disagio intimo tra una madre (Joan) e una figlia (Quintana). Ciò che va in scena la maggior parte del tempo è, infatti, più che la consueta brillantezza dell’autrice, la prostrazione di una madre che non sa come venire incontro al disagio di una figlia alle prese con un problema di alcolismo che pare insormontabile.
Probabilmente, si dirà, questo è il classico scrupolo che accompagna il lettore critico di ogni operazione editoriale di questo genere. Certo è che nel caso di un’autrice che non ha mai avuto problemi a rendere pubblici i suoi più lancinanti dolori – la scomparsa a brevissima distanza del marito John e della stessa figlia – la cosa assume una coloritura leggermente differente. Non era il caso di concedere a Didion, a dispetto dei nostri “diritti di lettori”, che almeno questa parte della sua storia non venisse divulgata?
A questa obiezione, che a qualcuno potrebbe apparire oziosa, se ne aggiunge un’altra. Sarebbe a dire che il «diario» in questione non è forse nemmeno un vero diario, quanto, piuttosto, il resoconto di ciascuna delle quarantatré delicatissime sedute a cui Didion si sottopose dal dicembre del 1999 fino al gennaio del 2003 con il suo psichiatra. Ciò che ne risulta sono degli appunti di disperazione privi di quell’elaborazione che è presente nella forma diaristica – seppur talvolta in minima parte – e che tende a dare al dolore una forma. Quello di Diario per John, invece, è un dolore senza forma, scompaginato, che resiste alla razionalizzazione – la razionalizzazione letteraria del lutto che ha portato, nella carriera di Didion, ai due fantastici memoir L’anno del pensiero magico e Blue Nights, rispettivamente dedicati alla scomparsa del marito e della figlia.
In seconda battuta, il lettore non può negare che in questo nuovo libro ci sia pur sempre qualcosa di luminoso. Sia pure il fatto banale che si parla di un’autrice fondamentale per la letteratura americana contemporanea, e che dunque ogni parola, ogni riflessione intima non può che essere preziosa, anche solo al fine di offrire ulteriori spaccati della vita interiore della scrittrice. Come, ad esempio, quando Didion si accorge della difficoltà a parlare schiettamente di fronte alle persone: “«Non piange nel corso del giorno»” le dice il dottore, vedendola scoppiare in lacrime all’inizio di un nuovo incontro “«ma questo non è il corso del giorno. Fatica particolarmente a parlare oggi?»” “Ho risposto di no,» dice Didion «[fatico] ogni giorno». Un dettaglio clinico del rapporto analista-paziente che non può che riecheggiare alcune considerazioni che l’autrice svolse, per esempio, nel suo articolo Perché scrivo del 1976. “In molte maniere” aveva scritto Didion “scrivere è l’atto di dire «io», di imporsi sopra gli altri, di dire «ascoltami, vedila a modo mio, cambia idea». È un atto aggressivo, persino ostile.” Un’aggressività che, leggendo Diario per John, si riconosce come manchevole nella vita di tutti i giorni, sepolta da una timidezza inesorabile oltre che dalla paura “per il mondo fuori”, e perciò ricercata nella letteratura. Diario per John, oltre che offrire una Didion inedita, aggiunge dettagli importanti rispetto ad alcuni elementi che compongono molto del suo lavoro, così strettamente intrecciato alla sua biografia.
Sono il marito John e la figlia Quintana i due referenti fondamentali di questo nuovo libro. Per questo, a trarre luce da quest’ultima pubblicazione sono soprattutto i due lavori a loro dedicati, L’anno del pensiero magico e Blue Nights, entrambi posteriori alla scrittura del Diario.
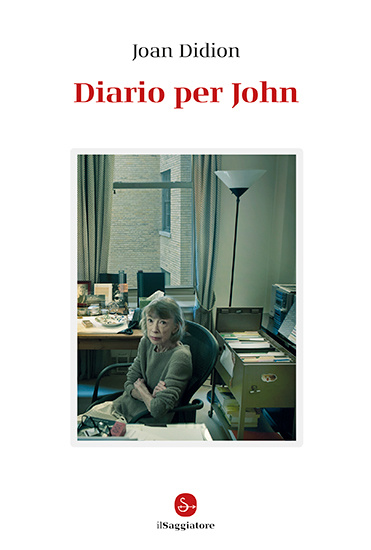
Al marito John è rivolto ogni appunto della raccolta, anche se, come viene fatto notare dai curatori, «è possibile dedurre che i resoconti non avessero il semplice scopo di aggiornare il marito», visto che uno dei resoconti parla di una seduta a cui John era presente. Il «tu» a cui si rivolge Didion pare quindi essere sia reale che finzionale, e, più di tutto, un riferimento costante dentro di lei: “ho detto che ero molto giù. Che mi sembrava che non ci fosse niente che io e te potessimo fare per aiutare Quintana”. John è un punto fermo nel continuo cambiamento drammatico che caratterizza la vita, e che nel Diario è costituito dalla malattia di Quintana. Il cambiamento drammatico è stato il nodo cruciale della produzione matura di Didion, e fu il tema fondante di L’anno del pensiero magico, che trattava proprio della perdita del marito. «Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita» scriveva allora Didion. Questa domanda rivolta a sé stessa e al marito fa da sottofondo a ogni seduta raccolta nel Diario: che fine ha fatto la vita che conoscevamo? È interessante notare che da Diario a L’anno del pensiero magico l’autrice fa i conti con il passaggio da questo “noi” a un nuovo ’”io”, quando, con la morte di John, perde il punto di riferimento reale e le rimane soltanto quello interiore. “Penso a quando entravo con lui nella caverna di Portuguese Bend” scrive Didion in conclusione di L’anno del pensiero magico “all'acqua limpida che saliva, a come cambiava, alla velocità e alla forza che prendeva quando passava nelle strettoie tra gli scogli ai piedi del promontorio. La marea doveva essere proprio al punto giusto. Noi dovevamo essere in acqua nel preciso momento in cui la marea era al punto giusto. Nei due anni che abitammo là potevamo averlo fatto solo una mezza dozzina di volte al massimo, ma è ciò che ricordo. Ogni volta che lo facevamo avevo paura di perdere il momento giusto della marea, di restare indietro, di sbagliare il tempo. John mai. Dovevi sentirla cambiare, la marea. E dovevi abbandonarti al cambiamento. Me lo disse lui.”
Se in Diario John è il “tu” a cui Didion si rivolge e il “noi” da cui trae conforto, il rapporto con Quintana è l’oggetto di quasi ogni riflessione. Riflessione che, dopo la sua morte, sarà proseguita in Blue Nights, libro di cui, per molti versi, Diario per John è la prefigurazione. Molti temi dell’ultima opera pubblicata in vita da Didion vengono qui toccati per la prima volta: la preoccupazione per il fatto che la figlia si sentisse responsabile per i genitori, i sensi di colpa della scrittrice che temeva di essersi dedicata troppo al lavoro, l’approssimarsi della vecchiaia. “Dobbiamo toglierle dalla testa questa cosa che per forza deve essere colpa di qualcuno. Le cose accadono, a volte brutte” dice il dottor MacKinnon a Didion durante una seduta, e non si può leggere queste parole senza pensare a ciò che verrà – l’attacco di cuore che porterà alla scomparsa improvvisa di John, lo shock settico che uccise Quintana meno di un anno dopo. La fine della vita per come la si conosceva, una vita che si pensava interminabile come le notti azzurre dell’estate di New York che Didion descrisse in Blue Nights. “Durante il periodo delle notti azzurre pensi che la fine del giorno non arriverà mai” scriveva allora, nel suo libro “per Quintana”. Salvo poi, in un istante, riconoscere l’approssimarsi del buio. La luce blu si è dissolta e con essa la sua promessa di eternità, il suo “fulgore”. Blue Nights raccontava proprio la fine di questo fulgore, l’inizio di una nuova solitudine, l’arrivo dell’anzianità e “l’inevitabilità della dissolvenza”. “So cos’è la fragilità, so cos’è la paura. La paura non è per ciò che è andato perso. Ciò che è andato perso è già murato in una parete. Ciò che è andato perso è già chiuso dietro porte sbarrate. La paura è per ciò che c’è ancora da perdere. Potreste dire che non vedete cosa ci sia ancora da perdere. Eppure non c’è giorno della sua vita in cui io non la veda”. Nell’ultima parte della sua vita il timore di Didion, in queste che furono le ultime parole che scrisse, fu di perdere qualcosa di più che non il semplice ricordo della figlia, ormai “svanita”. Fu, piuttosto, il sentimento della figlia, l’immagine viva di lei che la scrittrice temeva di perdere, quella struttura mentale definitiva impressa dall’amore che non ammetteva la negazione della vita. “Riesco a immaginare di dirglielo perché la vedo ancora. (…). Allo stesso modo in cui la vedo estirpare le erbacce nel campo da tennis di Franklin Avenue.” La paura di perdere questa visione nell’ottundimento della senilità rimane l’ultima grande paura di Didion, al termine della sua esistenza.
In un articolo del 1998 intitolato Le ultime parole, Didion raccontò che una sera, durante un dinner party a Berkeley, un professore di letteratura inglese sentenziò che Francis Scott Fitzgerald era un cattivo scrittore, e che la pubblicazione del suo libro postumo The Last Tycoon ne era una prova inconfutabile. “Mi permisi di dissentire” scrive Didion “The Last Tycoon era un libro non finito, non c’era modo di giudicare a partire da quello perché non c’era modo di sapere come Fitzgerald avesse intenzione di terminarlo”. Per lo stesso evidente motivo, Diario per John – che, peraltro, non era nemmeno pensato per la pubblicazione – non vi dirà che genere di scrittrice è Joan Didion. Non vi dischiuderà davanti agli occhi il suo valore, non vi stupirà per la sua padronanza della scrittura, o per la sua estrema lucidità. I due libri sopra menzionati assolvono a questo compito in una maniera molto migliore, come, d’altronde, era nelle intenzioni dell’autrice, e sono solo quelle parole a valere come il suo testamento letterario. Questi appunti, d’altronde, scritti in un momento nuovo e drammatico dell’esistenza come tentativo continuo di ricomprensione della vita, sono un ulteriore lascito di una grande autrice che fece dell’autocoscienza il valore supremo. “Ho detto che pensavo a questo sin da quando ero piccola. Non alla «morte», ma a questo fatto di «esistere» o «non esistere». Ancora ricordo che provavo a girarmi di scatto per vedere se il mondo continuava a esistere anche se io non lo vedevo”.