Speciale
Il contesto e Porte aperte / Sciascia e la giustizia
Il contesto di Leonardo Sciascia è stato pubblicato nel 1971, suscitando molte polemiche all’epoca. Porte aperte, uno dei libri dell’ultima stagione narrativa dello scrittore siciliano appare del 1987. Eppure, per quanto concepiti a distanza di molti decenni, sembrano ruotare intorno a un medesimo tema.
Innanzitutto si collocano a pieno titolo nell’oramai collaudato filone che possiamo definire ‘diritto e letteratura’, che studia i prodotti letterari in rapporto alle questioni giuridiche che pongono (Giustizia e letteratura, doppiozero). Ma c’è un’altra ragione forse più importante: i due romanzi testimoniano l’ossessione di Leonardo Sciascia per il problema della giustizia, perché, come ha scritto, “per me tutto è legato”.
“Porte aperte” è privo di avvenimenti dinamici; è piuttosto una sorta di “antiromanzo filosofico” centrato sul rifiuto della pena di morte. La vicenda prende le mosse da un fatto effettivamente accaduto: un triplice omicidio accaduto a Palermo nel 1937. L’assassino, Giuseppe Ferrigno, come narrano le cronache, è un impiegato appena licenziato animato dal desiderio di vendetta, che colpisce a morte la moglie, il collega che lo ha sostituito e il responsabile dell’ufficio appena lasciato. Un caso semplice perché l’accusato è confesso e lo attende perciò la pena di morte, reintrodotta dal fascismo pochi anni prima con il Codice penale del 1930, che durante il regime riscuoterà innegabile successo (sono 183 le sentenze emesse e quelle 118 eseguite). Assume un ruolo decisivo il giudice togato che affianca il Presidente della Corte, nelle cronache dell’epoca Salvatore Petrone di Recalmuto. Questi non viene mai nominato, ma indicato semplicemente come il “piccolo giudice”, non tanto per la statura o il ruolo laterale al presidente quanto per la misura dell’impegno, «tanto più forti» di lui erano le cose «che aveva serenamente affrontato». Il piccolo giudice s’oppone alla pena capitale convincendo la giuria a optare per l’ergastolo sulla base di un argomento tecnico. I tre crimini non si presentavano sganciati da loro, come maturati ed eseguiti senza connessione, ma potevano essere considerati il frutto di un disegno che idealmente li unificava: la vendetta. Così argomentando la pena da comminare poteva essere l’ergastolo e non quella capitale.
La sentenza, come attestano le cronache dell’epoca, verrà ribaltata nelle fasi successive, e l’imputato sarà fucilato. Dal canto suo il giudice pagherà la sua intransigenza con il trasferimento in una piccola pretura provinciale. Non si saprà mai se il presidente della corte, che s’era assunto l’incarico di redigere la motivazione, nonostante fosse favorevole alla pena di morte, si sia espresso secondo il lessico legale in modo ‘suicida’. In altri termini se espose le ragioni dell’ergastolo sulla base della tesi della continuazione tra gli omicidi, salvo poi spiegare che i tre episodi erano invece autonomi e quindi in termini incompatibili con le premesse. Questa sarà la ragione dell’annullamento dell’ergastolo e della successiva condanna a morte (Passarella, Magistrati togati e giudici popolari durante il fascismo, Roma, 2020).
Il contesto tratta invece dell’omicidio di un alto magistrato, il procuratore Varga, cui ne fanno seguito altri quattro: sono i “cadaveri eccellenti”, come titola il film di Rosi del 1976 tratto dal libro. L’indagine è affidata all’ispettore Rogas che percorre una pista apparentemente fondata. Ipotizza che si tratti della vendetta messa in opera dal farmacista Cres che, da innocente, aveva scontato la pena di cinque anni di reclusione per tentato uxoricidio. Questi sarebbe stato mosso dalla volontà di rifarsi contro i giudici che “più di qualsiasi altri incarnano la legittimità della forza”. Il poliziotto capisce presto di essere emarginato e che la sua inchiesta rischia di essere affossata.
Riceve censure dall’alto con “l’autorevole esortazione a non raccogliere dicerie riguardo l’operato dei magistrati uccisi”. Gli viene suggerito di indagare nell’ambiente estremista con lo scopo, neanche troppo velato, di alimentare una sorta di strategia della tensione e quindi “tirar dritto sulla traccia, se traccia c’era, di quel pazzo furioso che senza ragione alcuna andava ammazzando i giudici.” Percepisce così che si sta architettando una sorta di complotto attraverso cui i detentori del potere istituzionale, con la collaborazione dei vertici della magistratura, cercano di consolidare la loro supremazia, “la collusione dei poteri del potere”.
I due romanzi sono gialli ‘atipici’. Entrambi, diversamente da quanto farebbe intuire l’inclinazione dell’autore verso quel genere, non sono gialli canonici. Porte aperte, svolgendosi nell’ambito di un dibattimento, potrebbe sembrare un legal drama, cioè quello schema letterario, diffuso soprattutto nei paesi anglosassoni, incentrato sullo svolgimento delle trame nell’aula del tribunale. Ma non lo è. È privo di momenti investigativi volti ad accertare le responsabilità in quanto l’imputato è confesso, non insiste sui fatti delittuosi, ma offre soltanto scarne testimonianze, è reticente sulla discussione in camera di consiglio. L’incertezza sulla sentenza non è dovuta agli imprevisti della discussione, a una testimonianza sorprendente, al ripensamento improvviso di un giurato quanto alla contrapposizione radicale tra due differenti posizioni sulla pena di morte. L’autore lo ha definito una ‘parodia’ del romanzo giallo. Ne sovverte i canoni nonostante che il nome Rogas dell’ispettore, dal latino rogare, cioè interrogare, sia un apparente richiamo ai modelli giallisti, cosa che peraltro dichiara lo stesso Sciascia nel descriverlo: «un po’ Maigret, un po’ Ingravallo del Pasticciaccio, un po’ quel Prentinice della Quinta Colonna di Greene. E un po’ moi”. Il genere poliziesco dovrebbe far emergere la verità mentre il romanzo è svuotato di certezze. Il finale dovrebbe chiudersi con lo svelamento rassicurante del mistero, mentre è invece aperto. Rogas infatti viene ucciso unitamente al segretario rivoluzionario Amar, e nulla viene spiegato al lettore, lasciato solo a scegliere tra alcune possibili conclusioni.
La prima è che questi omicidi siano funzionali alla strategia della tensione, come sottolineato dal comunicato televisivo emesso immediatamente dopo l’omicidio dei due uomini, dove si parla di un oppositore ‘biondo barbuto’ come possibile autore del doppio omicidio. La seconda conclusione è ipotizzata da un amico di Rogas: questi è stato ucciso da un agente segreto perché aveva scoperto il complotto, come dimostrerebbe un memoriale che in realtà il lettore non conoscerà mai. La terza si riassume nella versione prospettata dal Vicesegretario del Partito rivoluzionario: Rogas uccide Amar e a sua volta viene ucciso da un agente. Sul motivo per cui non sia stato arrestato la risposta è secca: “La ragion di Stato: c’è ancora, come ai tempi di Richelieu. E in questo caso è coincisa con la ragion di Partito... L’agente ha preso la più saggia decisione: uccidere anche Rogas … Non potevamo correre il rischio che scoppiasse una rivoluzione ... Non in questo momento”. Si tratta di uno schema in cui sfumano le verità nel pirandelliano gioco delle parti, che denuda una giustizia incapace di punire il colpevole. S’intuisce la ragione per cui Sciascia ha scelto la denominazione ‘parodia’: quel mondo è degradato rispetto a come dovrebbe essere. Se “nel giallo esiste una metafisica, un mondo oltre il fisico e l’investigatore incorruttibile ed infallibile è un eletto”, scrive in “Breve storia del romanzo poliziesco”, compreso in Cruciverba, Einaudi, 1983 (ora in Il metodo di Maigret ed altri scritti sul giallo, Adelphi, 2018). In Il contesto non esiste una metafisica, non esistono soggetti che fissano le responsabilità individuali secondo principi morali, e l’investigatore non è depositario della verità. Come taluno fa presente a Rogas: ‘il suo mestiere è diventato ridicolo: presuppone l’esistenza dell’individuo e l’individuo non c’è. Presuppone l’esistenza di dio che è rimasto talmente a lungo nascosto che possiamo presumerlo morto’.
Porte aperte ha come cornice storica il Fascismo, Il contesto si svolge negli anni Settanta con una singolare inversione dei periodi: Il contesto è del 1971 ed è ambientato in quegli stessi anni, mentre Porte aperte è del 1987, ma collocato nel passato, nell’epoca fascista. Sono molto diversi per la cornice storica, ma innervati da alcune note comuni. Una di queste è il condizionamento del mondo esterno, la funzione dell’opinione pubblica influenzata dal potere e che su di esso a sua volta influisce. Un’intuizione folgorante, che non riceverà smentite negli anni successivi, anzi verrà corroborata divenendo oggi quasi un luogo comune, banale e scontato.
Il contesto si ispira alla situazione istituzionale e politica, e all’ambiente giudiziario degli anni Settanta. Non compaiono richiami diretti, i delitti non hanno una spiegazione esplicita, ma inevitabile è il richiamo a quella fase politica e storica. Di lì a poco sarebbero cominciati processi e inchieste contro esponenti di spicco della politica italiana, e sarebbero emersi scenari conturbanti sui rapporti inquinati dello Stato durante la stagione delle stragi. Ruolo non secondario assume l’opposizione, di cui si delinea una possibile convergenza verso il potere. L’ispettore Rogas sottolinea come i giovani sospettati dei delitti si siano probabilmente rifugiati nelle ville e negli yacht dei propri genitori benestanti. E Galano, direttore della rivista «Rivoluzione permanente», e i suoi collaboratori sono definiti “cattolici vecchi, fanatici, funerarî” e il romanzo ne denuncia l’essenza borghese.
Lo scrittore Nocio si difende dall’accusa mossagli proprio da Galano di essere lui stesso borghese capovolgendo l’argomento: “vivi come me; spendi come me; hai le mie stesse amicizie e conoscenze; vai e vieni da Saint-Moritz, da Taormina, da Montecarlo; giuochi e ti paghi gli amori come io non faccio, non ho mai fatto: ma io sono borghese, tu no. L’essere o non essere borghese sta qui – disse Galano: e si toccò con l’indice il centro della fronte. – Molto comodo – disse Rogas”. I gruppuscoli politici di estrema sinistra vengono difesi dalle accuse, ma sono anche criticati, ridimensionati, in particolare sul versante della sincerità della loro ideologia: almeno a livello dei loro capi non sono estranei a chi aspira soltanto al potere per il potere. Il discorso dell’autore sull’opposizione è netto e poco accomodante: il potere e chi vi si oppone fanno lo stesso gioco. Esiste in Italia, non solo in Sicilia, un groviglio di forze apparentemente contrastanti che in realtà si impegnano nella ricerca di un punto di equilibrio, così ponendosi in un’unica e indivisibile potestà sopraffattrice. Il romanzo modella la rappresentazione universale del “potere nel mondo”, “che mette tutto e tutti insieme”, “tutti dentro, nessuno fuori... anche l’opposizione” con risultati controversi. Il libro è stato giudicato a suo tempo come una delle cose “più felici” (Paolo Milano, Espresso 12.12.1971), oppure il contrario: “infelice” (Pietro Citati). Da taluno ritenuto “un raccontino scialbo e pretenzioso” (Giovanni Raboni, su Quaderni piacentini, XI), da altri una “chiacchiera qualunquista” (Walter Pedullà, Avanti del 2.1.1972).
Nel racconto di Sciascia il paese e le istituzioni si scagliano contro colpevoli più consolatori, quei “gruppuscoli” che “dalla capigliatura e dell’abbigliamento” si deduceva fossero “di un certo tipo, di una certa tendenza”. Si diffonde il sollievo nell’individuare presunti colpevoli in quell’ambiente, e anche il ministro degli Interni osserva: “Perché gruppi come quelli ... a me fanno comodo ... consumo (ed è la parola che fa al caso) l’uovo di oggi e la gallina di domani. L’uovo del potere e la gallina della rivoluzione... La situazione della politica, per così dire, istituzionalizzata si può condensare in una battuta: il mio partito, che malgoverna da trent’anni, ha avuto la rivelazione che si malgovernerebbe meglio insieme al Partito Rivoluzionario Internazionale; e specialmente se su quella poltrona – indicò la sua dietro la scrivania – venisse ad accomodarsi il signor Amar. Ora la visione del signor Amar che da quella poltrona fa sparare sugli operai in sciopero, sui contadini che chiedono acqua, sugli studenti che chiedono di non studiare…; questa visione seduce anche me”.
In questa cornice la folla e la politica agiscono, suggeriscono, e sospingono in Il contesto verso la costruzione del colpevole; in Porte aperte verso una sentenza esemplare. In quest’ultimo racconto la sostituzione della pena di morte con l’ergastolo viene considerata un incidente di percorso. Come ipotizza il procuratore, il processo d’appello sarà costruito in modo da impedire la conferma di quella sentenza non desiderata: “Posso dirle quello che accadrà: la Cassazione annullerà la sua sentenza, assegnerà il processo all’Assise d’Appello di Agrigento dove c’è un presidente che… ha una certa affezione alla pena di morte. Ad Agrigento c’è anche un vecchio avvocato socialista: buon avvocato e segnato a dito come antifascista. Quest’avvocato assumerà la difesa dell’imputato: che è quel che si vuole per dimostrare che c’è nel processo una contrapposizione tra il fascismo che cade inesorabile sui delitti efferati e l’antifascismo che squallidamente li difende. In conclusione: ci sarà la sentenza di morte, l’imputato sarà fucilato”. Fin dall’inizio il processo punta ad una sentenza esemplare perché è un deterrente. Il titolo del libro si ispira a un detto in uso durante il regime fascista: “da quando c’è il fascismo si dorme con le porte aperte”, sottolinea il procuratore. Al che il “piccolo giudice” replica: “Io chiudo sempre la mia”. Le porte aperte sono per il fascismo il segno della sicurezza e della fiducia che il cittadino può riporre nello Stato che pensa alla sua incolumità: “Ma era, nel sonno, il sogno delle porte aperte; cui corrispondevano nella realtà quotidiana, da svegli, e specialmente per chi amava star sveglio e scrutare e capire e giudicare, tante porte chiuse”. La presunta scientificità alla base della pena capitale copre un obiettivo politico: il consenso derivante dal ruolo di garante dell’ordine che il regime intende rivestire. Il mito di uno stato forte, pronto, attento al benessere degli onesti, efficace nel punire esemplarmente chi intenda minacciarlo. Una tal norma è “l’idea di uno Stato che si preoccupa al massimo della sicurezza dei cittadini”, “l’idea che davvero, ormai, si dorma con le porte aperte”.
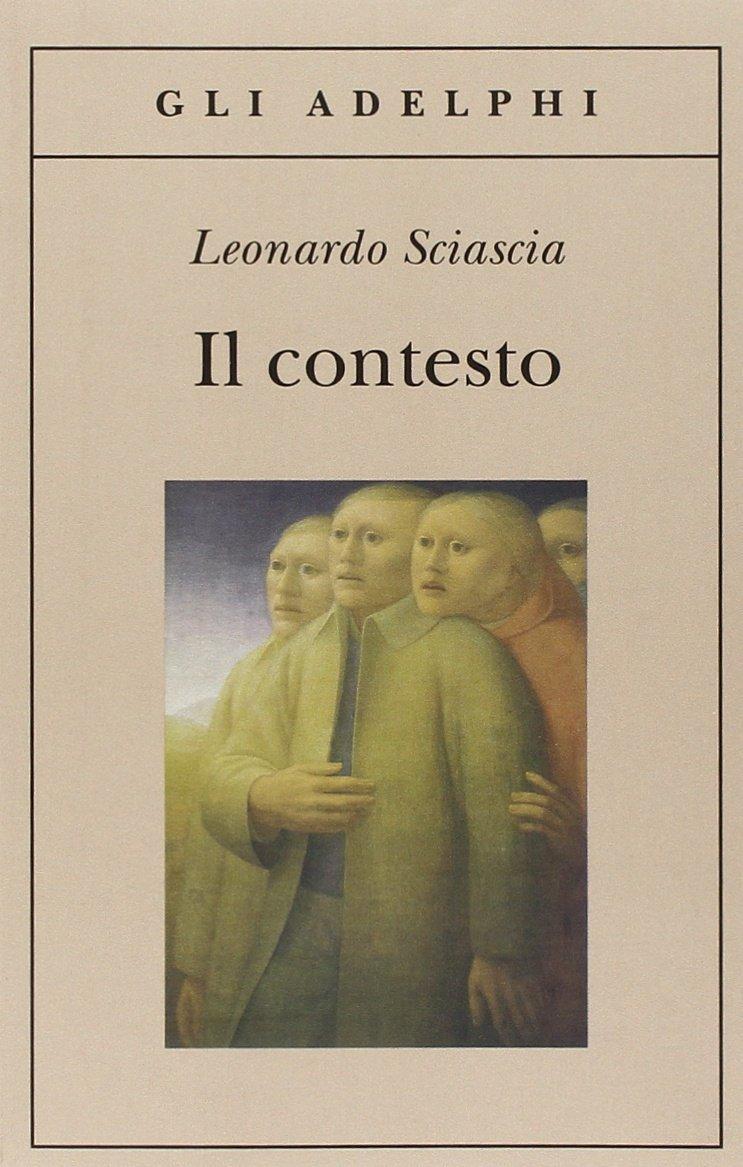
Il tema del diritto e della giustizia è trattato nei due romanzi sotto diversi angoli di visuale. L’autore ha riconosciuto costantemente il debito culturale verso l’illuminismo (esplicitamente in La Sicilia come metafora Mondadori, 1979), verso quella fase storico-culturale che pone tra l’altro in posizione privilegiata “lo stato di diritto”, oggi vanto delle democrazie. Si tratta di un assetto che elimina l’arbitrio e la degenerazione delle attività statali proclamando la superiorità della legge. Essa diviene il metro per distinguere il giusto dall’ingiusto, l’argine obbligatorio e non facoltativo rispetto agli stati di eccezione. Inverte il rapporto potere-diritto tipico dello stato assoluto secondo cui il diritto è creato dal potere, stabilendo invece che il potere è conseguenza del diritto. Combatte il dominio della Ragion di stato che esalta la scissione tra azione politica e valori, si oppone ai poteri che non si vedono e non votano, cioè quelli occulti. Questo sistema si è aggiornato con la formula “positivismo giuridico”, che ugualmente si affida ai comandi del legislatore, legittimi perché provengono da un’autorità che segue rigide ed accettate procedure. I giudici diventano esecutori di quella volontà e non sono consentite loro discrezionalità applicative perché sono “la bocca della legge”.
L’adesione di Sciascia a questo modello è descritta con particolare efficacia in Il giorno della civetta del 1961, quando si confrontano Don Mariano e il capitano Bellodi. Il primo è a favore della giustizia degli uomini con il contributo decisivo dell’istinto, delle inclinazioni, delle emozioni. Il secondo ribadisce il valore della legge oggettiva, vincolata, rigorosa, da applicare come “il bisturi del chirurgo”, riscuotendo il favore dell’autore (Irti, Il giorno della civetta e il destino della legge, Todo modo, 2017 e Fiandaca, Relazione a La giustizia in Leonardo Sciascia, Milano 7.4.2018, Youtube).
In Il contesto del 1971 l’approccio cambia, anzi si stravolge. Il romanzo è la rappresentazione della degenerazione di quei principi, di quello che malauguratamente potrebbe essere, e forse è. La fiducia nella legge si dissolve, s’incrina la certezza del diritto, trionfa il potere invisibile, viene eliminata la responsabilità individuale annegando il soggetto nella massa. Alla magistratura è delegato il compito di tranquillizzare il popolo e di punire attraverso meccanismi indifferenti ai riti democratici. Essa pertanto ‘non è… giusta… perché ‘tra i poteri del potere c’è quello di stabilire ciò che è giusto e ciò che è santo (Camon, “Il vertice della piramide”, in AA.VV., Leonardo Sciascia. La verità, l’aspra verità, Manduria, 1985). Il dialogo tra il Presidente Riches e l’ispettore Rogas mette a fuoco i danni che il potere infligge alla giustizia. Riches è convinto che quest’ultima sia impenetrabile come i sacramenti, che il suo esercizio sia l’unico “ingresso di dio nel mondo” in quanto il giudice è un sacerdote che non commette errori, infallibile perché non può che dispensare giustizia, espressione di un potere che si legittima autonomamente: “Il sacerdote può anch’essere indegno, ma il fatto che è stato investito dell’ordine fa sì che ad ogni celebrazione il mistero si compia. Mai, dico mai, può accadere che la transustanziazione non avvenga. E così è un giudice quando celebra la legge: la giustizia non può non compiersi…Lo vede un prete che dopo aver celebrato messa si dica: chissà se questa volta la transustanziazione è compiuta? Nessun dubbio: si è compiuta… inevitabilmente. Ribadisce Riches che “la sola forma possibile di amministrazione della giustizia potrebbe essere, e sarà, quella che nella guerra militare si chiama decimazione. Il singolo risponde dell’umanità e l’umanità risponde del singolo”.
Gli individui scompaiono con le loro responsabilità personali, mentre i colpevoli sono individuabili; «non si tratta più di cercare l’ago nel pagliaio, ma cercare nel pagliaio il filo di paglia». I delitti assumono la statura di atti di lesa maestà: “Nei processi sui delitti contro la legittimità della forza, …la colpa è perseguita nel disprezzo delle discolpe dei singoli imputati. Che l’imputato l’abbia commessa o no, per i giudici non ha mai avuto importanza”. E viene esaltata la vittima sacrificale secondo lo schema inquisitorio: “La confessione di una colpa da parte di chi non l’ha commessa stabilisce quello che chiamo il circuito della legittimità... E dallo stato di colpa è facile estrarre gli elementi della convinzione di reato più che dalle prove oggettive, che non esistono. Anzi, se mai, sono le prove oggettive che possono dar luogo a quello che lei chiama errore giudiziario.” Si compie così la cesura totale sia con la società su cui la magistratura dovrebbero vigilare, sia con le regole che dovrebbero accompagnare il controllo giurisdizionale.
Per Sciascia le cose non cambiano negli anni successivi. In “Dialogo di Candido e l’inquisitore sulle cose presenti”, (L’Espresso 1981, ora Opere, vol I, 2012) lo scrittore riannoda i fili lasciati liberi nel romanzo. “Candido (l’allora Rogas): siamo al realizzarsi di quel modello di amministrazione della giustizia di cui mi ha parlato 10 anni fa, vorrei capire… cosa sta accadendo – ’Inquisitore (l’allora presidente della corte Riches): Il disonore e il delitto devono essere restituiti ai corpi della moltitudine come nelle guerre ai reggimenti, alle armate. Puniti nel numero, giudicati dalla sorte – Candido, lei ha parlato di un potere falso, apparente.… – Inquisitore, Parlerò attraverso un apologo, Benito Cereno di Melville. L’equipaggio della nave si è ammutinato e quando la nave è stata fermata per un’ispezione, gli ammutinati si sono comportati come se il comandante fosse ancora tale. Nessun potere, ma solo formale ossequio al potere. Così è oggi: l’equipaggio è ammutinato, il comandante non comanda e non ci si accorge che il potere è passato di mano, non è più di chi apparentemente lo detiene. Lei non capisce quello che accade, ma accade”. Ancora negli anni Ottanta le istituzioni rappresentano per Sciascia solo l’apparenza visibile del potere, in realtà gestito da altri e altrove.
Come per il capitano le forme dello stato scompaiono e riappaiono solo per volontà di chi le ha spodestate rimanendo invisibile, e il cittadino non riceve giustizia perché la legge è inquinata. La certezza del diritto non è più un principio da proteggere perché ha prevalso la Ragion di Stato che ha costruito la legislazione secondo le proprie esigenze. Il quadro che si ricava da entrambi i testi è cupo, negativo, quasi disperato, con una magistratura apocalittica, arroccata, immemore delle ragioni della sua funzione. Non vi sono spiragli, neppure quelli proposti dalla Costituzione, pur già vigente negli anni 70, ma completamente assente nel romanzo. La situazione risulta immodificabile, tanto che la ragion di stato celebra il suo successo con l’uccisione dell’ispettore Rogas. Del resto, osserva Sciascia, se la mafia è arrivata anche a Roma, se s’intravede un colpo di stato, quale futuro può esservi? Come si può difendere lo stato contro chi lo detiene? “Lo stato è detenuto”, scrive.
Con Porte Aperte, pubblicato nel 1987, seppur ambientato durante il fascismo, l’approccio sul tormentato rapporto tra diritto-giustizia è diverso. Il giudice spinge infatti la giuria a evitare la pena di morte convinto della sua profonda ingiustizia perché guidato da una scelta di valore, secondo cui quella sanzione costituisce un’aberrazione. Il procuratore propugna invece la tesi formalistica, letterale, secondo cui “la legge è legge, noi non possiamo che applicarla, che servirla” anche se è emanazione del fascismo e soprattutto anche se la magistratura ne subisce la pressione. Questo romanzo disegna un ritorno al passato, quello antecedente a Il contesto, in quanto recupera il principio di legalità e il ruolo dell’interprete. Nel contempo descrive un nuovo modo di intendere quel rapporto ossessionante tra diritto e giustizia.
Il tema è semplice e nel contempo drammatico: come può o deve confrontarsi l’interprete quando si trova di fronte ad una legge ingiusta? Innanzitutto quando la legge è ingiusta? Può essere tale perché strumentale, fittizia, sostanzialmente faziosa, mossa da scopi propagandistici. Oppure perché traduce lo spirito dei tempi se contrassegnati dal sopruso e dalla violenza. Oppure perché viene emanata secondo procedure antidemocratiche, oppure ancora quando contiene precetti contrari ad altre leggi. Nel romanzo la legge è ingiusta nella formulazione classica: è tale perché contravviene ai principi morali e alla dignità dell’uomo, nella sostanza perché confligge con le leggi non scritte che invocava Antigone.
Di fronte a questa situazione cosa può fare il giudice? Può dimettersi e non decidere, ma questo rappresenterebbe una sconfitta. Se invece intende procedere quali sono i principi che invoca, da dove provengono, come vengono individuati, quale controllo esercitare su questa scelta? Come si può evitare il potere eccessivo dell’interprete con il rischio di indebolire la certezza del diritto?
Il romanzo rimarca, in termini netti, l’importanza del giudicare, il suo dilemma morale, la sua componente tragica (Cartabia-Violante, Giustizia e mito, Laterza, 2018). Il giudice si trova davanti a opzioni opposte che si escludono a vicenda (non si può fare sia l’una sia l’altra), e nel contempo una non è preferibile all’altra. Esiste un conflitto: da una parte adottare una soluzione eticamente non accettabile, e dall’altra applicare una norma inserita in un sistema vigente e cogente.
Mentre molti commenti su Porte aperte pongono attenzione quasi esclusiva sul problema filosofico della pena di morte negli anni del regime, è invece significativo l’anno di uscita del romanzo, il 1987. Sciascia ha avuto modo di seguire dal 1970 l’operare di una magistratura giovane, incalzante, arrembante, che s’interroga sul come superare un codice penale stridente con i nuovi messaggi repubblicani, optando spesso nel rinvio alla verifica costituzionale. Il corpo giudiziario si manifesta ‘disubbidiente’ verso norme che ritiene superate e che tenta di non esserne vittima. Erano quelli anni in cui lentamente si era erosa l’idea della legalità pura ed incontaminata, come un abito che inizia ad essere stretto quando con il passar degli anni il fisico ingrossa. E in effetti da svariati decenni si erano presentati i problemi sociali sempre più complessi, la rivoluzione industriale, la rinascita di corpi intermedi, le formazioni politiche rinnovate. Si stava rompendo il monolite della legge, ritornava il giusnaturalismo che limitava la certezza del diritto, si assisteva alla crisi del mito illuministico. Entravano in campo l’eticità nello Stato, i principi e diritti fondamentali i cui valori sono superiori ai prodotti del legislatore. Di conseguenza si delinea un ruolo dell’interprete nuovo, impegnato ad applicare la legge ma ispirata a principi autoevidenti, validi sempre e ovunque. Sfuma il semplice esecutore della legge d’illuministica memoria. Con l’ispirazione contingente di quegli anni il romanzo si trasferisce nel 1937: cosa poteva fare un “piccolo giudice” di fronte ad un istituto applicabile perché vigente, ma inaccettabile secondo i principi fondamentali?
Lo scrittore ricerca tra gli arnesi del codice la strada per attuare i principi in cui crede, e nel contempo si oppone a una disubbidienza radicale e ribellistica volendo applicare la legge. E trova il punto di equilibrio nel vincolo della continuazione, come si è ricordato, che gli consente di evitare la morte al condannato. Del resto quel codice del 1930, vigente ancora oggi con molti rappezzi, presenta una norma tuttora vitale che riconferma i principi accolti dall’autore. Si tratta dell’art. 2 che impone il principio di legalità penale, poi riconfermato nella Costituzione repubblicana, secondo cui si può essere giudicati solo sulla base di un reato già previsto dal codice, e come tale conoscibile dal cittadino. Sciascia rifugge dalla dissoluzione della legalità attraverso l’interpretazione e risolve l’eterno rapporto con la legge scritta conciliandoli, integrandoli, orientando la prima con i principi provenienti dalla seconda. Per questo il ‘poliziotto di dio’, come lo ha chiamato Bufalino, è messaggero del pensiero dell’autore a fronte di derive che privilegiano alternativamente l’uno o l’altro dei termini del rapporto.
In Il contesto la legge è sempre ingiusta perché inquinata dal potere, in Porte aperte è ingiusta perché la pena di morte contravviene a tutele universali. Il giudice ha un ruolo decisivo, di solito legato al potere, ma può anche avere un colpo di reni. Porte aperte rompe la cupezza tenebrosa sia per le considerazioni esposte sull’interpretazione irrorata dai principi, sia perché mostra un giudice diverso. Un magistrato interessato all’attività processuale svolta con valori ancorati alla ragione, alla ricerca della verità a prescindere dagli interessi di carriera, senza condizionanti esterni, con indipendenza di giudizio, nel ripudio di pregiudizi nei confronti dell’imputato quand’anche autore di condotte esecrabili. Questo sforzo è disegnato sul volto di Volontè, interprete del film omonimo di Gianni Amelio del 1990. Quasi sfinito, egli esprime con gesti lenti e misurati l’umanità dolente che rappresenta, il suo disincanto che lo fa apparire quasi distaccato ma per questo sereno e senza pregiudizi. È l’antieroe che mette a repentaglio la professione ed il futuro per un principio talmente inattaccabile «che si può essere certi di essere nel giusto anche se si resta soli a sostenerlo» In lui “la difesa del principio” è stato “il punto d’onore della sua vita, dell’onore di vivere”. Perla rara, questa, nella produzione di Sciascia, dove la rappresentazione di magistrati opportunisti, incapaci o corrotti è ampia, coerente con il quadro sconfortante dell’amministrazione della giustizia, “terrificante [...] specialmente quando fedi, credenze, ragion di Stato o ragion di fazione la dominano e vi si insinuano”. Quando il procuratore generale sembra rinfacciare l’inutilità del tentativo di evitare la pena di morte e insinua il sospetto che abbia difeso sopra di tutto un principio, il ‘piccolo giudice’ risponde: “È vero…ma è un problema, non un alibi. Io ho salvato la mia anima, i giurati hanno salvato la loro: il che può anche apparire comodo. Ma pensi se avvenisse, in concatenazione, che ogni giudice badasse a salvare la propria”.
Con il passar degli anni, dal 1971 al 1987, l’autore confida che la giustizia sia possibile rispettando la legge interpretandola alla luce di principi etici ed umani. Seppur con difficoltà e con momentanee sconfitte, come quella subita dal “piccolo giudice”. Sciascia intravede una speranza, veste “gli ignudi”, abbandona l’intransigenza giacobina del passato, tempera lo scetticismo trasformando il “non c’è certezza alcuna” in “nemmeno è certo che non ci siano certezze” (“Rensi filosofo dimenticato”, Corriere della sera 5.12.1986). Non a caso adotta come epigrafe per “Una storia semplice” del 1989 il proposito di Dürrenmatt: “ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia” (da Giustizia, Adelphi, 2011).







