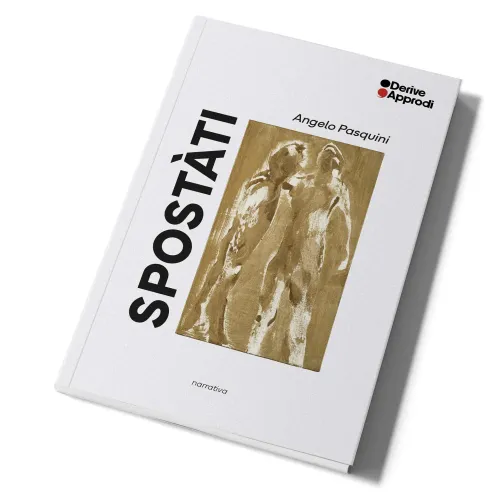Il Male: gli anni al contrario
Gli scrittori che dopo la seconda guerra mondiale scrivono romanzi in italiano costruiscono uno sguardo che durerà fino alla fine degli anni settanta. Primo Levi, Elsa Morante, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Carlo Levi, Italo Calvino, Natalia Ginzburg sono interpreti dello stesso impeto della nostra costituzione. Sono in buona sostanza nel solco di Benedetto Croce: il fascismo è stato un brutto episodio in una cultura fondamentalmente sana, si tratta di riannodare i fili con lo spirito costruttivo di Manzoni e Leopardi. Sarebbe difficile andare più indietro di così nel tempo: già Casanova, Da Ponte o Goldoni appartengono a un mondo pre-patriottico, lo stesso Foscolo a Londra si divide tra rivoluzionari italiani e greci. A ben vedere anche Leopardi, che dopo l’incontro decisivo con una colonia di protestanti a Roma raffredda molto gli entusiasmi risorgimentali della giovinezza, o gli anni decisivi di Manzoni a Parigi, rendono piuttosto difficile stringere le viti di cosa sia davvero il patriottismo. Più facile, per la sua sprovvedutezza e ignoranza, capire cosa sia stato il fascismo, un ventennio di progressiva provincializzazione e isolamento. Come del resto vediamo sempre in giro per il mondo, il nazionalismo altro non è, per gli italiani come per i tedeschi, gli inglesi, gli armeni, gli israeliani e qualunque altro popolo della terra, una malattia. Non solo per l’implicito razzismo di cui si nutre, ma perché nella chiusura all’altro reifica la propria paura, come qualcuno che si ritiri dalla vita per frequentare solo parenti di sangue, o che legga solo nella propria lingua, o che si ritrovi schiacciato nella nostalgia di genitori defunti. Una collettiva nostalgia di sé, piena dei malanni dell’immaginazione e spesso foriera di sciagurate iniziative politiche.
Le aperture dopo la caduta del fascismo, le traduzioni, il ritorno a una vita di pluralità di idee e incontri, fanno respirare invece un’aria molto diversa nelle opere degli autori del primo dopoguerra, quasi una speranza, una scommessa, che si articola poi in generale nelle altre arti, nelle azioni legislative, alla fine nei due referendum all’inizio degli anni settanta su aborto e divorzio che mostrano uno slancio e un desiderio di riparare tanti guai della società patriarcale e maschilista che aveva dominato gli anni del fascismo.
Questo rinnovamento si arresta negli anni settanta per diverse ragioni: da un lato un PCI ancora molto filosovietico e incapace di raccogliere e articolare le spinte eterodosse della società italiana, dall’altro la DC resta succube di un Vaticano che nonostante il concilio vaticano secondo resta bigotto, impelagato in una visione conservatrice della società italiana. I partiti minori, sia quelli liberali del centro che quelli più radicali della sinistra, sono margini a volte vivaci ma in generale ininfluenti.

Ma è soprattutto l’azione della P2 a bloccare l’Italia: rileggendo il Piano di Rinascita Democratica trovato nei documenti della figlia di Licio Gelli, è chiaro che l’egemonizzazione da parte degli USA della società italiana si afferma in questi anni e produce l’Italia in cui viviamo. Com’è ormai noto per le sentenze e le ricostruzioni dei movimenti di capitali che transitano per i conti di Gelli, la P2 agisce orchestrando una campagna di terrore con manovalanza neofascista che da Piazza Fontana all’omicidio di Aldo Moro segue una strategia che è stata studiata ormai in molti dettagli, a cui reagiscono in modo piuttosto velleitario le Brigate Rosse, ma lo fa soprattutto con un soft-power che ha al centro l’informazione. Silvio Berlusconi, come disse lo stesso Licio Gelli, ne è la vera espressione, ma i dettagli del piano andrebbero riletti proprio per farci comprendere in che direzione stiamo andando, come siamo diventati sempre più americani. Dalla controversa separazione delle carriere in magistratura alla televisione al turismo all’istruzione, dal presidenzialismo al boccone più grosso che la destra italiana ha sempre davanti: la costituzione.
Gli anni ottanta saranno anni di riflusso: alla spinta innovativa della generazione del dopoguerra seguirà un periodo di ripiegamento, disimpegno civile (o impegno su questioni remote geograficamente e culturalmente). Certo ogni autore va considerato in se stesso, per le proprie opere, ma se appunto il senso generale della generazione del dopoguerra era stato di un risveglio dopo il fascismo, quello degli anni ottanta è di un ripiegamento. Anche naturalmente di nuove aperture: molti romanzi, come ha scritto René De Ceccatty, vengono ambientati in Europa, si intravede a fianco alla provincializzazione anche un desiderio di aderire al progetto politico decisivo che presto darà Schengen, la moneta unica, che anche se l’identità europea resta vaga sono comunque passaggi decisivi.

Questa premessa è necessaria se si vuole parlare degli anni settanta: la vera ragione per cui è difficile scrivere oggi di quell’epoca, come si vede nel romanzo di Angelo Pasquini Spostàti (Derive e approdi 2025, pp 190), è che in realtà il Piano di Rinascita Democratica ha vinto: siamo governati da eredi di Gelli e della destra fascista. A prescindere dalle qualità e dai difetti del libro di Pasquini, che è stato tra gli ideatori e animatori di una rivista importante di quegli anni, Il male, è difficile capire le motivazioni dei personaggi che lui crea. In parte la vicinanza di Pasquini al cinema, dove personaggi e vicende, come fa dire a un personaggio, sono funzionali al racconto, fa sì che si perda quella qualità linguistica che fa del romanzo e della poesia qualcosa di più. Perché la lingua nella letteratura non è funzionale, al contrario, resiste a banalizzazioni, è idiosincratica persino quando è agile. Viene da come e quanto ci si parla, da cosa si legge; quando invece ha troppo a che fare con cinema e televisione, diventa appunto funzionale. Serve a dire qualcosa, ma quel qualcosa non è quello che dice, è spostato in avanti, un nuovo snodo nell’intreccio che molto spesso, per povertà di idee, è qualcuno con una pistola o una scena di sesso.
Ma la vera ragione, e non vale solo per Pasquini, per cui parlare di quegli anni è difficile, sta proprio nell’esito culturale dell’affermazione degli Usa in Italia. Le bombe da noi le han messe negli anni ‘70. Se le prospettive che erano ancora reali negli anni settanta sono diventate oggi utopiche, è perché la nostra vita sociale, collettiva, è rientrata nell’amministrazione ordinaria di una provincia americana. Senza nessuna nostalgia perché una certa sciatteria nei rapporti umani, dove la misoginia domina famiglie, coppie, amicizie, nella sinistra radicale come nella destra, non rendono quell’epoca per nulla attraente. Ma il crinale che ha determinato i passaggi degli anni successivi non dipende da scelte private, è il contesto che mutando ci ha trascinato in un’altra epoca.
Nella vicenda descritta da Pasquini domina un’amara rassegnazione: nelle vicende umane, negli ambiti professionali. Si è esaurita la spinta della generazione che era uscita dal fascismo e non si riesce a intravedere il dopo. Un dopo che non ha le spinte innovative cui accennavamo, ma in cui tanti hanno vissuto, e che forse non si è raccontato ma che riemergerà.