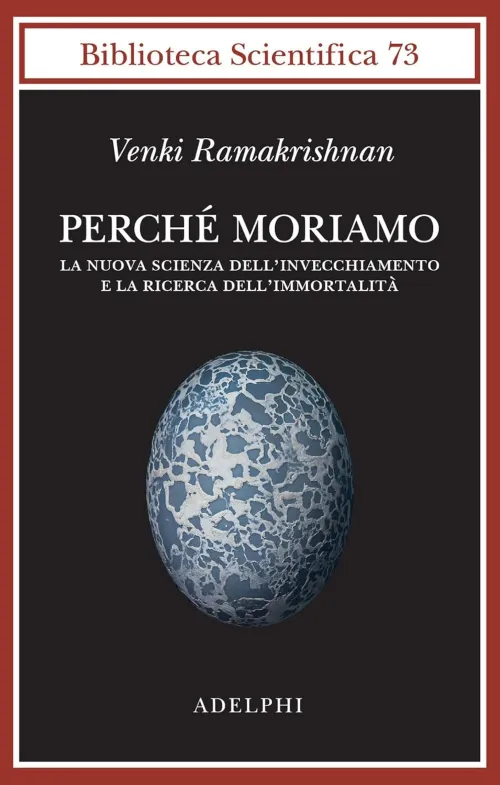Morire ci tocca?
Al momento della nostra morte, che cosa muore esattamente? La risposta dovrebbe essere semplice, almeno... ma se anche a voi, come a me, non è uscita di getto, se vi sta facendo pensare, se vi state interrogando sorprendentemente dubbiosi, beh, allora considerate l’opportunità di entrare in libreria e acquistare Perché moriamo. La nuova scienza dell’invecchiamento e la ricerca dell’immortalità, appena uscito per Adelphi a firma di Venki Ramakrishnan, premio Nobel per la chimica del 2009, con la traduzione di Maurizio Bruno. Perché… perché, in effetti, al momento della morte la maggior parte delle cellule del nostro corpo saranno ancora vive, tant’è che possiamo donare interi organi perfettamente funzionanti; e anche l’infinita colonia di batteri (migliaia di miliardi) che “ospitiamo”, ben più numerosi dell’insieme delle nostre cellule, continueranno la loro esistenza. E poi, quale sarebbe il momento della nostra morte? Quando il cuore smette di battere? Ma oggi, e non da oggi, l’arresto cardiaco può essere invertito; e pure sulla perdita delle funzioni cerebrali si può discutere, talvolta persino quelle possono essere ripristinate. Il che ci porta al guazzabuglio delle definizioni legali: “Una ragazza con diagnosi di morte cerebrale a Oakland, in California, veniva considerata viva in base agli standard del New Jersey, dove risiedeva la sua famiglia, la quale fece una petizione per ottenere che il suo corpo, con tutta l’apparecchiatura per tenerlo in vita artificialmente, venisse trasportato nel New Jersey, dove la ragazza morì alcuni anni dopo”. Le controversie sulla “brain death declaration”, infatti, non sono da meno di quelle che dovrebbero certificare il momento della nascita: sull’evidenza per cui esistiamo prima di emergere dal grembo materno discuterebbero in pochi: ma dal concepimento, invece? Dipende cosa s’intende: “dopo che uno spermatozoo è entrato in contatto con la superficie di una cellula uovo, c’è una finestra temporale durante la quale deve verificarsi una serie di eventi prima che venga messo in moto il programma genetico dell’ovulo fecondato. Successivamente, c’è una finestra temporale di più giorni durante la quale l’ovulo fecondato va incontro a una serie di divisioni, e l’embrione – ora chiamato blastocisti – deve impiantarsi nel rivestimento dell’utero. Più tardi ancora si forma l’abbozzo di un cuore, e solo molto tempo dopo, con lo sviluppo di un sistema nervoso e del suo cervello, il feto può avvertire dolore”.
Fa pensare la quotidiana ricerca di qualche significato per la nostra esistenza in vita, quando già solo definirne la nascita e la morte pone così tanti, non risolvibili interrogativi. “Noi pensiamo alla nascita e alla morte come a eventi subitanei – a un certo istante veniamo alla luce e a un altro cessiamo di esistere –, ma i confini della vita sono sfumati”. Non è così per tutto? Quando è il momento esatto in cui una città è nata o è sparita? E un impero, una civiltà, oggi una nazione?
È per cercare di mettere qualche punto fermo, che Venki Ramakrishnan ha scritto questo libro, senza alcun dubbio alla portata anche di lettori non specialisti. Quando diciamo che moriamo – avverte Ramakrishnan – “in realtà significa che smettiamo di funzionare come un tutto coerente: quando i nostri tessuti, i nostri organi non lavorano più insieme come unità, moriamo”. Per un accumulo progressivo di danni chimici alle molecole e cellule del nostro corpo. Non a caso, a Ramakrishnan torna in mente un passaggio di Fiesta di Hemingway, quando a un personaggio viene chiesto com’è che è andato in bancarotta. “A poco a poco e poi all’improvviso”. Capita così.

Di fatto, e conseguentemente, il testo di Ramakrishnan diventa una riflessione su un altro “perché”, perché invecchiamo, dove a parte l’introduzione, e gli ultimi due capitoli, l’undicesimo e il dodicesimo, più speculativi, ognuno dei dieci centrali riassume lo stato della ricerca e le diverse ipotesi. C’è quella “plaietropica”, per la quale l’invecchiamento di un organismo è un compromesso evolutivo tra longevità e maggiore possibilità di trasmettere i propri geni attraverso il successo riproduttivo: “l’idea è che un corpo usa e getta sia in grado di trasmettere i suoi geni prima di invecchiare e morire”. Si contempla l’alterativa tra vivere in fretta e morire giovani, come le farfalle che possono vivere anche solo una settimana, e in maggioranza meno di un mese (Rabindranath Tagore, citato dall’autore: “La farfalla non conta i mesi ma i momenti, e ha tempo a sufficienza”), o per superare i millenni come alcuni alberi di tasso in Gran Bretagna che sono su quella terra e su questa Terra da tremila anni, o magari coltivando una sorta di immortalità, come Turritopsis dohrnii, una medusa che quando subisce un danno fisico o una situazione di stress, si trasforma ritornando ad uno stadio precedente dello sviluppo e ricominciando la sua vita dall’inizio.
Se guardiamo ai mammiferi, in generale più grande è l’animale e più lunga è la sua vita (ma, all’interno delle specie, le razze più piccole generalmente vivono più a lungo di quelle più grandi), ciò in ragione della correlazione tra dimensioni e tasso metabolico, ovvero il ritmo al quale un animale brucia il carburante nella forma di cibo per ottenere l’energia di cui ha bisogno: la quantità totale di calorie bruciate in un’ora da un animale aumenta proporzionalmente meno della massa dell’animale stesso, seguendo la legge di Kleiber. Sarà un caso ma, dai criceti alle balene, i mammiferi di solito hanno lo stesso numero di battiti cardiaci nel corso della loro vita, 1,5 miliardi; e se per noi sapiens attualmente se ne contano quasi il doppio è perché la nostra aspettativa di vita, nell’ultimo secolo, è quasi raddoppiata; allo stesso modo, però, anche le automobili sono progettate per una vita media, calcolabile a più o meno 250mila chilometri, che corrispondono, guarda un po’, a 1,5 miliardi di giri dell’albero motore. Curiosità.
Vivere piano sembra essere un buon metodo per allungare la vita: è così per le tartarughe, il cui cuore batte ogni dieci secondi, lo è per lo storione beluga, lo squalo della Groenlandia e la balena artica. Per noi mammiferi umani, capaci di raddoppiare l’aspettativa di vita nonostante le raccomandazioni per una vita “slow” non sempre vengano seguite, ciò che ha fatto la differenza in questi ultimi cento anni, più che i progressi della medicina, è stata la sanità pubblica: condizioni igieniche e vaccini (con buona pace), che hanno ridotto drasticamente le malattie infettive; fertilizzanti chimici che hanno aumentato la produttività agricola in maniera considerevole (con buona pace anche in questo caso, ché se l’ampia disponibilità di cibo ai giorni nostri, nelle società opulente, ha portato a problemi di obesità, diabete, malattie cardiovascolari, non bisogna dimenticare che fino a un secolo fa, appunto, si lottava per avere abbastanza da mangiare); antibiotici, trasfusioni di sangue, sterilizzazione dell’acqua e degli alimenti tramite clorazione e pastorizzazione.

Nel proporre, molto spesso nel testo, la similitudine tra la morte di un individuo e quella di una città o di una società complessa, Ramakrishnan sottolinea come il fattore disgregante più fatale sia il caos, l’illegalità, la perdita di controllo, e di governo centrale. Qual è l’autorità essenziale che supervisiona le migliaia di attività di ogni singola cellula? La “cosa” che si avvicina di più all’idea di un centro di controllo sono i nostri geni contenuti nel DNA. “Indiscutibilmente il DNA è il centro di regolamentazione del programma complessivo della cellula, ma io penso che la cellula sia più una democrazia che una dittatura. Proprio come un governo ideale non è autocratico ma risponde alle esigenze della popolazione, il DNA non detta l’intero processo. Piuttosto, sono le condizioni della cellula e il suo ambiente a decidere quali parti del DNA vengano utilizzate, nonché con quale frequenza e in quali circostanze”. Il danneggiamento del DNA e la possibilità della sua endogena riparazione giocano un ruolo dirimente nel procedere e/o nel rallentamento dell’invecchiamento. Al centro della risposta al danno del DNA c’è una proteina p53 (o soppressore tumorale P53) non a caso chiamata “il guardiano del genoma”: noi esseri umani ne ereditiamo una copia da ciascun genitore, il fatto che gli elefanti ne abbiano a disposizione 20 copie non è irrilevante, come pare significativo che le specie più longeve, come le balene, le tartarughe giganti e gli altri mammiferi di cui abbiamo accennato, presentino insolite variazioni nel numero e nel tipo di geni oncosoppressori. In sostanza e in generale, sono i geni a contenere il programma per controllare il complesso processo della vita, ma il programma genetico, che pure si modifica all’istante per adattarsi in ogni momento alle necessità dell’organismo, può essere alterato dai danni che si accumulano con l’età. Le proteine svolgono molteplici compiti, “come i musicisti di una grande orchestra sinfonica”, sicché capita che qualcosa “stoni” o, peggio, si perda il ritmo. Nel procedere dei capitoli si incontrano molte delle circostanze per cui, a causa dell’invecchiamento, i sistemi di controllo non funzionano a dovere: cancro o Alzheimer ne rappresentano alcune delle conseguenze. Ipotesi per contenere la “perdita di controllo” si sono testate negli ultimi decenni. Interessante il capitolo 7°, Meno e più, sul tema della restrizione calorica che viene proposta e raccomandata, in vari modi, come modello per ritardare l’insorgenza di diverse malattie legate all’invecchiamento. Ed è tutto molto interessante, benché, argomenta Ramakrishnan, evolutivamente non siamo predisposti per la frugalità. È verissimo che un semplice correttivo nello stile di vita – la limitazione dell’approccio calorico e una sana alimentazione – può essere molto efficace nel rallentare il decadimento dell’organismo; e grandissimo è l’entusiasmo per la possibile sintesi di farmaci che, aggirando i meccanismi degenerativi, diano gli stessi benefici della restrizione calorica. Ma è altrettanto vero che prodotti ampiamente commercializzati come integratori anti-invecchiamento, presentano benefici più presunti che reali. C’è ancora molto lavoro da fare per stabilire efficacia e sicurezza di nuovi approcci (vie di segnalazione come TOR e IGF-1; composti quali la rapamicina, o la metformina, la ricerca sul resveratolo e la curcumina), sicché il business anti-invecchiamento è indubbiamente tra i più promettenti. Il resto consegue.
Necessario il capitolo sul genoma mitocondriale, curiosissimo (il decimo) quello sui “Dolori, malesseri e sangue di vampiro”. Perché non sono pochi i super ricchissimi che coltivano il sogno di una vita senza fine, magari bevendo “sangue giovane”: del resto, con i topi della coppia di ricercatori Irina e Michael Conboy, della Stanford University, funziona! Ça va sans dire, sono nate aziende che offrono plasma da donatori di età tra i sedici e i venticinque anni. Altre sono (si dicono) specializzate in crioconservazione, o meglio, in “vitrificazione”. L’Alcor Life Extension Foundation offre la crioconservazione di tutto il corpo, alla modica cifra di 200mila dollari: si presumono sconti per i transumanisti ai quali basta conservare solo il cervello. Che siano “folli o visionari” (al titolo del capitolo 11), sarebbe utile per loro, e per tutti noi, prendere visione della dichiarazione di principio firmata già nel 2002 da un gruppo di 51 eminenti gerontologi, i cui punti chiave sono riassunti a pagina 247: leggere per capire. E anche sulla effettiva efficacia dei nutraceutici, o sul ruolo che, negli ultimi tempi, hanno assunto i tecno-guru miliardari della Silicon Valley, seguendo il loro motto, move fast and break things, e l’idea che l’invecchiamento sia solo un altro problema ingegneristico da risolvere “hackerando” il codice della vita: errore.
Più dal lato della visione che della follia, sembrano schierarsi alcuni imprenditori e non pochi ricercatori che cautamente (forse!) dichiarano: “Noi desideriamo che tutti muoiano giovani – dopo molto, molto tempo”. Che poi, a parere di Ramakrishnan, alcuni scienziati si siano entusiasmati un po’ troppo facilmente, ha a che fare con ciò che pensava Upton Sinclar: “È difficile far capire qualcosa a qualcuno quando il suo stipendio dipende dal fatto che non lo capisce”.
Dovremmo vivere per sempre? Si chiede l’autore. “Se aumentassimo la durata della vita senza comprimere la morbilità, non faremmo che peggiorare i problemi esistenti”. Forse la sfida è proprio quella di morire giovani, dopo molto tempo. Ma senza dimenticare che sempre, dappertutto, e in ogni tempo, i progressi della medicina hanno aumentato le diseguaglianze. “C’è il serio rischio che si crei una divisione permanente tra due categorie di esseri umani: coloro che godono di una vita molto più lunga e in buona salute, e tutti gli altri”. Un risultato che nessuna scienza, nessuna ricerca, nessun ricercatore dovrebbe considerare un progresso.
Leggi anche
Pino Donghi, La macchina del gene / Venki Ramakrishnan, peripezie di un premio Nobel